Un fondatore che lascia l’abito
Un carisma più forte del fondatore
DOSSIER: Padre Stefano Maria Manelli, l’uomo che aveva dato vita ai Francescani dell’Immacolata, non è più frate: ha ottenuto la dispensa dai voti religiosi. La notizia, notificata il 12 settembre 2025 dal Dicastero per la Vita Consacrata, segna la fine di una vicenda che per oltre trent’anni ha attraversato la vita ecclesiale italiana e internazionale, tra entusiasmi iniziali, accuse di abusi, commissariamento pontificio e contenziosi giudiziari.
La sua parabola non è solo cronaca interna agli ordini religiosi: è un caso emblematico che interroga il modo in cui la Chiesa custodisce i carismi, corregge le derive e difende i consacrati da forme di abuso spirituale. Una vicenda che mostra anche i rischi della “santoneria” cattolica, quando la fede rischia di essere sostituita dal culto di un leader carismatico.
È un paradosso ecclesiale: chi si era proposto come difensore della radicalità evangelica ha abbandonato proprio quella forma di vita che aveva innalzato a vessillo. Forse si tratta dell’ennesimo tentativo di sottrarsi a ogni forma di autorità, una volta scaduto il tempo di esclaustrazione concessogli tre anni fa dal nuovo governo.
Dall’entusiasmo al rigore
La storia dei Francescani dell’Immacolata nasce negli anni ’90, quando i padri Stefano Manelli e Gabriele Pellettieri avviarono un nuovo ramo francescano ispirato a san Massimiliano Kolbe. L’intuizione iniziale appariva promettente: vocazioni in crescita, case aperte in Italia e all’estero, apostolato mariano.
Le radici risalivano però al 1970, quando i due religiosi avevano scelto il convento irpino di Frigento per inaugurare una forma di vita più austera all’interno dei Frati Minori Conventuali. Dopo vent’anni, Manelli entrò in rottura anche con il suo Ordine di appartenenza. All’epoca, tuttavia, il contesto ecclesiale e sociale era diverso e più favorevole a esperienze di nuove fondazioni.
Durante il pontificato di Giovanni Paolo II, l’istituto ottenne rapidamente il riconoscimento di diritto pontificio. Ma l’entusiasmo iniziale si trasformò presto in irrigidimento. Secondo la visita apostolica, il governo personale e accentrato di Manelli si protrasse per venticinque anni, in contrasto con lo spirito di rinnovamento richiesto dal can. 624 del Codice di Diritto Canonico.
La figura del fondatore divenne progressivamente carismatica e ingombrante. Per molti frati, suore e laici, Manelli non era soltanto un padre, ma un uomo percepito come taumaturgo, con rivelazioni e profezie. Una deriva che diversi osservatori hanno definito “santoneria”, più che autentica testimonianza.
La Chiesa conosce bene questo rischio: quando il fondatore diventa idolo, il carisma si ammala. Papa Francesco lo ha ricordato con parole nette: «Non c’è carisma che valga al di fuori dell’unità della Chiesa. Quando il carisma si isola, si ammala, muore».
Una mariologia segnata dalla paura
Il limite più grave, sul piano teologico, fu una mariologia segnata da impostazioni barocche e devozionali, più polemica che accademica, spesso critica verso la teologia contemporanea anche quando pienamente aderente al Magistero.
L’esempio più lampante riguarda Fatima: là dove la Chiesa legge un messaggio di speranza e di conversione, Manelli e i suoi proponevano spesso scenari di catastrofi e castighi. Numerose testimonianze riportano come si sia generata così una spiritualità della paura, che deformava il volto della Madre di Dio.
Eppure, il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, presenta Maria come «segno di sicura speranza e di consolazione» per il popolo di Dio. Il contrasto è evidente.
A ciò si aggiunse l’istituzione di un centro di studi teologici autonomo, privo di riconoscimenti accademici e di strumenti adeguati: un percorso autoreferenziale che formava più alla fedeltà al fondatore che al servizio della Chiesa.
Abusi e clericalismo
Secondo la Santa Sede, accanto ai limiti teologici emersero pratiche di governo problematiche che segnarono sia i frati che le suore:
- autarchia: case aperte e chiuse in tempi brevissimi, senza discernimento né stabilità, in violazione del can. 609;
- formazione insufficiente: studi ridotti e autoreferenziali, scollegati dalle università pontificie;
- clericalismo: spirito di dominio nei rapporti tra frati, e nei confronti delle religiose e dei laici;
- abusi spirituali: manipolazioni di coscienza, voto di obbedienza usato come strumento di controllo;
- divisioni: comunità educate al sospetto e alla contrapposizione, più che al discernimento e alla libertà evangelica.
Il documento Il dono della fedeltà, la gioia della perseveranza della CIVCSVA lo afferma con chiarezza: «Quando l’autorità diventa dominio, quando il discernimento si riduce a imposizione, allora la vita consacrata si snatura e diventa strumento di oppressione».
L’intervento della Chiesa
Nel 2012 partì la visita apostolica. L’anno seguente arrivò il commissariamento pontificio. Non una punizione, ma un atto di cura: la Chiesa cercava di riportare l’istituto alla comunione e alla fedeltà al carisma originario.
La resistenza del fondatore fu durissima: ricorsi, campagne mediatiche, opposizione all’autorità ecclesiale. Inizialmente appoggiato da settori tradizionalisti, Manelli intraprese una battaglia che con il tempo lo isolò persino dai suoi sostenitori. Da una reciproca influenza all’essere mollato, nella logica dell’opportunismo più mondano.
Il primo commissario apostolico, P. Fidenzio Volpi OFMCapp., ne uscì logorato, fino a morire per le conseguenze di un ictus nel 2015. Nel 2021 la morte imprevista raggiunse anche il suo successore, don Sabino Ardito. Il canonista salesiano dovette affrontare la stessa ostinazione: dopo vani tentativi di mediazione, si vide costretto a comminargli la sospensione a divinis.
Fino al Capitolo generale del 2022, Manelli cercò di imporre la sua agenda, ma senza successo: la maggioranza dell’Istituto scelse la Chiesa, non il fondatore. Alla fine, la richiesta di dispensa dai voti segnò il distacco definitivo. Non l’obbedienza di Francesco o di Padre Pio, ma il rifiuto di sottoporsi a un correttivo.
Fiancheggiatori e complicità
Tre cerchi concentrici circondarono Manelli.
- Dentro l’Istituto: alcuni frati e suore che trasformarono l’obbedienza in adesione cieca, replicando su scala minore il suo stile di governo.
- I laici: gruppi devoti e associazioni che, oltre al sostegno spirituale, garantirono consulenze giuridico-finanziarie, nonché coperture economiche e patrimoniali.
- I media tradizionalisti: giornalisti e opinionisti che costruirono la narrazione del “fondatore perseguitato”, alimentando una battaglia ideologica contro il Vaticano e Papa Francesco.
In tutte queste forme di sostegno emerge un tratto comune: la complicità spirituale. Invece di aiutare il fondatore a riconoscere i suoi limiti, i fiancheggiatori ne rafforzarono l’isolamento. Papa Francesco lo ha detto con chiarezza: «Chi copre un abuso è complice. Non è neutrale, ma corresponsabile».
Ombre e ferite
Le conseguenze sono state pesanti.
- Frati e suore disorientati: molti hanno lasciato la vita religiosa, altri sono rimasti sospesi, incapaci di trovare una collocazione ecclesiale.
- Comunità divise: tra fedeltà al Papa e culto del fondatore.
- Patrimonio conteso: beni e immobili trascinati in tribunali, con grave danno di credibilità.
- Famiglie spirituali devastate: segnate da sospetti, accuse reciproche e ferite difficili da sanare.
Ma il danno più grave è stato di ordine spirituale: vocazioni tradite, coscienze manipolate, giovani attratti da un ideale radicale e poi abbandonati a una solitudine amara.
Precedenti storici e casi recenti
Non è la prima volta che la storia francescana conosce deviazioni dei fondatori. Matteo da Bascio, iniziatore dei Cappuccini, visse tensioni e si distaccò. Bernardino Ochino, generale dell’Ordine, cadde nell’eresia protestante. Eppure i Cappuccini diventarono gloriosi, perché seppero riferirsi non agli uomini, ma a san Francesco e alla Chiesa.
A tutto questo si aggiunge un elemento simbolico: padre Stefano aveva spesso richiamato un presunto legame speciale della sua famiglia con san Pio da Pietrelcina, presentandosi come suo “figlio spirituale prediletto”. Ma, a differenza del santo cappuccino, non ne ha imitato l’umiltà, né l’obbedienza.
Lo stesso dinamismo si ripete oggi con altri fondatori radiati: Marcial Maciel (Legionari di Cristo), Luis Fernando Figari (Sodalitium), Marie-Dominique Philippe (Communauté Saint-Jean), fino ad altri movimenti minori come il Verbo Incarnato o l’Aula Regia. Tutti nati con la pretesa di ristabilire l’“ortodossia della dottrina”, ma segnalati per forme di abuso di potere, clericalismo e manipolazione dei fedeli.
Il filo rosso è sempre lo stesso: un fondatore che si presenta come garante di ortodossia finisce per travolgere il carisma con la propria personalità. Dal desiderio di riforma al culto del leader, dal carisma all’ideologia.
Una rinascita possibile
Oggi l’Istituto, spogliato di beni e ridimensionato, conosce una nuova stagione: vocazioni giovani anche in Europa, formazione accademica solida, nuove opere di apostolato sobrie ma feconde.
Vita Consecrata lo ricorda: «La vita consacrata rimane segno di speranza, proprio quando accetta la via della croce». È la croce che i Francescani dell’Immacolata hanno portato, ma che si rivela seme di resurrezione.
La lezione di una parabola
La parabola di padre Stefano M. Manelli lascia una triplice lezione:
- Il carisma senza obbedienza diventa ideologia.
- La mariologia senza speranza diventa spiritualità segnata dalla paura.
- Il governo senza discernimento diventa abuso.
Ma insegna anche che la Chiesa sa correggere e purificare. Nonostante le ferite, la maggioranza dei frati e delle suore ha scelto la fedeltà al Papa e non al fondatore. In questa scelta sta la fecondità: non nell’illusione di falsi profeti, ma nella comunione con Pietro, dove il carisma fiorisce e porta frutto.
Uno dei frati più anziani ha testimoniato che P. Stefano Manelli gli rivelò, in tempi non sospetti, il proposito che avrebbe distrutto l’Istituto e lui stesso ne sarebbe uscito se i Frati non avessero eseguito quello che voleva.
Dio ha disposto diversamente, tranne che nella seconda parte.
Alla fine, ciò che resta non è l’ombra di un uomo, ma la luce di un carisma custodito e rigenerato dalla Chiesa. Non servono “martiri di sé stessi”, alimentati da narrazioni ideologiche, ma figli obbedienti, come Francesco e Pio: uomini che hanno testimoniato la verità non con la ribellione, ma con l’umiltà, la fedeltà e la pazienza.
Questa è la santità che la Chiesa attende e che il mondo riconosce.


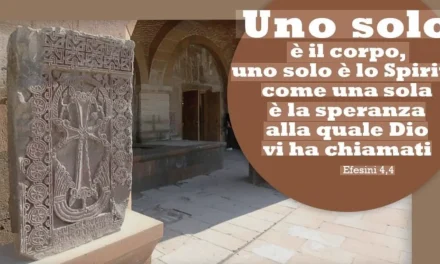











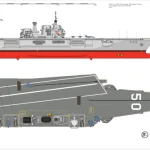




Questo prete continuerà a far male ai suoi figli e alle sue figlie.
La sua uscita è il punto di arrivo di una storia fatta di tensioni, inchieste, abusi di governo, contenziosi patrimoniali. La Chiesa, in continuità tra Benedetto XVI e Francesco, ha scelto di difendere i religiosi e la credibilità dell’Istituto.
Oggi resta una lezione preziosa: i carismi non appartengono ai fondatori, ma alla Chiesa. Nessuno, neppure chi ha dato vita a un’opera, può pretendere di identificarla con sé stesso. La fedeltà non si misura sull’idolatria di una figura, ma sulla capacità di custodire la verità del Vangelo nella trasparenza, nella fraternità e nell’obbedienza ecclesiale.
Cos’ e pazz! Chissà se lo vedremo al Festival di Sanremo!
La vicenda Manelli resta una lezione preziosa per tutta la vita consacrata: la fedeltà non si misura sull’idolatria di un uomo, ma sulla capacità di vivere la trasparenza, la fraternità concreta, l’obbedienza ecclesiale. Solo così i frutti di un carisma restano buoni e duraturi.
San Francesco d’Assisi, davanti alle tensioni del suo Ordine, non esitò a consegnarlo nelle mani della Chiesa, accettando correzioni e persino modifiche alla sua Regola pur di restare figlio obbediente. Non si aggrappò al potere, non identificò l’opera con sé stesso: scelse la via dell’umiltà e della comunione. È questa la vera eredità francescana, ed è qui che la Chiesa invita anche oggi a guardare.
Molti commenti hanno letto questa uscita come una sorta di “rinnegamento doloroso”, quasi un padre che rifiuta un figlio. Ma la realtà è diversa. In diritto canonico, gli istituti religiosi non appartengono al fondatore: appartengono alla Chiesa. Il carisma, cioè il dono spirituale che sostiene una comunità, non si identifica con la persona che lo ha avviato. Per questo la Chiesa può e deve intervenire quando emergono irregolarità o abusi, come avvenne con il commissariamento del 2013.
Attribuire la responsabilità di tutto a Papa Francesco è fuorviante. La decisione fu del Dicastero per la Vita Consacrata, sulla base di denunce interne da parte di frati e suore che avevano vissuto da vicino problemi di governo, imposizioni ideologiche, scelte patrimoniali discutibili. Il Papa ratificò, come avviene in tutti i casi simili. Non fu una crociata personale contro Manelli, ma un atto di tutela.
Avevo già letto il comunicato ufficiale dei Frati Francescani dell’Immacolata. Adesso leggo da un blogger di Torino che i frati non lo hanno ringraziato? E di cosa! Nel notificare la dispensa, non ha avuto bisogno di parole di ringraziamento solenni: la storia è più grande delle persone. La vera riconoscenza verso un iniziatore sta nel custodire l’opera perché rimanga fedele al Vangelo e libera da derive personali.
La vicenda Manelli resta una lezione preziosa per tutta la vita consacrata: la fedeltà non si misura sull’idolatria di un uomo, ma sulla capacità di vivere la trasparenza, la fraternità concreta, l’obbedienza ecclesiale. Solo così i frutti di un carisma restano buoni e duraturi.
La dispensa dai voti religiosi concessa a padre Stefano M. Manelli, da lui stesso richiesta, non è una formalità: è il sigillo finale di una vicenda che da anni ha segnato la vita dei Frati Francescani dell’Immacolata e che ora si chiude con una separazione definitiva. Il fondatore ha scelto di abbandonare l’Istituto e di entrare nel clero secolare della diocesi di Sanremo-Ventimiglia. È un epilogo che parla da sé. Non un colpo di scena isolato, ma il punto d’arrivo di una lunga storia di tensioni, di denunce interne, di inchieste ecclesiali, di accuse di abusi di governo e di contenziosi patrimoniali mai chiariti del tutto. Ridurre questa traiettoria a un complotto o a una persecuzione è semplicemente falso: la Chiesa ha agito, come ha il dovere di fare, per tutelare la vita religiosa e la credibilità di un carisma che rischiava di essere snaturato.
Almeno così potrà chiedere a Mons. Suetta, Vescovo di San Remo di togliergli la sospensione a divinis e celebrare la S. Messa lecitamente.
Ha aspettato fino alla fine per distruggere l’istituto. Voleva fare uscire frati e suore e in parte c’è riuscito. Adesso è uscito lui credendo e sperando che altri lo seguano. Una malattia.
Un’uscita di scena da avanspettacolo. Preghiamo per lui.
Ho conosciuto il padre da religiosa. All’inizio si mostrava riflessivo, attento. Gli mancava solo l’aureola. Tutte me ne parlavano come di un santo che parlava con la Madonna ed era protetto da Padre Pio. Col tempo ho visto tanta incoerenza, aggressività, sete di potere, golosità, particolarismi soprattutto verso le nipoti. Poco chiaro il rapporto con la Madre Generale che poi uscì e so che ora stia in Inghilterra e forse non è neanche più cattolica. È onesto però dire che siamo state tutte complici. Abbiamo nutrito noi il mostro con applausi e adulazioni che immagino continuino fino ad oggi. Non è stato facile per me riprendere la mia vita in mano, ma ci sono riuscita pur conservando delle ferite dalle cicatrici indelebili, sia per il Manelli che per il comportamento delle superiore da lui sostenute.
Concordo con la religiosa che ha scritto sul fatto che gli abbiamo dato troppa corda. Quando sono stato in convento notai qualcosa che in lui non andava… Dai frati non ho avuto problemi, ma sono andato via dopo pochi giorni di esperienza e un paio di colloqui con lui. Non mi meraviglio che si sia arrivato a questo.
No Angelo, io non mi aspettavo questa fine e anche questa ribellione da parte sua…
Chissà cosa gli è preso.
Preghiamo per don Stefano.