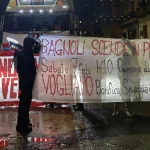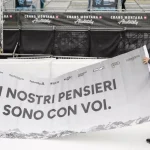La recente rielezione di Alexander Lukashenko in Bielorussia ha suscitato prevedibili critiche internazionali, con molti osservatori che continuano a definirlo un “pupazzo di Putin”. La sua stretta alleanza con Mosca e il ruolo della Bielorussia come partner strategico della Russia nella guerra in Ucraina lo rendono un simbolo dell’influenza russa nell’Europa orientale. Tuttavia, l’atteggiamento dell’Unione Europea solleva questioni su un possibile doppio standard, dato che la stessa Ue ha recentemente contestato le elezioni in paesi come la Romania e la Georgia.
Un leader nell’ombra di Mosca
Lukashenko, al potere dal 1994, ha rafforzato la sua posizione politica grazie al sostegno di Vladimir Putin, soprattutto dopo le proteste post-elettorali del 2020. Negli ultimi anni, la Bielorussia è diventata un’estensione delle politiche di Mosca, ospitando truppe russe e offrendo il proprio territorio per operazioni militari nella guerra in Ucraina.
Sebbene l’immagine di Lukashenko come mero esecutore delle direttive del Cremlino sia largamente accettata, il leader bielorusso ha dimostrato più volte di saper manipolare le dinamiche geopolitiche per consolidare il suo potere, mantenendo una parziale autonomia per evitare una totale subordinazione.
Le contestazioni europee: Romania e Georgia sotto i riflettori
La posizione dell’Unione Europea sulla rielezione di Lukashenko si scontra con il contesto di altre elezioni contestate nell’area europea. Recentemente, l’Ue ha criticato i processi elettorali in Romania e Georgia, sottolineando irregolarità che mettono in dubbio la trasparenza e l’equità del voto.
In Romania, le accuse si sono concentrate sull’influenza politica nel sistema giudiziario e sulla mancanza di riforme democratiche richieste dall’Ue, mentre in Georgia l’Ue ha espresso preoccupazione per una crescente deriva autoritaria, legata al controllo del partito al governo, “Sogno Georgiano”, e alle tensioni con l’opposizione. La contestazione europea, però, è stata vista da alcuni come un’ingerenza nei processi interni di due paesi che stanno cercando un equilibrio tra la loro sovranità e le pressioni internazionali.
La Bielorussia e il dilemma europeo
La situazione bielorussa offre un contrasto netto. L’Ue ha ripetutamente condannato le elezioni in Bielorussia come non libere e non eque, ma si è trovata senza strumenti efficaci per influenzare il corso degli eventi. Le sanzioni economiche imposte a Minsk hanno avuto un effetto limitato, spingendo Lukashenko ancor più verso Mosca. Tuttavia, la fermezza europea nei confronti di Lukashenko rischia di essere interpretata come incoerente, dato che in Romania e Georgia, entrambe vicine all’orbita occidentale, l’Ue ha agito come osservatore critico ma senza assumere posizioni drastiche.
Un paradosso geopolitico
Il caso della Bielorussia mette in luce un paradosso: l’Europa critica con forza l’influenza russa su Lukashenko, ma le sue stesse azioni nei confronti di altri paesi sollevano accuse di doppio standard. Se da un lato è comprensibile che l’Ue voglia sostenere la democrazia e i diritti umani, dall’altro lato l’applicazione selettiva di questi principi rischia di minare la sua credibilità a livello internazionale.
In un contesto sempre più polarizzato, è evidente che ogni intervento dell’Ue – o la sua assenza – sarà visto attraverso il prisma delle tensioni geopolitiche con Mosca.
La rielezione di Alexander Lukashenko è un promemoria delle difficoltà di promuovere la democrazia in un ambiente geopolitico complesso come quello dell’Europa orientale. Mentre l’Ue cerca di mantenere un equilibrio tra principi democratici e interessi strategici, la Bielorussia rappresenta un nodo cruciale per le relazioni con la Russia e la stabilità regionale.
In definitiva, l’Unione Europea si trova di fronte a una sfida strategica: come sostenere la democrazia in paesi come la Bielorussia senza compromettere la propria coerenza e legittimità nelle questioni internazionali. La questione rimane aperta, ma una cosa è certa: i prossimi anni richiederanno decisioni politiche e diplomatiche più incisive per risolvere i paradossi che caratterizzano l’azione europea.