Raccogliamo la testimonianza di alcuni cristiani palestinesi che malgrado l’esodo tengono duro nel voler rimanere nella loro terra.
Diverse centinaia di fedeli si sono rifugiati in due chiese dove hanno conservato ciò che è necessario per resistere e non essere costretti a lasciare la Striscia. Uno dei due luoghi è stato colpito da un attacco israeliano.
Mentre decine di migliaia di palestinesi della Striscia fuggon a sud dell’enclave seguendo l’ultimatum dell’esercito israeliano nella speranza di allontanarsi dai bombardamenti, un gruppo di cristiani rifugiati nella chiesa cattolica di Gaza City celebrava il battesimo di un bambino di 11 mesi di nome Daniel.
Questa immagine, quasi irreale, vuole essere un messaggio al mondo: “Noi scegliamo la vita, nonostante siamo circondati dalla morte”.
George Antone, responsabile della Caritas-Gerusalemme nella Striscia, si ha un nodo alla gola quando ricorda quel momento.
È esausto e terrorizzato, ammette in una conversazione telefonica.
“Siamo morti di paura. La maggior parte pensa che non usciremo vivi dalla chiesa, che ci bombarderanno. Ma bisogna andare avanti, bisogna essere forti. Siamo a casa di Gesù, siamo nelle sue mani”, dice dalla chiesa della Sacra Famiglia di Gaza City.
Tra gli oltre due milioni di abitanti della Striscia vive una minuscola comunità cristiana di circa 1.000 persone che si sta estinguendo nel corso degli anni, soprattutto da quando il movimento islamista Hamas ha preso il controllo dell’enclave nel 2007.
Alla mancanza di libertà e all’isolamento che domina la vita dei gazei a causa del blocco che Israele impone da 16 anni, si aggiunge, nel caso dei cristiani, un’esclusione lavorativa e sociale guidata da settori legati a Hamas e ad altri movimenti islamisti radicali presenti anche nella zona.
“Purtroppo, abbiamo abbastanza esperienza nelle guerre e quando abbiamo visto l’attacco di Hamas il 7 ottobre, sapevamo che ci sarebbe stata un’enorme risposta militare israeliana.
Mia moglie, le mie tre figlie ed io abbiamo deciso di rifugiarci in chiesa.
Lentamente, arrivavano più persone che avevano paura nelle loro case o che avevano perso tutto. Ora siamo 500 cristiani qui”, spiega, lentamente, Antone, 42 anni.
Al gruppo si è unito un sacerdote egiziano, padre Yussef, e circa una decina di suore di diverse congregazioni.
Tutti sanno bene che sono a rischio enorme e anche i più ottimisti si sono sentiti svenire giovedì, quando la chiesa ortodossa, situata a pochi metri dalla loro, è stata colpita in un bombardamento in cui sono morte almeno 18 persone, delle oltre 350 che si rifugiavano all’interno.
Consapevole di vivere in una polveriera, la comunità cristiana della Striscia ha creato qualche mese fa un comitato di gestione per le crisi future e ha iniziato a prepararsi per i momenti difficili, spiega Antone.
“Abbiamo iniziato a conservare materassi, coperte, prodotti per l’igiene, carburante e cibo non deperibile, a preparare generatori e abbiamo visto come avremmo potuto comprare rapidamente acqua e altri generi alimentari in caso di emergenza.
Viviamo qui e conosciamo la situazione. Temevamo che sarebbe successo qualcosa perché a Gaza la violenza è ciclica, anche se questo ha superato le nostre peggiori previsioni”, riconosce.
Quando l’esercito israeliano ha avvertito la popolazione civile che doveva spostarsi nella zona meridionale dell’enclave per preservare la vita, la stragrande maggioranza delle famiglie cristiane ha deciso di non muoversi dalla chiesa.
“In questo momento, possiamo resistere fino a due mesi qui dentro. L’idea è di garantire la sopravvivenza della comunità cristiana di Gaza quando la guerra sarà finita. Non vogliamo essere costretti a lasciare qui, il nostro posto è a Gaza”, spiega Antone, che è nato in una famiglia di rifugiati palestinesi in Libano ed è tornato nella Striscia nel 1994, incoraggiato dall’ottimismo generato dagli accordi di pace di Oslo e con la speranza di partecipare alla costruzione di uno stato palestinese.
“Mi dispiace, siamo in piena evacuazione delle persone della chiesa ortodossa. Dovremo parlare più tardi”, risponde al telefono, agitata, Nisreen Antone, moglie di George e responsabile dei progetti del Patriarcato di Gerusalemme a Gaza, ore dopo il bombardamento del tempio ortodosso di San Porfirio, il più antico di Gaza. Non sappiamo quanti morti ci sono stati, pensiamo che ci siano ancora persone sotto le macerie. Non ci sono parole per esprimere come ci sentiamo oggi”, aggiunge la donna.
Ore dopo, sono stati sepolti 18 cristiani morti in questo bombardamento.
Un totale di 40 sopravvissuti e diverse persone ferite sono state ospitate nella chiesa cattolica, dove ci sono medici e infermieri tra i rifugiati.
La famiglia Antone insiste sul fatto che le autorità ecclesiastiche a Gerusalemme hanno informato l’esercito israeliano che le chiese e le loro istituzioni associate, come le scuole cattoliche, sono rifugio di centinaia di persone, persone di pace che non hanno nulla a che fare con questo conflitto.
SIAMO TUTTI PALESTINESI
“Ma siamo tutti palestinesi, non c’è differenza tra i palestinesi musulmani e noi. Non siamo un’eccezione e siamo permanentemente in pericolo. Cerchiamo solo di sopravvivere, ma non sappiamo cosa succederà, cosa ci riservano i giorni a venire”, esprime, con angoscia, George Antone.
Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme ha denunciato duramente questo attacco e ha sottolineato che prendere una chiesa come bersaglio militare, quando sta anche “prestando rifugio a cittadini innocenti” che hanno perso le loro case, “è un crimine di guerra che non può essere ignorato”. Un portavoce dell’esercito israeliano ha detto all’agenzia Reuters che i suoi aerei da combattimento hanno attaccato un “posto di comando di un’organizzazione terroristica” e “un muro di una chiesa nella zona è stato danneggiato” e ha riferito che “l’incidente è in fase di revisione”.
UN FRAGILE EQUILIBRIO
Da anni, i cristiani di Gaza si muovono in un fragile equilibrio tra le autorità islamiste della Striscia, il dialogo con Israele e la conservazione dei loro costumi. Ci sono stati momenti in cui la chiesa e i suoi fedeli, facilmente identificabili dai loro cognomi e dall’aspetto, specialmente le donne, sono stati oggetto di minacce e di alcune aggressioni.
In passato, i cristiani hanno anche ricoperto posizioni importanti nel governo, nelle università e negli organismi palestinesi, ma sono gradualmente scomparsi dalla vita pubblica di Gaza e nel migliore dei casi lavorano in entità cattoliche come la Caritas o qualche ONG.
A differenza delle grandi famiglie cristiane della Cisgiordania, spesso influenti, senza difficoltà finanziarie e ben integrate nella società, a Gaza essere cristiani significa affrontare un percorso complicato e quotidiano di ostacoli.
Questo fa sì che molti abbiano fatto le valigie. Nel 2007, c’erano circa 7.000 cristiani nella Striscia, sette volte di più di adesso. In tutti i territori palestinesi, la comunità non raggiunge il 2% della popolazione. All’interno della comunità cristiana di Gaza, i cattolici non superano i 130.
La vita quotidiana all’interno della chiesa della Sagrada Familia è perfettamente organizzata per scacciare la sensazione di caos e soffocare la paura. Due messe, una al mattino e una al pomeriggio, preghiera del rosario, momenti per cucinare e pulire…
“Non usciamo a malapena perché questo significa rischiare la nostra vita. Solo se è necessario procurarsi qualche medicina che non abbiamo o assistere qualcuno che è nelle nostre scuole, dove abbiamo ricevuto alcune famiglie musulmane”, spiega Antone.
Quando c’è una minaccia di bombardamento nelle vicinanze, i responsabili della sicurezza all’interno del tempio organizzano rapidamente i presenti, li aiutano a spostarsi in uno dei rifugi che sono stati allestiti in aree più sicure della chiesa, dove c’è anche acqua e cibo, e si occupano dei bambini, degli anziani e dei disabili del gruppo.
Per George Antone, uno dei pochi momenti di pace in questi giorni sono state le tre chiamate che Papa Francesco ha fatto: “Si è interessato alla comunità, a come stavamo vivendo all’interno della chiesa e ci ha augurato di poter tornare presto nelle nostre case”. Speriamo.




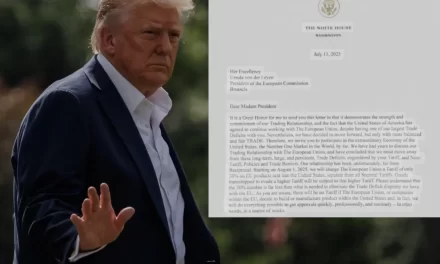









Mi sono commossa per questa testimonianza. Sono povera gente. Dove potrebbero andare. Che questo massacro cessi! Preghiamo il Signore.