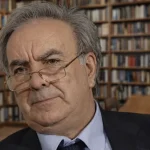C’è un’Italia che vive ogni giorno senza essere riconosciuta. Un’Italia che abita le nostre città, raccoglie i frutti delle nostre campagne, vince le nostre medaglie, ma resta invisibile. È l’Italia dei volti non bianchi, dei lavoratori e delle lavoratrici sfruttati, dei giovani che sono italiani in tutto ma non sulla carta d’identità, degli sportivi applauditi solo finché non parlano, non pensano, non reclamano. È un’Italia reale ma non rappresentata, sopportata ma non accolta, vissuta ma non ascoltata.
Eppure la politica, quella che dovrebbe interpretare la realtà e trasformarla, sembra sorda. Cieca, forse volutamente. Non coglie — o finge di non cogliere — che il razzismo non è un accidente morale, una maleducazione da condannare con un tweet e dimenticare subito dopo. È una struttura. Un dispositivo. Una forma di potere che si intreccia con le logiche economiche del capitalismo e con le storie rimosse del colonialismo. Una forma di dominio che divide la classe per governarla meglio.
In questo contesto, la riedizione italiana di Cultura, razza, potere di Stuart Hall — a dieci anni dalla sua morte — non è solo un omaggio a uno dei pensatori più lucidi del nostro tempo. È una necessità politica. È un invito a guardare in faccia la realtà e a dotarsi di strumenti per comprenderla.
Stuart Hall, intellettuale nero caraibico cresciuto nel Regno Unito, ha dedicato la sua vita a svelare i meccanismi culturali del potere, a decostruire il razzismo come elemento strutturale e non accidentale, a pensare la diaspora come esperienza di soggettivazione e non di perdita. E ha fatto tutto questo dialogando con Antonio Gramsci, facendo incontrare il pensiero marxista con la realtà postcoloniale, la lotta di classe con la lotta culturale.
Chi controlla la rappresentazione, controlla l’immaginario.
Stuart Hall
Chi controlla l’immaginario, controlla il futuro
Leggere Hall oggi, nel tempo del populismo autoritario, della xenofobia sdoganata, dei confini blindati e delle sinistre smarrite, significa riprendere il filo di un’analisi che troppo a lungo è stata ignorata o edulcorata. Significa comprendere che il razzismo non è solo odio, ma soprattutto gerarchia. È una cultura, un discorso che normalizza la disuguaglianza, che giustifica lo sfruttamento, che legittima l’esclusione.
Il suo pensiero ci obbliga a rifiutare l’idea che basti la solidarietà etica per sconfiggere il razzismo. L’antirazzismo morale, se non si fa politico, rischia di diventare un cerotto su una frattura aperta. Serve un antirazzismo che parli di condizioni materiali, di accesso al lavoro, alla casa, alla cittadinanza. Serve un’antropologia della disuguaglianza che metta in crisi il nostro eurocentrismo, che ascolti le voci di Fanon, di Césaire, di chi ha pensato il mondo da altri margini.
La lezione di Hall è radicale perché non separa mai il razzismo dal capitalismo. Non pensa che la modernità europea possa essere salvata dai suoi fantasmi coloniali senza un processo di rielaborazione profonda, culturale prima ancora che istituzionale. Le “pratiche discorsive” — come le chiama — sono ciò che tiene insieme l’immaginario suprematista e l’ordine socioeconomico. Smontare quelle pratiche significa cambiare la società.
Nel pensiero gramsciano, Hall trova la chiave per questo cambiamento: la cultura come terreno di battaglia politica. Non cultura come ornamento, ma cultura come egemonia. In questo senso, il ritorno a Gramsci non è nostalgia, ma urgenza. Hall non lo legge come un teorico puro, ma come un intellettuale militante che fa della teoria uno strumento per leggere e trasformare la storia.
E allora, se vogliamo davvero affrontare il razzismo in Italia, dobbiamo prima smettere di pensarlo come un corpo estraneo. È nostro. Ci appartiene. È nel modo in cui selezioniamo chi “integrare” e chi no, in cui ci indigniamo per un’aggressione razzista ma restiamo indifferenti davanti a un decreto sicurezza, in cui tolleriamo che un nero venga definito “non del tutto italiano” anche se indossa la maglia azzurra.
C’è una verità scomoda che Stuart Hall ci ricorda: non si può essere davvero antirazzisti se non si è anche anticapitalisti, se non si è capaci di mettere in discussione i meccanismi di accumulazione, i dispositivi di esclusione, le gerarchie di valore che costruiscono ogni giorno la disuguaglianza. E questo vale anche — soprattutto — per la sinistra.
La riedizione del suo libro in Italia non è solo una pubblicazione. È uno specchio. E chissà se avremo il coraggio di guardarci davvero.