Quarant’anni esatti fa, il 17 giugno 1983, si consumò in Italia uno dei più clamorosi errori giudiziari.
Gli studenti di diritto e di giornalismo della generazione Y trarranno giovamento dalla conoscenza di questo caso.
Venne arrestato Enzo Tortora, il celebre presentatore di “Portobello”.
Sono passati quarant’anni.
Negli anni Ottanta il suo programma spopolava per il format popolare e originale.
Era un mercatino dove si vendevano e compravano le cose più strane, si cercava moglie e si ritrovavano i vecchi commilitoni di guerra.
Tortora esibiva un pappagallo dal nome “Portobello” e con un aplomb da lord inglese concludeva il programma con la celebre fase: “Il Big Ben ha detto stop!”
Le manette dell’infamia scattarono alle 4:15 del mattino mentre Tortora era all’Hotel Plaza di Roma.
L’Italia del popolo bue, quella che a milioni seguiva ogni venerdì sera “Portobello”, si divise tra colpevolisti e innocentisti.
Un uomo degno e rispettabile entrò nel tritacarne del suo stesso mondo lavorativo.
Il suo arresto e la sua detenzione dovevano essere spettacolarizzati.
L’ordine di arresto era stato spiccato dalla procura di Napoli sulla base delle accuse di alcuni «pentiti».
Giovanni Pandico «’o pazzo», dichiarato psicolabile e paranoico, entrato e uscito dai manicomi giudiziari, noto per aver sparato al padre, avvelenato la madre, dato fuoco alla fidanzata, senza contare la strage nel Municipio del suo paese dove aveva ucciso a sangue freddo gli impiegati che tardavano a consegnargli il certificato di nascita.
Pandico fece il nome di Tortora solo al quarto interrogatorio dove, in un elenco di malavitosi, lo citò al sessantesimo posto con il titolo di camorrista “ad honorem”.
Pasquale Barra detto “’o animale”, il killer dei penitenziari, famoso per avere ucciso in carcere Francis Turatello, dopo diciassette interrogatori, nonostante gli fosse stato mostrato l’elenco compilato da Giovanni Pandico, non fece mai il nome di Tortora, finché poi, al diciottesimo, improvvisamente cambiò idea.
Riscontri? Nessuno.
Unica “conferma” un’agendina, giunta agli inquirenti da Lecce, che il 15 maggio 1983, un mese prima del blitz, era stata sequestrata nell’abitazione di un camorrista napoletano, Giuseppe Puca, noto come “‘o giappone”. Un librettino con la copertina nera pieno di fogli scritti con una grafia confusa.
Sotto la lettera T compariva anche il nome, scritto in corsivo, di Tortora Enzo, con accanto un numero di telefono: in seguito le indagini calligrafiche proveranno che il nome era Tortona e che il recapito telefonico non era quello del presentatore.
Poi fu la volta di Gianni Melluso, detto “il bello” o “cha cha cha” che durante i beati anni della delazione contro Tortora, usufruì di trattamenti di particolare favore, come gli incontri con Raffaella, che restò incinta e diventò sua moglie in un memorabile matrimonio penitenziario con lo sposo vestito Valentino.
Va detto che Melluso fu l’unico a chiedere perdono ai familiari di Tortora, in un’intervista all’Espresso del 2010: «Lui non c’entrava nulla, di nulla, di nulla. L’ho distrutto a malincuore, dicendo che gli passavo pacchetti di droga, ma era l’unica via per salvarmi la pelle. Ora mi inginocchio davanti alle figlie».
«Resti pure in piedi» fu la risposta di Gaia, la terzogenita.
Il resto è storia nota: le accuse si riveleranno del tutto false.
Nonostante ciò, il conduttore scontò sette mesi di carcere.
Eletto parlamentare europeo fra i Radicali, Tortora rinunciò all’immunità e restò ai domiciliari, certo che il processo avrebbe ristabilito la verità.
Il 15 settembre 1986 è assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Napoli.
Memorabile il suo appello in aula nei confronti dei giudici napoletani:
«Io grido: “Sono innocente!”
Lo grido da tre anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento! Io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi».
Il 17 giugno 1987 la Cassazione confermò l’assoluzione in appello.
Giorgio Bocca disse: “il più grande esempio di macelleria giudiziaria all’ingrosso del nostro Paese è che nessuno abbia pagato per quel che è successo”.
I giudici coinvolti, al contrario, hanno fatto un’ottima carriera.
I pentiti, i falsi pentiti, si sono garantiti una serena vecchiaia, e uno di loro, il primo untore, persino il premio della libertà.
I magistrati, senza neanche l’ombra di un controllo bancario, un pedinamento, un’intercettazione telefonica, basandosi solo sulle fonti orali di criminali di mestiere, sono riusciti nell’impresa di mettere in galera Tortora e condannarlo in primo grado a 10 anni di carcere più 50 milioni di multa. I due sostituti procuratori che a Napoli avviano l’impresa si chiamano Lucio Di Pietro, definito “il Maradona del diritto”, e Felice Di Persia.
Nessuno dei delatori sbugiardati è stato incriminato per calunnia.
Un anno dopo, il 18 maggio 1988, Tortora morì, stroncato da un tumore.
«In quelle orrende mura del carcere – dirà nell’ultima sua apparizione in televisione collegato dal suo letto nell’ospedale – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro…».
La sua vita si era fermata molto prima, il 17 giugno 1983, quando Enzo Claudio Marcello Tortora, figlio di un napoletano che faceva il rappresentante di cotone a Genova, giornalista e presentatore televisivo in gran spolvero, diventò all’improvviso “il caso Tortora”.
La vicenda che l’ha spezzato in due, anche se ormai lontana, segnò comunque la nostra storia.
Un po’ come quel “…Dunque, dove eravamo rimasti?”
Fu la frase con la quale riprese il suo “Portobello” dopo la scarcerazione.
Quanto ai magistrati, poco prima di morire, Tortora aveva presentato una citazione per danni: 100 miliardi di lire la richiesta.
Il Csm ha archiviato, risarcimento zero.
Archiviato anche il referendum del 1987, nato proprio sulla spinta del caso Tortora, sulla responsabilità civile dei magistrati: vota il 65 per cento, i sì sono l’80 per cento, poi arriva la legge Vassalli e di fatto ne annulla gli effetti.
Quel che resta di Enzo Tortora («Io sono innocente. Io sono estraneo», ripeteva come un mantra) non riposa in pace dentro una colonna di marmo con capitello corinzio al cimitero monumentale di Milano. La colonna è interrotta a metà da un vetro. Infilata dall’esterno, un’immaginetta di un Cristo in croce con la scritta: “Uno che ti chiede scusa”.
Dietro il vetro, c’è l’urna dorata con le ceneri e due date (1928-1988). Sotto, un’iscrizione abbastanza misteriosa: “Che non sia un’illusione”.
La spiega Francesca Scopelliti, l’ultima compagna: “Enzo ha voluto farsi cremare insieme ai suoi occhiali, quelli che gli servivano per leggere e che perdeva di continuo, e a una copia della Storia della colonna infame del Manzoni, con la prefazione di Leonardo Sciascia, di cui era amico.
Era venuto a trovarlo pochi giorni prima della fine. Ne scrisse subito dopo sul Corriere della sera, confidando parte di quello che Enzo gli aveva detto: speriamo che il mio sacrificio sia servito a questo Paese, e che la mia non sia un’illusione”.




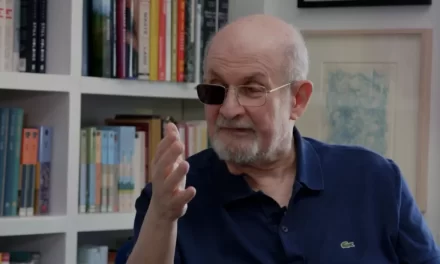









Questa è l’Italia. Gente onesta si fa la galera e i criminali stanno a piede libero. Una vergogna per la magistratura. La giustizia non esiste per i giudici?