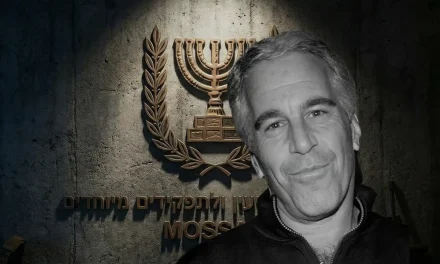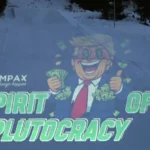C’è un filo sottile che lega le ultime mosse di Viktor Orbán: l’incontro di novembre con Donald Trump, i nuovi contratti energetici con Mosca e il silenzioso braccio di ferro con Bruxelles. È il filo di una strategia ambigua e pericolosa, che fa dell’Ungheria un laboratorio di equilibri instabili tra potenze rivali. Orbán gioca su tre tavoli — Stati Uniti, Russia e Unione Europea — trasformando ogni crisi in occasione per rafforzare se stesso, anche a costo di indebolire la posizione del suo Paese nel consesso europeo.
Con Trump, il premier ungherese ha ottenuto ciò che cercava: una deroga alle restrizioni sull’import di petrolio russo e la promessa di nuovi investimenti energetici statunitensi. In cambio, ha offerto un sostegno politico simbolico a quella destra populista americana che vede in lui un modello di “democrazia illiberale”. Ma dietro la cordialità delle foto di rito, Orbán sa che il legame con l’ex presidente americano è fragile: è una scommessa sul futuro, non un’alleanza solida.
Con Putin, mantiene una dipendenza calcolata. Continua ad acquistare gas e petrolio russi a prezzi agevolati, giustificandoli come “necessità nazionali”. In realtà, quella scelta tiene l’Ungheria ancorata a una rete di interessi economici che attraversa Mosca e le aziende di Stato magiare, dove si intrecciano potere politico, affari e clientele. Orbán non ha mai rotto davvero con il Cremlino, e la sua retorica “neutralista” nella guerra d’Ucraina serve più a proteggere questo legame che a preservare la pace.
Con l’Unione Europea, infine, gioca una partita doppia. Bruxelles resta la principale fonte di finanziamenti del governo ungherese, ma anche il bersaglio privilegiato della propaganda. Ogni volta che i fondi comunitari vengono sospesi per violazioni dello stato di diritto, Orbán agita lo spettro di un’Europa “colonialista” per alimentare il consenso interno. È la politica del ricatto permanente: bloccare decisioni cruciali su Ucraina, migranti o bilancio comune per poi ottenere concessioni.
Questo triplo gioco — economico, geopolitico e mediatico — è la chiave del suo potere. Orbán sa di non poter competere con le grandi potenze, ma può renderle tutte, a turno, un po’ dipendenti da lui. È il piccolo Stato che si comporta da pivot, sfruttando la propria posizione geografica e la propria vulnerabilità energetica per ottenere margini di manovra che non avrebbe altrimenti. Ma ogni equilibrio fondato sul calcolo finisce per logorarsi.
Dentro i confini ungheresi, la sua immagine comincia a incrinarsi. L’economia rallenta, l’inflazione corrode i salari e l’isolamento diplomatico pesa sulle prospettive del Paese. Lo stesso apparato che per anni gli ha garantito fedeltà — media controllati, magistratura allineata, oligarchi amici — mostra segni di stanchezza. E un Paese costruito sulla paura del dissenso inizia a mostrare la paura del declino.
La vicenda di Ilaria Salis, gestita con un cinismo che ha indignato l’opinione pubblica europea, ha reso visibile il volto più spietato del sistema Orbán: uno Stato che usa la giustizia come vetrina politica, la sovranità come scudo propagandistico, il dolore umano come strumento di consenso. È in questo terreno che il premier ungherese tenta di restare a galla: non più come statista, ma come equilibrista di potere.
Il nuovo sfidante Péter Magyar — figura interna al sistema, ma ora simbolo di un possibile risveglio civico — rappresenta per molti un segnale che qualcosa si muove. E se anche non riuscisse a scalzare Orbán, il solo fatto che un’alternativa emerga indica che il mito dell’invincibilità comincia a incrinarsi.
Orbán continuerà a sedere ai tre tavoli, ma la sedia europea traballa. Perché un’Europa che tollera il doppio gioco di Budapest indebolisce se stessa. E un leader che si regge solo sull’arte dell’ambiguità finisce prima o poi per perdere il ritmo, confondendo la tattica con la visione.
Dietro la maschera del “difensore della nazione” resta un uomo solo, che ha fatto del potere il proprio unico alleato e dell’Europa il suo nemico necessario.