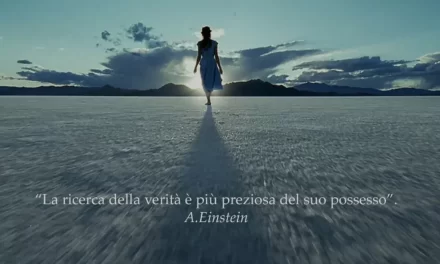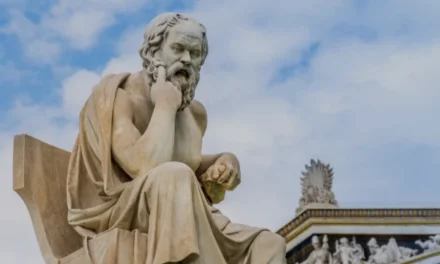Rigore nella misura, onestà nel bilanciamento, coraggio nell’assumere i costi delle decisioni. È questa l’arte che fa dell’ars iuris un sapere pratico e che, ieri come oggi, rende l’aequitas il nome più esigente della responsabilità del giurista: una via stretta che tiene insieme ordine e vita, legalità e giustizia, regola e caso, restituendo al diritto la sua fedeltà al giusto.
Nel lessico giuridico occidentale l’aequitas si presenta come una delle categorie più delicate ed esigenti, tanto da non poter essere ridotta a semplice strumento di correzione contingente o a clausola di buon senso. Essa non è un concetto neutro né un sentimento di clemenza, ma un metodo razionale che opera come grammatica della misura: criterio proporzionale che consente al diritto di adattarsi alla singolarità dei casi senza dissolvere la forza universale della regola. L’orizzonte che la sostiene è antico e si radica nell’intuizione aristotelica dell’epieíkeia, la quale non rappresenta un ammorbidimento sentimentale della legge, bensì la sua perfezione in concreto: la capacità di raddrizzare la linea dell’universale là dove non riesce a cogliere la curvatura del reale. Ne consegue che l’aequitas non si colloca all’esterno del diritto, come supplemento eventuale o fattore di disturbo, bensì al suo interno, come energia ordinante che impedisce sia il riduzionismo formalistico, sia l’indeterminatezza soggettiva. Essa costituisce dunque un’arte del proporzionare che permette di tradurre l’uguaglianza formale in giustizia proporzionale, rifiutando l’astrattezza cieca e, al contempo, evitando la deriva dell’arbitrio. Il giurista che esercita l’aequitas si muove in uno spazio di responsabilità peculiare: non può abdicare al diritto, né rinunciare al principio di legalità, ma deve consentire al sistema di riprodursi nel particolaresenza smarrirsi. Si tratta di attivare quella aequabilitas che permette all’ordinamento di mantenere coerenza tra il precetto generale e la concretezza della vita sociale. È una pratica che chiede rigore argomentativo, capacità di bilanciamento e sensibilità per i valori condivisi, poiché solo tali criteri sottraggono l’equità alla soggettività e la radicano in un tessuto di legittimazione riconoscibile. In questo senso, l’aequitas non può essere concepita come mera clausola di benignità, ma come dispositivo epistemico che raffina il diritto, mantenendolo fedele alla sua vocazione: essere ordine razionale delle relazioni intersoggettive. Lungi dall’essere un nome innocuo, essa diventa il banco di prova della responsabilità giuridica, luogo in cui il giurista deve misurare la distanza tra il “dire diritto” e il “fare giustizia”, rendendo conto della propria scelta non solo in termini di tecnica normativa, ma anche in termini di fedeltà alla persona come fine e misura di ogni ordinamento. In questo quadro, la tradizione giuridica romana costituisce un laboratorio paradigmatico. L’aequitas non venne concepita come fattore extragiuridico, ma come criterio di operatività dello stesso ius civile. Il pretore, viva vox iuris, integrava e correggeva le rigidità dello ius strictum, assumendo l’aequitas quale fondamento dei suoi rimedi. La giurisprudenza, commentando e sistematizzando quelle soluzioni, trasformava l’esperienza in metodo e traduceva in ius receptum innovazioni che erano nate come riparazioni equitative. La distinzione tra aequitas civilis e aequitas naturalismostra come già allora fosse presente la consapevolezza di un duplice livello: da un lato l’adeguatezza interna alla legalità costituita, dall’altro un parametro superiore capace di intervenire quando la legge positiva tradiva l’istanza di giustizia. Questo duplice volto rese l’aequitas un criterio operativo di straordinaria flessibilità, capace di evitare che il summum iusdegenerasse in summa iniuria e, al tempo stesso, di impedire che la creatività giuridica si trasformasse in arbitrio disgregante.
Equità come manutenzione dell’ordine giuridico e mediazione dei conflitti
Se il diritto è destinato a regolare la vita associata, l’aequitas rappresenta la sua capacità di manutenzione interna, la funzione che gli consente di rimanere fedele a sé stesso pur nelle trasformazioni sociali, culturali ed economiche. La storia occidentale conosce sistemi “aperti”, dove l’equità costituisce un meccanismo strutturale di adattamento, e sistemi “chiusi”, dove essa è relegata a criterio sussidiario attivabile entro confini rigorosamente definiti. In entrambi i modelli, tuttavia, l’aequitas agisce come strumento di razionalizzazione del concreto: l’astrazione della regola incontra la resistenza del fatto, e il giurista deve costruire un equilibrio che non tradisca né la certezza normativa né la giustizia sostanziale. Ne discende un’etica del bilanciamento che impedisce alla certezza di degenerare in durezza e, simmetricamente, alla creatività di smarrirsi nell’indeterminatezza. In epoca contemporanea, segnata da pluralismo valoriale e complessità sociale, il ruolo dell’aequitas si fa ancor più cruciale. Essa opera come principio polarizzante: integra e talvolta corregge la legalità senza minarne la struttura, a condizione che la decisione sia rigorosamente motivata, ancorata a standard non idiosincratici e coerente con la trama ordinamentale. Il giurista, in questa prospettiva, non è un demiurgo che crea norme ex nihilo, ma un artigiano della misura che deve rendere trasparente la ragione delle proprie scelte. L’argomentazione diventa così il luogo in cui l’aequitas si legittima: solo la verificabilità dei criteri adottati consente di distinguere la giustizia del caso concreto dall’arbitrio soggettivo. La proporzionalità, la ragionevolezza, la buona fede e la tutela dell’affidamento costituiscono alcuni degli strumenti mediante cui l’equità prende forma, traducendo valori condivisi in parametri di giudizio controllabili. La dimensione processuale conferma questa esigenza. Nei sistemi codicistici, il potere di decidere secondo equità è previsto in ipotesi eccezionali: la sentenza di equità non si limita a scegliere tra norme concorrenti, ma crea rapporti giuridici mediante un contemperamento ragionevole degli interessi in gioco. Proprio per questo, la sua legittimità dipende dall’argomentazione: dalla chiarezza con cui il giudice esplicita i criteri di proporzione, dalla capacità di radicare la decisione in valori giuridicamente riconoscibili, dalla coerenza con l’architettura complessiva del sistema. Accanto a questa equità “tipizzata”, emerge una più ambiziosa equità sostanziale o “immanente”, che orienta l’interpretazione delle norme anche in assenza di rinvii espressi. Non si tratta di sostituirsi alla legge, ma di dar voce all’energia interna della legalità, evitando che l’applicazione della norma si traduca in una distorsione del suo stesso spirito. In tal senso, l’aequitas rappresenta la capacità dell’ordinamento di garantire mobilità senza dissoluzione, fedeltà ai principi senza rigidità formalistica. Questa funzione di manutenzione ordinamentale si rivela particolarmente significativa in un contesto globale caratterizzato da interdipendenze fragili e conflitti intrecciati. L’aequitas non promette pacificazioni illusorie, ma offre una ragione pratica esigente, capace di governare la tensione tra proporzione e prevedibilità. Essa non elimina i conflitti, ma li rende trattabili, impedendo che la pretesa di certezza diventi durezza e che l’aspirazione alla giustizia si traduca in indeterminatezza. È, in definitiva, un linguaggio di mediazione che chiede al giurista di assumersi la responsabilità dei propri bilanciamenti, di nominare con onestà il costo delle scelte e di non mascherare l’inevitabile durezza del reale dietro formule apparentemente neutre.
Etica della responsabilità e fedeltà alla persona
Se la cifra dell’aequitas è la proporzione, il suo orizzonte ultimo è la persona. L’oggetto del diritto è la relazione intersoggettiva, e l’equità ne costituisce la salvaguardia concreta: impedisce che la persona venga sacrificata all’astrazione della regola e, allo stesso tempo, che la soggettività dissolva l’ordine normativo. L’aequitas si rivela così non solo criterio tecnico, ma anche istanza etica: mantiene il diritto aderente al suo oggetto, rendendolo strumento di giustizia e non mera macchina di potere. In essa si radica la logica del suum cuique, non come formula vuota, ma come metodo per distinguere l’equo dall’iniquo, per distribuire il dovuto secondo proporzione, per rendere al soggetto la sua dignità giuridica. La responsabilità del giurista che pratica l’aequitas si articola in più dimensioni. Anzitutto, una responsabilità epistemica: selezionare criteri controllabili e verificabili, distinguere l’imprevedibilità del caso dall’indeterminatezza arbitraria, rendere trasparente il percorso logico-argomentativo che conduce alla decisione. In secondo luogo, una responsabilitàistituzionale: mantenere la continuità del diritto, consentendogli di adattarsi al particolare senza tradire la propria identità, prevenendo tanto l’estremo del formalismo quanto quello dell’arbitrio. Infine, una responsabilità relazionale: riconoscere nell’altro non soltanto una controparte, ma un soggetto di diritto dotato di dignità intrinseca, titolare di un “suum” che deve essere rispettato e tutelato. È in questa prospettiva che l’aequitas si salda con i principi di solidarietà e di fraternità civile: non come retorica, ma come criterio concreto di lettura delle pretese, delle vulnerabilità e delle responsabilità che emergono nelle controversie giuridiche. In un tempo caratterizzato da pluralismo culturale, crisi ambientali e interdipendenze globali, l’aequitas assume un significato che travalica i confini strettamente giuridici. Essa diventa simbolo di una politica della misura: un metodo per evitare tanto la rigidità escludente quanto la fluidità disgregante, un linguaggio che può fungere da ponte tra ordinamenti diversi, un criterio che consente di pensare la giuridicità come spazio comune di convivenza. Lungi dall’essere un residuo della tradizione classica, essa appare oggi come la via più esigente per governare le sfide del diritto: offrire soluzioni giuridiche che, senza rinunciare alla certezza, sappiano riconoscere la dignità dell’altro come limite e misura di ogni potere.