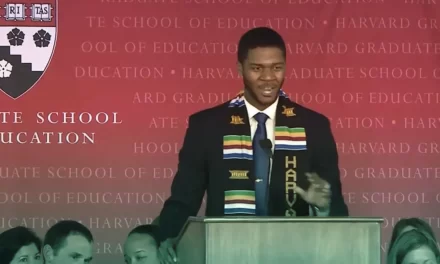Nel giorno in cui l’Italia ricorda la fine di Benito Mussolini, ucciso dai partigiani il 28 aprile 1945 e appeso il giorno dopo in Piazzale Loreto con Claretta Petacci, torna la domanda su cosa significhi davvero libertà. Una libertà conquistata col sangue, ma non per questo autorizzata alla ferocia.
L’Italia che rinasceva dalla dittatura e dalla guerra civile aveva bisogno di giustizia, non di vendetta. Aveva bisogno di processi, non di corpi esposti al ludibrio. Per questo, le parole che Sandro Pertini – partigiano e futuro presidente – pronunciò allora restano scolpite nella coscienza repubblicana:
«Io i nemici li combatto quando sono in piedi e vivi».
Non era indulgenza verso un dittatore. Era amore per la civiltà giuridica. Era l’intuizione che la nuova Italia non potesse ripagare l’odio con altra violenza. In quei cadaveri violati si consumava, infatti, non solo la fine tragica del fascismo, ma anche un rischio: quello che la democrazia nascesse già vulnerata nel suo principio fondante, il rispetto per la persona, anche quando sconfitta.
Oggi più che mai, in un mondo attraversato da nuovi populismi, da vendette pubbliche, da piazze digitali che chiedono punizioni esemplari e sommarie, quella frase di Pertini suona profetica. È un appello alla misura, alla giustizia che non urla, alla pietà che non è debolezza ma fondamento della pace.
Il 29 aprile resta una data che divide. Ma proprio per questo va guardata in faccia, per imparare a non tradire ciò per cui si è lottato: la libertà come responsabilità, e la giustizia come argine alla barbarie. Anche quando la tentazione di infierire sembra più forte del desiderio di costruire.