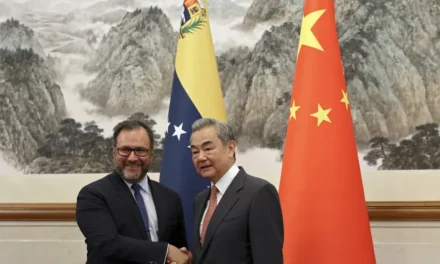il Vangelo assediato nell’unico villaggio cristiano di Palestina
Nel cuore della Cisgiordania, nella cittadina cristiana di Taybeh, il fuoco divampa non solo tra le pietre di una chiesa bizantina del V secolo, ma nei cuori feriti di un popolo sempre più solo. Il 7 luglio, coloni israeliani hanno dato alle fiamme la Chiesa di San Giorgio (Al-Khader) e un antico cimitero, sotto lo sguardo impassibile – e talvolta complice – delle forze armate israeliane. È solo l’ultimo capitolo di una spirale di violenza sistematica contro civili palestinesi, aggravata da una cultura dell’impunità che sta mutando i territori occupati in una zona franca del diritto.
Taybeh non è un luogo qualunque. È l’unico villaggio interamente cristiano della Palestina, menzionato nella Bibbia come Efraim, il luogo dove Gesù si ritirò con i suoi discepoli dopo la risurrezione di Lazzaro (Gv 11,54). È un frammento vivo della memoria di Cristo in Terra Santa, testimone di una fede che resiste alla marginalizzazione e all’oblio.
Eppure, oggi questa comunità di 1.500 anime, appartenenti a diverse confessioni (latini, ortodossi, melchiti), subisce intimidazioni, incursioni armate, roghi di case, pascoli forzati e insediamenti illegali, nel silenzio assordante della comunità internazionale e con la retorica dell’autodifesa usata per giustificare ogni sopraffazione.
La denuncia dei tre parroci
A parlare chiaro, in una dichiarazione congiunta diffusa l’8 luglio, sono stati i tre parroci del villaggio – p. Daoud Khoury (latino), p. Jacques-Noble Abed (greco-ortodosso) e p. Bashar Fawadleh (melchita) – che hanno denunciato senza mezzi termini «una strategia sistematica di erosione spirituale e culturale» e una «intimidazione quotidiana che mira a svuotare Taybeh della sua identità cristiana e palestinese».
«Crediamo che la Terra Santa non possa restare viva senza il suo popolo nativo. Espellere i contadini dalla loro terra, minacciare le chiese, accerchiare i villaggi è una ferita al cuore vivente di questa nazione», scrivono i presbiteri nel testo, pubblicato anche da Fides.
Hanno chiesto un’indagine internazionale, l’invio di delegazioni ecclesiali e diplomatiche per documentare i danni, e un sostegno tangibile per le famiglie colpite.
La ferita che brucia
La distruzione della chiesa di San Giorgio non è solo un attentato contro un edificio, ma contro l’identità di un popolo, contro la possibilità stessa di vivere la propria fede nella terra dove essa è nata. Quando la religione diventa strumento di espansione etnica, quando la fede si traveste da ideologia del possesso, il Vangelo viene tradito.
La violenza dei coloni – spesso orchestrata da gruppi estremisti come i “giovani della collina” – è cresciuta esponenzialmente negli ultimi mesi, alimentata da leggi ad personam e dalla revoca delle sanzioni americane contro gli insediamenti. L’episodio di Taybeh è solo l’ultimo di una lunga serie che ha colpito case, scuole, uliveti, moschee e chiese. Secondo il centro di monitoraggio ACLED, “la violenza dei coloni continua senza tregua”, anche se l’attività dei gruppi armati palestinesi è in calo.
Il silenzio che uccide
Ciò che inquieta è l’assenza di giustizia. Gli arresti sono rari, le condanne pressoché inesistenti. Le forze dell’ordine israeliane, incaricate di proteggere tutti i civili, restano spesso spettatrici o protettrici dei coloni. Il 25 giugno, dopo l’assalto a Kafr Malik e l’uccisione di giovani palestinesi, alcuni coloni hanno addirittura aggredito soldati dell’IDF, accusati di aver smantellato un avamposto illegale. Questo rovesciamento dei ruoli – coloni armati che sfidano l’autorità militare – rivela una deriva interna allo Stato israeliano: una frangia estremista si sente al di sopra della legge.
Il premier Netanyahu ha definito i coloni “un modello per lo sviluppo della terra e la cultura della Torah”, riservando le sue condanne solo ai casi di violenza contro l’esercito. Nulla sulle aggressioni ai civili palestinesi. Nulla sui cristiani di Taybeh.
La profezia della Chiesa
Nel silenzio delle diplomazie, la Chiesa parla. E lo fa con parole profetiche. I parroci di Taybeh non si appellano alla vendetta, ma alla solidarietà. Chiedono protezione, ma anche giustizia. Non vogliono fuggire, ma restare. È questa la loro resistenza: non con le armi, ma con la fede e la memoria.
Papa Francesco, nella sua enciclica Fratelli Tutti, ci ha messi in guardia da ogni nazionalismo sacralizzato:
«Una cultura senza amore sociale è un terreno fertile per l’odio, la crudeltà e la violenza» (FT, 30),
«Le religioni offrono un contributo essenziale alla costruzione della fraternità e alla difesa della giustizia nella società» (FT, 271).
Taybeh chiama la coscienza globale
Taybeh è oggi un microcosmo che interpella le Chiese del mondo, soprattutto quelle del Sud globale: l’Africa, l’America Latina, l’Asia. Non si tratta solo di difendere un villaggio, ma di riaffermare un principio: nessuna Terra Santa può esistere senza il popolo che l’abita. E nessun Vangelo può essere pienamente annunciato se la giustizia è messa a tacere.
Mediafighter si unisce all’appello di Taybeh. Servono monitoraggi, azioni legali, sostegni agricoli e – soprattutto – presenza pubblica e visibile. Le parole, da sole, non bastano più.
Restare, resistere, rinascere
I cristiani di Taybeh non cercano privilegi. Chiedono solo di vivere. Piantano ancora ulivi, celebrano l’Eucaristia, accendono candele tra le macerie. Ogni gesto è Vangelo che non si spegne. È tempo che anche noi restiamo al loro fianco.
Perché dove si dà fuoco a una chiesa, si tenta di bruciare la memoria di Cristo. Ma dove si resta — come a Taybeh — il Vangelo continua a risorgere.