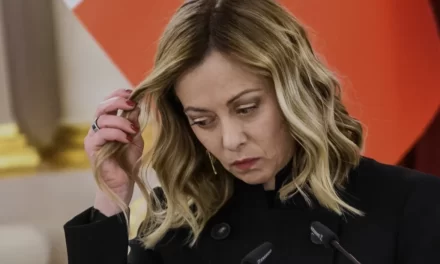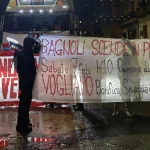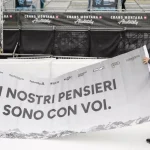Il Senato approva la separazione delle carriere dei magistrati
La riforma sulla separazione delle carriere è stata approvata dal Parlamento e sarà ora sottoposta al vaglio dei cittadini.
Si parla di modernità, efficienza, equilibrio dei poteri.
Ma il punto vero è un altro: stiamo costruendo una giustizia più forte o un potere più comodo?
In Italia esiste un dato che nessuna retorica può cancellare:
la criminalità organizzata non è un fenomeno folkloristico né confinato a un passato remoto.
È economia, è infiltrazione, è condizionamento.
Ed è viva.
Per questo, quando si tocca la struttura della magistratura, non si fa un esercizio accademico.
Si decide se il pubblico ministero potrà ancora indagare con libertà su chiunque, oppure se sarà costretto a guardarsi prima alle spalle e poi avanti.
La separazione delle carriere, in teoria, è un tema legittimo.
Nella pratica, il modo in cui è disegnata questa riforma apre una crepa: due Consigli superiori, un’Alta Corte disciplinare, criteri di nomina che espongono una parte delle toghe a selezioni e controlli più permeabili alla politica.
La giustizia non è un recinto da cui mettere ordine a colpi di architettura.
È un organismo delicato.
Funziona quando chi investiga non deve chiedersi chi sta toccando, quando non teme ripercussioni, quando l’autonomia non è favola ma protezione reale.
La storia italiana ce lo ha insegnato nel modo più duro:
l’indipendenza non è privilegio del magistrato, è garanzia del cittadino.
Chi teme la magistratura autonoma dovrebbe porsi una domanda:
davvero crediamo che il problema del Paese sia un pubblico ministero troppo libero?
Davvero pensiamo che mafie e corruzione arretreranno se chi le combatte dovrà farlo con meno scudo istituzionale?
Una riforma è buona quando rafforza il diritto, non quando alleggerisce il peso sul potere.
E una democrazia matura non teme l’autonomia dei suoi giudici e dei suoi pm: la pretende, perché sa che l’alternativa non è equilibrio, ma debolezza.
Il referendum dirà quale idea di giustizia vogliono gli italiani.
Non un rito, non un tecnicismo:
una scelta tra uno Stato capace di indagare tutti e uno Stato in cui non tutti sono indagabili.
Il resto è semantica.
La libertà, invece, è sostanza — e va difesa, oggi, con più lucidità che mai.