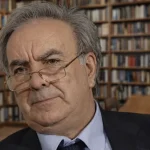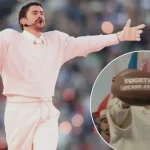Questo 22 settembre il Paese sta vivendo una giornata particolare: lo sciopero generale proclamato dall’USB e da altri sindacati conflittuali. Non sarà solo l’ennesima fermata del lavoro a difesa di salari e condizioni, ma un atto che intende intrecciare la lotta sociale in Italia con la tragedia che continua a consumarsi in Medio Oriente, in particolare a Gaza.
Dietro questa scelta c’è una convinzione precisa: il diritto allo sciopero non si esaurisce nella difesa corporativa di un contratto, ma diventa esercizio di cittadinanza e responsabilità solidale. Quando lavoratori e studenti scendono in piazza non solo per sé, ma per un popolo che chiede libertà e riconoscimento, il gesto assume una dimensione più ampia, quasi profetica.
Un Paese che dà e riceve
Il tema che attraversa molte piazze riguarda anche l’Italia. Da tempo, infatti, il nostro Paese è coinvolto negli scambi economici e militari con Israele: non solo forniture di sistemi di cybersicurezza e tecnologie dual use, ma anche importazioni di armamenti e collaborazioni scientifiche che pongono interrogativi etici.
In un tempo in cui il conflitto a Gaza continua a mietere migliaia di vittime civili, la coscienza collettiva si interroga: fino a che punto la sicurezza nazionale può giustificare relazioni che rischiano di alimentare un conflitto giudicato da tanti osservatori come sproporzionato e disumano?
La Costituzione italiana – che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali – si ritrova qui in sintonia con il Magistero della Chiesa. Pacem in Terris di san Giovanni XXIII ricordava che la pace non è mai mera assenza di guerra, ma “costruzione fondata sulla verità, la giustizia, l’amore, la libertà”. E papa Francesco, in Fratelli tutti, ha rilanciato con forza: «Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato» (n. 261).
Solidarietà e conflitto sociale
Nelle parole di economisti e intellettuali come Luciano Vasapollo, la Palestina è oggi simbolo di una lotta più ampia: quella contro ogni forma di sfruttamento predatorio, che sia militare o economico. Senza condividere necessariamente le categorie ideologiche con cui viene descritta, resta il fatto che lo sciopero chiama in causa un nodo reale: la connessione tra pace e giustizia sociale.
Il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa parla di “solidarietà” come principio fondamentale: essa è «determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune» (n. 193). È la stessa logica che anima i lavoratori italiani quando chiedono salari adeguati, servizi pubblici, tutela ambientale, e allo stesso tempo non dimenticano i popoli sotto occupazione o guerra. Non è un semplice esercizio di retorica: i portuali di Genova hanno già mostrato come la forza del lavoro possa concretamente incidere impedendo il transito di armi.
Dal diritto alla profezia
Per questo lo sciopero del 22 settembre non va letto solo nella chiave di una mobilitazione sindacale. È piuttosto un banco di prova della capacità di coniugare il diritto con la responsabilità. In tempi di crisi globale, la solidarietà non è un lusso, ma un’urgenza.
Si tratta allora di custodire il diritto allo sciopero come patrimonio democratico e sociale, non ridurlo a disservizio o fastidio. Quando questo diritto viene esercitato per denunciare la complicità con la guerra e per affermare l’urgenza della pace, diventa parola pubblica, coscienza vigile, segnale di un Paese che non vuole rassegnarsi.
Il 22 settembre, dunque, non è soltanto il giorno di un conflitto tra lavoratori e governo, ma anche un’occasione per riflettere su quanto la nostra vita quotidiana sia intrecciata con le sorti di popoli lontani. È la lezione della solidarietà evangelica e sociale: nessuno si salva da solo.