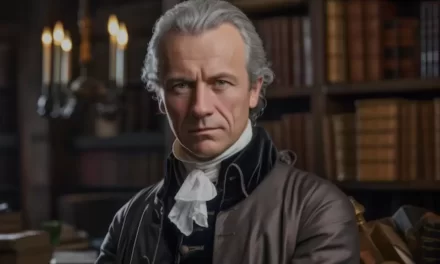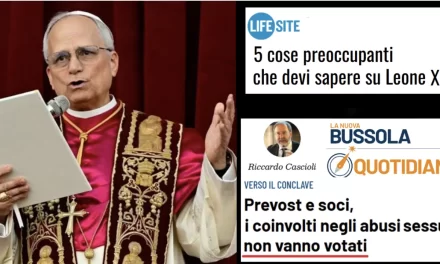Il 2 luglio 1871 Vittorio Emanuele II entra solennemente a Roma, proclamata capitale d’Italia. Un gesto altamente simbolico, compiuto dieci mesi dopo la breccia di Porta Pia, con cui si completava l’unità territoriale del Paese. Roma non era solo una città: era un’idea, un sogno risorgimentale e, al tempo stesso, una ferita aperta per la coscienza cattolica. A distanza di oltre 150 anni, quella data continua a interrogarci: fu una vittoria politica, ma fu anche l’inizio di una lunga e tormentata rielaborazione del rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, tra civitas e ecclesia, tra potere temporale e coscienza morale.
Il trionfo dell’unità… e la nascita di una frattura
Per il Regno d’Italia, fare di Roma la capitale significava completare il processo di unificazione: Torino era stata troppo sabauda, Firenze troppo temporanea. Roma rappresentava un punto di convergenza ideale tra storia, mito e legittimazione. Ma questa scelta aveva un prezzo: lo strappo con il Papato. Pio IX si chiuse nei Palazzi Apostolici, proclamandosi “prigioniero”, mentre lo Stato italiano si trovò nella difficile posizione di occupare la Città Eterna senza alienarsi definitivamente le coscienze cattoliche, ancora fortemente legate al Papa-re.
Nonostante la Legge delle Guarentigie (1871), che intendeva riconoscere alla Santa Sede una serie di prerogative, il dissidio rimase insanabile per decenni. I cattolici furono a lungo scoraggiati dal partecipare alla vita politica dello Stato unitario. Nacque così il paradosso: l’Italia aveva la sua capitale, ma non ancora un’identità condivisa.
Roma, capitale politica e custode di un’anima più grande
Roma, dunque, non fu solo una conquista, ma un banco di prova. Per lo Stato significò affermare la propria sovranità su un territorio che per secoli era stato centro di un potere teocratico. Ma nel tempo emerse una verità più profonda: Roma non poteva essere ridotta a capitale amministrativa. Era un laboratorio spirituale, simbolico e culturale, che non si poteva possedere con le sole leggi o i cannoni.
Fu proprio questa tensione a costringere lo Stato italiano a riconsiderare il suo rapporto con la dimensione religiosa. La riconciliazione arrivò solo con i Patti Lateranensi del 1929, quando si stabilì una nuova forma di coabitazione tra le due sovranità: quella dello Stato italiano e quella spirituale della Chiesa cattolica.
E oggi? Una capitale che continua a interrogare
A quasi un secolo dai Patti e oltre 150 anni dall’ingresso di Vittorio Emanuele II, Roma resta un crocevia delicato tra politica, fede, popoli e storie. Dopo due guerre mondiali, il fascismo e la Resistenza, dopo il Concilio Vaticano II e la crisi dei totalitarismi, Roma ha acquisito un ruolo inedito: quello di coscienza critica dell’Europa, terra di ponti e non di muri, culla del diritto e sentinella della dignità umana. In questo senso, l’elezione dei Papi del secondo Novecento, da Giovanni XXIII a Leone XIV, ha contribuito a dare alla città un respiro universale, ecclesiale, profetico.
Ma Roma, oggi, è anche segnata da ferite: degrado urbano, conflitti sociali, disuguaglianze, sfiducia verso le istituzioni. Eppure, continua a custodire un mistero. Non è solo capitale d’Italia. È il cuore di una civiltà che cerca, talvolta goffamente, di coniugare la giustizia con la misericordia, il diritto con la profezia, il potere con il servizio.
Dalla conquista alla conversione
Il 2 luglio 1871 fu un punto di partenza più che di arrivo. Roma non fu semplicemente “presa”: fu affidata alla coscienza del popolo italiano. E questa coscienza, nel tempo, si è confrontata con i drammi della guerra, la crisi del potere, la forza della testimonianza cristiana. Oggi, nel tempo della globalizzazione, della guerra diffusa, delle migrazioni e delle nuove povertà, Roma è chiamata a non essere solo centro decisionale, ma anima accogliente. Il suo essere capitale sarà pieno solo se saprà tornare ad essere grembo, più che trono. Città di Dio, più che città del potere.
Nota finale: Il gesto di Vittorio Emanuele II fu storico. Ma solo la fede, nel tempo, ha trasformato quella ferita iniziale in un’opportunità di dialogo. È in questa capacità di conversione storica che risiede oggi il vero prestigio morale della Chiesa e il senso profondo di Roma capitale.