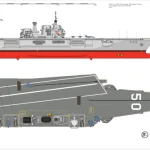C’è un gesto che, più di mille comunicati, rivela lo stato morale di una stagione politica: zittire una giornalista che fa il proprio mestiere. Sull’Air Force One, incalzato da una domanda sui files Epstein, Donald Trump non ha scelto la via della chiarezza ma quella dell’epiteto: «Quiet, piggy» – “porcellina, stai zitta”. La Casa Bianca lo ha persino difeso.
Non è solo sessismo da bar. È un segnale: quando il potere teme la verità, attacca il messaggero. E non a caso la domanda riguardava Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali e al centro di un sistema di sfruttamento che – a leggere le testimonianze – ha inghiottito adolescenti, vulnerabili, vite con nome e volto che spesso restano oscurati. Nei nuovi materiali pubblicati dal Dipartimento di Giustizia compaiono infatti anche trascrizioni con racconti di ragazze giovanissime, fino a 14 anni, e la conferma che denunce erano arrivate all’FBI già nel 1996.
La vicenda, però, ha un’altra ironia tragica: il rilascio dei documenti è avvenuto in forza dell’Epstein Files Transparency Act, legge firmata dallo stesso Trump, che impone la pubblicazione del materiale non classificato ancora sigillato. Ma ciò che arriva al pubblico è un pacco spesso pesantemente redatto, con pagine oscurate e interi blocchi illeggibili. Gli attivisti e diversi parlamentari – democratici e repubblicani – dicono che così si tradisce lo spirito della trasparenza.
Poi accade l’episodio più tossico: almeno 16 file “spariscono” dal sito del Dipartimento di Giustizia poche ore dopo la pubblicazione. Tra questi, secondo Associated Press e Financial Times, anche un’immagine in cui sarebbe comparsa una foto di Trump (insieme a Epstein, Melania Trump e Ghislaine Maxwell) all’interno di un cassetto o in materiali sequestrati. Il Dipartimento parla di revisioni e redazioni “per cautela”, ma l’impressione pubblica è devastante: chi decide che cosa si vede e che cosa no?
In mezzo, le fotografie diventano benzina politica. Alcune mostrano figure celebri: Bill Clinton appare in più scatti (anche in contesti mondani o privati); compaiono nomi della cultura e dello spettacolo come Mick Jagger, Michael Jackson, Diana Ross; e ancora Kevin Spacey, Chris Tucker, Richard Branson, Peter Mandelson, oltre al principe Andrew e Sarah Ferguson. Ma la presenza in una foto, da sola, non prova un reato: è semmai una mappa di prossimità, un atlante di relazioni, un indicatore del modo in cui Epstein costruiva la propria aura.
È qui che l’elzeviro deve fare il suo mestiere: distinguere. Distinguere tra giustizia e spettacolo, tra vittime e trofei mediatici, tra la doverosa trasparenza e la pornografia del sospetto. Perché il rischio è duplice: o tutto diventa complotto e propaganda, oppure tutto viene dissolto in un flusso di “foto sgranose” senza contesto, buone solo a colpire l’avversario.
Ma una cosa resta evidente: l’insulto alla giornalista è un atto politico e simbolico. È come dire: non chiedere; non guardare; non nominare; non aprire i cassetti. Solo che la storia dell’Occidente – e, più ancora, la storia biblica – insegna che i cassetti prima o poi si aprono. E quando si aprono, la misura della civiltà non è quanta vergogna riusciamo a spostare altrove, ma quanta verità siamo disposti a sopportare per fare finalmente giustizia.
Per questo il punto non è la “porcellina”. Il punto è la paura. E la paura, quando abita i palazzi, diventa un metodo: redigere, ritardare, rimuovere. Finché la trasparenza non è più un dovere verso le vittime, ma un’arma da puntare contro i rivali. E allora sì, la domanda più seria non riguarda chi compare nelle foto: riguarda chi controlla la luce. E se la luce, in democrazia, è ancora davvero di tutti.