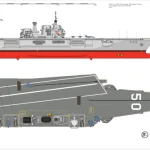Il presidente colombiano Gustavo Petro denuncia Washington: “Ha scelto la mafia come suo alleato”. L’inserimento nella lista Clinton segna l’apice di una crisi politica che intreccia potere, droga e geopolitica, con il rischio di trascinare la Colombia in una nuova stagione di scontro fra Stati Uniti e America Latina.
Venerdì sera, a Bogotá, Gustavo Petro non ha parlato da capo di Stato, ma da tribuno popolare. “Il governo degli Stati Uniti ha deciso di scegliere la mafia come suo alleato in Colombia”, ha gridato dal palco di Plaza de Bolívar, davanti a una folla che lo acclamava come un liberatore. La decisione di Washington di inserirlo nella lista Clinton — lo strumento giuridico che congela beni e relazioni commerciali di chi è sospettato di avere legami con il narcotraffico — è stata il detonatore politico di una crisi senza precedenti.
Petro, che negli ultimi mesi ha denunciato pubblicamente la cosiddetta Nueva Junta del Narcotráfico (NJN), ha ora rovesciato l’accusa: non sarebbe lui a essere colluso con il narcotraffico, ma sarebbero gli Stati Uniti ad averne fatto un alleato tattico. E per sostenerlo, ha scelto il terreno che gli è più congeniale: la piazza.
L’offensiva americana e la risposta di Petro
L’inserimento nella lista Clinton, deciso dal governo di Donald Trump, ha colpito non solo Petro, ma anche alcuni membri della sua famiglia e del suo entourage politico. L’amministrazione statunitense sostiene che il presidente colombiano avrebbe “tollerato” infiltrazioni criminali nei vertici economici e sportivi del Paese, in particolare attraverso club calcistici e società di sicurezza privata controllate da esponenti della NJN.
Petro ha reagito con furia, accusando Washington di un’operazione politica mascherata da indagine giudiziaria.
“Non ci inginocchiamo”, ha detto, “non faremo un passo indietro”. Nelle sue parole, l’attacco americano non è che l’ultima manifestazione del riflesso coloniale degli Stati Uniti: punire i leader latinoamericani che non si allineano alla loro politica estera.
Il presidente colombiano è convinto che le sanzioni siano una rappresaglia per le sue prese di posizione contro Israele all’ONU e per il suo appoggio al riconoscimento di uno Stato palestinese. “Mi puniscono perché ho denunciato il genocidio a Gaza”, ha dichiarato, “ma la Colombia non è un protettorato”.
Una piazza contro l’impero
La scena di Plaza de Bolívar aveva il sapore di un rito politico latinoamericano: bandiere dell’M-19, tamburi, studenti, sindacati, comunità indigene arrivate da lontano per sostenere il “presidente del popolo”.
Petro ha trasformato la difesa personale in una battaglia simbolica per la sovranità nazionale, evocando il linguaggio del potere costituente e della democrazia diretta. “Non sono io a essere sotto processo”, ha detto, “ma la Colombia libera”.
Le sue parole hanno diviso il Paese. Per i sostenitori, è l’unico leader che osa sfidare la prepotenza americana; per i detrattori, un populista che si rifugia nella retorica anti-imperialista per coprire le proprie fragilità politiche. Ma il discorso ha toccato un nervo scoperto: l’eterna ambiguità del rapporto tra Washington e Bogotá, un legame fondato da decenni su cooperazione militare e controllo antidroga, ma spesso degenerato in dipendenza economica e ingerenza politica.
Gli Stati Uniti e la doppia morale della “guerra alla droga”
Le parole di Petro non nascono nel vuoto. Per oltre cinquant’anni, gli Stati Uniti hanno finanziato la guerra alla droga in America Latina, fornendo armi, intelligence e fondi attraverso programmi come Plan Colombia. Ma oggi, con la NJN e le sue ramificazioni tra club calcistici, imprese di sicurezza e affari minerari, la linea che separa il crimine dall’economia legale è più sfocata che mai.
Petro denuncia che Washington avrebbe scelto di convivere con i nuovi cartelli “invisibili”, preferendo un ordine stabile — e quindi controllabile — al rischio di una rivoluzione sociale. “Hanno scelto la mafia”, ha detto, “perché la mafia non fa domande sulla disuguaglianza”.
È un’accusa pesante, ma non priva di fondamento. Le rivelazioni sul coinvolgimento di imprese legate alla NJN in appalti pubblici e in contratti con lo Stato colombiano mostrano come la penetrazione del narcotraffico nell’economia formale coincida spesso con l’interesse geopolitico americano a mantenere l’equilibrio.
La Colombia è da decenni il laboratorio delle politiche di sicurezza statunitensi nel continente. Eppure, dopo miliardi di dollari spesi, la produzione di coca non è diminuita: si è solo spostata, frammentata, resa più sofisticata. Oggi il narcotraffico non ha più bisogno dei cartelli violenti: ha banche, squadre di calcio e società di sicurezza. È diventato, paradossalmente, una struttura più efficiente e più compatibile con l’economia globale.
Petro contro il modello americano
La vera posta in gioco non è solo la reputazione del presidente colombiano, ma il modello di sovranità che egli propone. Petro rifiuta la subordinazione storica di Bogotá a Washington e rivendica una politica estera autonoma, che guarda al Sud globale e chiede un nuovo equilibrio tra giustizia sociale e sicurezza.
Il suo progetto di Assemblea Costituente, presentato come risposta alla crisi, punta a riscrivere il patto sociale del Paese e a sottrarre al Congresso — e, indirettamente, agli Stati Uniti — il monopolio delle riforme strutturali.
Washington, dal canto suo, interpreta questo progetto come una deriva autoritaria mascherata da sovranismo, e teme un effetto domino nella regione. Non è un caso che la tensione tra Stati Uniti e Colombia cresca mentre i governi di Brasile, Cile e Messico reclamano un maggiore protagonismo continentale e un rapporto meno asimmetrico con la Casa Bianca.
La Colombia come specchio dell’America Latina
La crisi tra Petro e gli Stati Uniti è, in fondo, il sintomo di una più ampia resa dei conti tra il Nord e il Sud del continente. Gli Stati Uniti, impegnati su troppi fronti — Ucraina, Medio Oriente, Indo-Pacifico — non possono più permettersi di “perdere” l’America Latina. Ma il linguaggio della sanzione e del sospetto rischia di produrre l’effetto opposto: spingere i Paesi sudamericani verso una diplomazia alternativa, da Pechino a Mosca, passando per Ankara.
Nel suo discorso, Petro ha ricordato che “Trump non sa nemmeno dove sia la Colombia”. Forse è una provocazione, ma fotografa una realtà: l’indifferenza americana verso le dinamiche reali del continente. Mentre la Casa Bianca continua a leggere la regione attraverso la lente del narcotraffico, l’America Latina cerca un nuovo linguaggio politico fondato su autonomia, memoria e giustizia sociale.
Dietro le accuse incrociate, si intravede una verità più profonda: la “guerra alla droga” è diventata una guerra di narrazioni. Gli Stati Uniti continuano a definirsi come baluardo della legalità, ma tollerano — o strumentalizzano — il potere dei narco-imprenditori quando serve ai propri interessi strategici. Petro, con la sua retorica anti-imperialista, tenta di ribaltare quella logica, ma rischia di restare solo, prigioniero di una piazza entusiasta e di un establishment diffidente.
La Colombia, ancora una volta, è la frontiera. Non solo del traffico di cocaina, ma della lotta per la sovranità politica in un mondo che non distingue più tra crimine, mercato e potere.
E la domanda, oggi, non è se Petro sopravviverà allo scontro con Washington.
La vera domanda è se l’America Latina potrà mai liberarsi dalla dipendenza da un impero che continua a confondere l’ordine con l’obbedienza.