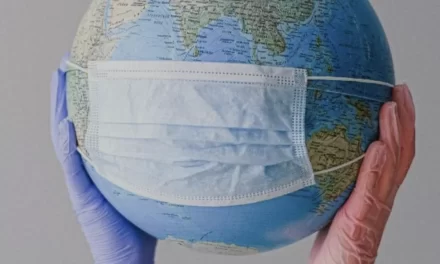EDITORIALE: La nostra società vive un paradosso: parla di morte sempre più spesso — invecchiamento demografico, solitudini estreme, dibattito sull’eutanasia — ma la comprende sempre meno. La teme, la rimuove, la sterilizza. Ne fa un fatto tecnico, sanitario, amministrativo. Eppure la domanda resta, ostinata e antica come l’uomo: cosa facciamo con il limite?
Che cos’è allora questa paura che ritorna? Non quella dei tomi di filosofia, ma quella delle lacrime vere, del respiro che manca, dell’invocazione che nessun argomento razionale riesce a zittire: “Non voglio morire”. È il grido della vecchia Marte nel film di Dreyer, ma è anche il sussurro di tanti che oggi si scoprono fragili e si chiedono, senza retorica: “Come si fa a morire?”
I grandi pensatori dell’antichità hanno provato a tranquillizzarci. Epicuro ci invitava a non temere ciò che sentirà il nostro corpo solo quando non sentiremo più nulla. Montaigne distingueva fra la morte e l’atto di morire. Spinoza ci esortava a meditare la vita, non la fine. Parole intelligenti, certo. E tuttavia, a ben guardare, contengono una confessione implicita: la morte fa paura anche ai filosofi. Forse perché non basta negare l’angoscia per vincerla. Come scriveva Pascal, gli uomini, incapaci di risolvere la morte, preferiscono non pensarci.
Ci sono, però, voci che onestamente non scappano. Santa Teresa di Lisieux, alla vigilia del suo ultimo respiro, non recitava massime stoiche: tremava. Diceva: “Non so come si faccia a morire”. Non per debolezza, ma per verità. Eppure morì abbandonata nell’Amore, non nel calcolo. Il suo timore non contraddiceva la fede: la trasfigurava.
Accanto a queste testimonianze spirituali, oggi emergono storie concrete, laceranti. Figli che hanno assistito i genitori fino all’ultimo, pazienti che lottano contro malattie progressive, uomini e donne che conoscono il dolore dall’interno e tuttavia dicono, con lucidità: la morte non si addomestica organizzando il suicidio medicalizzato. L’illusione di controllare la morte, decidendone l’ora e il modo, non libera: rischia di impoverire il significato della vita proprio quando esso è più urgente, più fragile, più vero.
Chi chiede di morire non domanda una siringa: chiede di non essere lasciato solo. Chiede che la sua sofferenza abbia ancora spazio nel cuore di qualcuno. Chiede che la vita non sia giudicata dalla sua efficienza. Chi si sente amato raramente chiede di scomparire. È qui che la domanda sul fine vita diventa domanda su di noi, sulla nostra capacità di rimanere accanto. “Dov’è l’amore quando non c’è più speranza?”, scriveva una giovane donna gravemente malata e tentata di arrendersi. Il suo cammino — faticoso, degno, luminoso — dimostra che la risposta non è un concetto, ma una presenza.
Cristo stesso, dinanzi alla morte dell’amico, non ha recitato dottrine astratte: ha pianto. Nel Getsemani non ha negato l’angoscia: l’ha attraversata. E sulla croce non ha avuto paura di dire “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Il Vangelo non ci propone un eroismo freddo: ci mostra un amore che non abbandona, che resta, che abbraccia l’oscurità senza lasciarla vincere.
Sarebbe ingenuo pensare che la paura della morte si dissolva con argomentazioni o leggi. Ma possiamo custodire un principio semplice e rivoluzionario: non è dignità decidere la propria sparizione; dignità è essere custoditi fino all’ultimo respiro. La cultura dell’eutanasia promette una morte “dolce”, ma rischia di costruire una società che smette di credere che ogni vita, anche ferita, rimane degna di sguardo, di prossimità, di abbraccio.
Non temiamo la morte rimuovendola. La affrontiamo imparando — con Maestri umani e divini — a stare nel passaggio. Non da soli, mai da soli. Perché si impara a morire come si impara a vivere: amando e lasciandosi amare. Tutto il resto è anestesia dell’anima.