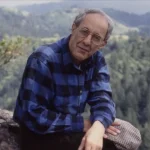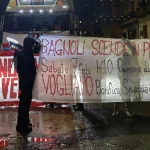La storia di Emanuele Foresti: No al suicidio assistito, no all’eutanasia
«Siamo noi e solo noi a dover scegliere sulla nostra vita», scriveva Laura Santi, giornalista cinquantenne di Perugia, poco prima di somministrarsi il farmaco letale che ha posto fine alla sua lunga convivenza con la sclerosi multipla. Una scelta drammatica, personale, rispettabile nella sua sincerità. Ma mentre quella frase rimbalzava sulle prime pagine e nelle dichiarazioni politiche sul fine vita, a Brescia, nel silenzio di una stanza e della comunità che lo accompagnava, un altro malato, Emanuele Foresti, moriva scegliendo di vivere fino all’ultimo. Niente clamore, nessuna siringa. Solo una croce portata fino in fondo, con la fede di chi crede che anche la sofferenza possa essere un linguaggio d’amore.
Mentre a Perugia una donna ha scelto di morire somministrandosi un farmaco letale con l’assistenza dello Stato, a Brescia un uomo, malato di Sla, ha scelto di vivere fino in fondo. Le due storie si sono incrociate nel silenzio di due stanze diverse, a centinaia di chilometri l’una dall’altra, ma sono diventate in modo imprevisto uno specchio. Non del giudizio, ma del senso. Della domanda radicale che attraversa il nostro tempo: è ancora possibile dare valore alla vita, anche quando essa è segnata dal limite?
Emanuele Foresti non è diventato un simbolo nei talk-show. Non ha avuto aperture di giornale né proclami da parte di alcuna associazione. Ma ha fatto qualcosa di grande: ha vissuto fino all’ultimo respiro, credendo che anche il dolore potesse parlare di Dio. Lo ha fatto attraverso un cammino interiore vero, non privo di domande, crisi, lacrime. E proprio per questo, profondamente umano. Lo ha fatto grazie a una comunità che non lo ha lasciato solo. Lo ha fatto perché – come diceva prima di morire – voleva che la sua sofferenza non fosse solo sua, ma diventasse forza per altri.
Nel frattempo, Elide, una donna disabile di Padova, combatte ogni giorno con dolori cronici e istituzioni sorde. Le sue parole sono semplici, ma rivelano uno squarcio: “Si parla solo del diritto a morire, mai di quello a vivere. È più comodo invocare il suicidio assistito che costruire un sistema che accompagni la fragilità.” E ha ragione.
Viviamo in un tempo in cui la morte viene presentata come diritto, ma il diritto a essere accolti nella vita – e nel dolore – scompare nel rumore dell’indifferenza. Non si parla di cure palliative, di sostegno concreto ai disabili, di reti che accolgano e non abbandonino. Non si investe nel personale per l’assistenza domiciliare, né si forma una cultura della prossimità. E così, la tentazione di “spegnerla qui”, la vita, diventa più forte. Non per convinzione, ma per solitudine.
Ma la sofferenza, se abitata con amore, può diventare un luogo sacro. La croce non è mai l’ultima parola, se ci sono occhi che guardano e mani che si tendono. L’esperienza di Emanuele lo dimostra: anche paralizzato, anche privo di forze, ha comunicato una luce che oggi fa riflettere più di qualsiasi dibattito giuridico. Una luce pasquale, che non nega la croce, ma la attraversa.
Chi ha a cuore la dignità umana non può tacere. Non si tratta di imporre dogmi, ma di gridare che la vita – anche spezzata, anche ferita – è sempre degna. E che c’è un’altra via rispetto alla morte indotta: la via della cura, della comunità, della fede che accompagna senza forzare.
«È più pratico brandire la morte», scrive amaramente Elide. Ma è proprio questa semplicità brutale che va smascherata: dietro l’apparente “libertà di scelta” si cela spesso una scelta senza alternative, una società che, invece di tendere la mano, offre una siringa. E questo, lo si dica chiaramente, non è progresso: è resa.
Emanuele ha scelto di combattere la buona battaglia. Ha conservato la fede, anche nell’oscurità. E ci lascia un’eredità silenziosa, ma luminosa: non tutto ciò che è difficile va evitato, non tutto ciò che è doloroso va soppresso. Alcune vite parlano proprio perché non fuggono.
Forse non vincerà nei sondaggi, ma nella coscienza di chi crede ancora nell’umano, questa testimonianza è un faro. E il suo nome, come quello di tanti invisibili che scelgono la vita ogni giorno, dovrebbe essere pronunciato più spesso. Non per fare rumore. Ma per dare voce a chi, senza urlare, ci insegna a non arrenderci.