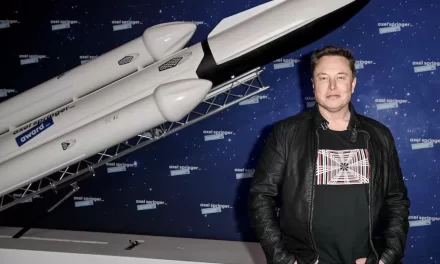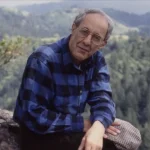Diciotto giorni: tanto è durata la “tregua” tra Israele e Hamas. Poi i raid, i morti, i bambini sotto le macerie. E mentre i mediatori parlano di tenuta dell’accordo, Washington benedice “risposte mirate”, Tel Aviv rivendica il diritto alla forza, Hamas minaccia e calcola. È una pace lessicale, non politica.
C’è un dettaglio che attraversa tutti i lanci di agenzia di queste ore: la parola tregua ricorre più della parola pace. Non è un vezzo linguistico. È la prova che la finestra aperta a Sharm el Sheikh sul “piano Trump” non ha mai avuto i cardini della politica, ma solo i ganci della contingenza. Diciotto giorni sono il tempo di un respiro nella guerra lunga di Gaza; troppo poco per sciogliere il nodo ostaggi, per ricostruire un minimo di fiducia operativa, per schermare il campo di battaglia dall’inerzia degli apparati e dalla pressione dei fronti.
La sequenza è nota: scaramucce, un soldato israeliano ucciso durante la tregua, attacchi aerei “mirati” (così li definiscono a Washington), poi l’ondata di bombardamenti con un bilancio che rimbalza tra ministeri e ospedali: almeno 104 morti, di cui 46 bambini, centinaia di feriti, pronto soccorso al collasso. Medici Senza Frontiere racconta volti, ferite, emorragie: l’anatomia di un cessate il fuoco che non cessa il fuoco. L’Onu condanna, ma la macchina dei fatti non rallenta. Alle 9 del mattino “la tregua è tornata in vigore”, annunciano da Israele. Giuridicamente plausibile, politicamente surreale.
Sul piano strategico la crisi ha quattro piani sovrapposti.
Primo: la guerra delle parole.
Per il vicepresidente americano JD Vance si tratta di “scaramucce” e “la pace reggerà”. La Casa Bianca (oggi come ieri) concede “risposte mirate” purché non salti l’accordo — un perimetro che di fatto legittima l’uso della forza entro margini negoziati a Washington. Tel Aviv parla di “minaccia imminente”, rivendica di aver eliminato militanti del 7 ottobre e fa sapere che Netanyahu ha informato Trump prima dei raid: un messaggio di allineamento politico, oltre che operativo. Hamas, dal canto suo, promette la restituzione di quattro corpi di ostaggi — la macabra contabilità che accompagna ogni tregua. Qui le parole non descrivono: producono la realtà. Se “mirato” diventa sinonimo di “tollerabile”, la linea rossa si sposta ogni giorno un passo più in là.
Secondo: la crisi umanitaria come sfondo fisso.
Nel 2025 l’OMS registra morti per malnutrizione a Gaza; gli ospedali lavorano a salti di corrente; i giornalisti uccisi sono ormai centinaia. Eppure il lessico diplomatico continua a trattare la variabile umanitaria come una voce del capitolo “conseguenze”, non come un vincolo. È la rimozione che consente di proclamare il ritorno del cessate il fuoco mentre si contano i bambini estratti dalle macerie. Finché l’umanitario resterà subalterno al militare e al negoziale, nessuna tregua diventerà pace.
Terzo: la politica interna israeliana.
La coalizione si lacera: Ben Gvir minaccia la sopravvivenza del governo se non si torna alla “guerra totale” e alla “distruzione di Hamas”. Ogni pausa operativa è vissuta come resa simbolica. È un fattore che i mediatori fingono di non vedere: senza una cornice politica in Israele (e in Palestina) capace di reggere il costo di un compromesso, ogni intesa è carta bagnata.
Quarto: l’erosione della credibilità internazionale.
L’Ue “chiede a tutte le parti di rispettare il cessate il fuoco” e ribadisce che “la via militare non è una soluzione”. È vero, ma irrilevante se non si accompagna con leve: accessi umanitari garantiti, meccanismi di verifica, condizionalità sugli armamenti. Il Qatar assicura che la tregua “reggerà nonostante le violazioni”: lo dice perché deve custodire il tavolo, ma il messaggio implicito è che la violazione è integrata nell’accordo. L’Italia, intanto, attacca la relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese: disputa legittima, ma che rischia di apparire come un diversivo mentre sul terreno saltano ambulanze e scuole.
In mezzo a tutto questo, una verità scomoda: le tregue, così come sono costruite, premiano la tattica e puniscono la strategia. Ogni pausa serve alle parti per riposizionarsi, ricomporsi, negoziare il prossimo scambio di ostaggi o di cadaveri. Il tempo politico, invece, si restringe. Chi invoca la “tenuta” del cessate il fuoco senza costruirne l’architettura sta in realtà costruendo il suo collasso.
Che cosa manca? Tre cose, chiare e sgradite.
1) Un meccanismo di verifica con costi.
Non bastano i comunicati. Serve una cellula di monitoraggio con mandato, strumenti e deterrenza: chi viola paga, subito, in termini di accessi, di sostegno, di legittimità diplomatica. Senza “costi” la tregua è una gentile raccomandazione.
2) Una cornice politica per “il giorno dopo”.
La promessa di una Forza Internazionale di Stabilizzazione resta nebulosa. Chi comanda dentro Gaza? Chi gestisce aiuti, polizia civile, scuole? Senza un comitato di gestione palestinese reale, con garanzie regionali e un perimetro israeliano di non-interferenza, la tregua non è il ponte verso la governance: è l’anticamera del caos.
3) Una linea americana coerente.
Benedire la “risposta mirata” e insieme garantire la tregua è un capolavoro di ambiguità funzionale agli equilibri interni Usa, non alla stabilità di Gaza. Se Washington è garante, deve esserlo con chiarezza: o il cessate il fuoco è un vincolo, o è una formula elastica che si spezza al primo strappo. Nel secondo caso, smettiamo di chiamarlo cessate il fuoco.
C’è poi la battaglia invisibile della memoria. Ogni raid, ogni corpo restituito, ogni ultimatum di un ministro, ogni condanna dell’Onu alimenta una narrazione che si cristallizza in identità irriducibili. E quando le identità si irrigidiscono, la politica smette di mediare e si limita ad amministrare l’odio. Lo vediamo nella retorica che trasforma la parola “genocidio” in clava, e nella contro-retorica che riduce i morti a “danni collaterali”: due linguaggi speculari che blindano, non liberano.
La domanda è semplice: vogliamo davvero che questa tregua regga? Se sì, bisogna trattare la violazione non come inevitabile “rumore di fondo”, ma come atto politico che comporta conseguenze, da qualunque parte arrivi. Bisogna legare aiuti e riconoscimento a comportamenti verificabili, non a promesse. Bisogna dire che il ritorno alla guerra non è un’opzione legittima a ogni scambio di fuoco, ma un fallimento condiviso che riduce il capitale politico di tutti — Israele incluso.
“Possiamo davvero chiamarlo cessate il fuoco?”, si chiede il medico di MSF entrando in pronto soccorso. È la domanda più onesta della giornata. Una tregua che consente bombardamenti notturni e rientra alle nove del mattino è un intervalloin una partita senza arbitro. E senza arbitro, lo sappiamo, la squadra con più forza vince l’azione, ma perde la stagione.
La pace non si firma nei comunicati, si costruisce nei vincoli. O li mettiamo, o smettiamo di illuderci. Per rispetto dei morti di oggi e dei vivi di domani, almeno chiamiamo le cose col loro nome. Qui, più che una tregua, vediamo una resa alla semantica. E la semantica, a Gaza, non salva vite.