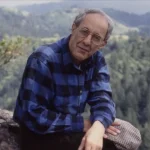Muore il leader dell’opposizione, simbolo di resistenza democratica. Il Paese affronta ora una transizione delicata tra povertà, corruzione e violenza sociale.
Con la morte di Raila Odinga, l’Africa orientale perde uno dei suoi volti più noti e controversi. Ottant’anni, più volte imprigionato, costretto all’esilio sotto il regime di Daniel arap Moi, poi primo ministro (2008-2013) dopo le sanguinose elezioni del 2007: Odinga è stato per decenni l’incarnazione dell’opposizione keniana, un uomo che ha attraversato tutti i passaggi della difficile democratizzazione del Paese.
È morto nel sud dell’India, durante una passeggiata, mentre si preparava alla candidatura alla presidenza della Commissione dell’Unione Africana: un segno di come la sua visione fosse ormai continentale, non solo nazionale. Con lui se ne va una generazione di politici che hanno creduto nella via africana alla democrazia, fatta di pazienza, dialogo e riforme graduali, ma anche di delusioni e contraddizioni.
Il padre della democrazia (incompiuta)
Figlio di Jaramogi Oginga Odinga, storico oppositore del primo presidente Jomo Kenyatta, Raila aveva ereditato non solo un nome, ma una missione: fare del Kenya uno Stato più giusto e pluralista.
Il suo ruolo negli accordi di condivisione del potere del 2008, che evitarono al Paese una guerra civile dopo oltre mille morti per scontri etnici e politici, resta il momento più alto della sua carriera. Da allora, però, il sogno di un Kenya riconciliato si è infranto contro l’élite corrotta e la violenza sociale, che ancora oggi dividono il Paese tra ricchezza tecnologica e povertà diffusa.
Un’eredità difficile
Odinga non era un santo. Spesso accusato di populismo e di una certa ambiguità ideologica, rimane tuttavia il volto politico che ha saputo dare voce ai disillusi: ai giovani senza lavoro, ai contadini espropriati, alle periferie abbandonate. Il suo carisma personale – laico ma non ostile alla fede – gli aveva conquistato una base trasversale, capace di parlare alle diverse etnie.
La sua scomparsa apre ora un vuoto politico e simbolico. Nessun leader sembra in grado di raccogliere la sua eredità, né nel suo partito, l’Orange Democratic Movement (ODM), né in un’opposizione frammentata e indebolita dal clientelismo.
Kenya, un Paese in bilico
Il Kenya di oggi, nonostante il boom tecnologico e turistico, è un Paese sull’orlo dell’instabilità.
La crescita economica non ha ridotto la povertà, la corruzione mina la fiducia nelle istituzioni, e la recente ondata di proteste giovanili contro il carovita e la disoccupazione ha rivelato la fragilità del sistema.
Molti temono che l’assenza di Odinga – capace di canalizzare il dissenso dentro i confini democratici – lasci campo libero a derive violente o autoritarie.
La necessità del dialogo
In queste ore, i vescovi keniani, attraverso mons. Martin Kivuva, hanno espresso “profonda tristezza” e un appello al Paese perché “la morte di Raila Odinga non diventi un pretesto per nuovi scontri, ma un’occasione per ritrovare l’unità nazionale”.
È la via del dialogo, quella che lo stesso Odinga invocava nei suoi ultimi discorsi: “Non possiamo costruire la democrazia bruciando le nostre case. La libertà non si conquista con l’odio, ma con la speranza.”
La sua eredità politica è complessa, ma la sua eredità morale resta chiara: la democrazia non è un bene conquistato una volta per tutte.
E nel Kenya che piange il suo “vecchio leone”, il futuro dipenderà da chi saprà farne una lezione, non un ricordo.