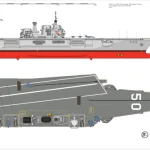Un rapporto dell’intelligence colombiana svela come il nuovo potere dei narcos si annidi nei consigli d’amministrazione di club calcistici e imprese di vigilanza. È il volto “manageriale” della criminalità globale, che ha imparato a confondersi con l’economia legale.
Il narcotraffico non ha più bisogno di mitragliatrici, né di corridoi clandestini nella giungla. Oggi preferisce i corridoi dei consigli d’amministrazione, gli stadi affollati e i contratti di sicurezza privata. La Colombia, cuore pulsante di un mercato che muove miliardi di dollari e tonnellate di cocaina, si trova ancora una volta davanti allo specchio di sé stessa. Ma il riflesso è cambiato. I boss non portano più catene d’oro o camicie hawaiane: portano cravatte, parlano di governance e sponsorizzano squadre di calcio.
Un rapporto della Direzione Nazionale di Intelligence ha reso visibile l’invisibile: la “Nueva Junta del Narcotráfico” (NJN), erede silenziosa dei vecchi cartelli, si muove ora attraverso attività perfettamente legali. Squadre di calcio professionistiche e società di sicurezza privata diventano i suoi strumenti prediletti. La ragione è semplice: visibilità sociale e invisibilità finanziaria. Il calcio fornisce un flusso costante di denaro — biglietti, sponsorizzazioni, trasferimenti — e una copertura affettiva che disarma ogni sospetto. Chi osa indagare su un club amato rischia di essere accusato di profanare un simbolo nazionale.
Tra i nomi citati dagli 007 colombiani compare quello di Luis Eduardo Méndez Bustos, presidente del club Santa Fe, già avvocato difensore di narcotrafficanti storici come Julio Lozano Pirateque, il patriarca di un sistema criminale oggi rinato sotto sigle nuove e metodi raffinati. L’altro volto di questa alleanza è Edgar Páez Cortés, ex presidente del Tigres F.C., assassinato nel 2023, che secondo il rapporto avrebbe avuto legami diretti con il traffico interno e con le scommesse illegali. Due uomini, due club, due indizi di una contaminazione più ampia: lo sport come zona grigia tra legalità e potere, dove la passione popolare fa da scudo all’economia criminale.
La seconda frontiera è quella della sicurezza privata, settore in espansione e sempre più cruciale nelle metropoli latinoamericane. Le società di vigilanza non solo ottengono contratti pubblici milionari, ma gestiscono licenze per armi, certificati di scorta, appalti per la protezione di infrastrutture sensibili. Alcune, come “Hidra Seguridad” o “Seguridad Oriental”, citate nel rapporto, avrebbero rilasciato documenti e autorizzazioni a membri del Clan del Golfo, il gruppo armato più potente del Paese. In un contesto dove la fiducia nelle forze di polizia è fragile, le imprese di vigilanza diventano parastati, territori autonomi di legalità apparente dove il crimine ottiene ciò che lo Stato non riesce più a controllare: il monopolio della forza.
Ciò che inquieta è la capacità di ibridazione: la NJN non è un cartello nel senso classico del termine. È una rete diffusa, una holding transnazionale che lega il traffico di droga al business degli smeraldi, ai porti commerciali, alle società immobiliari, al mercato del pallone. La regia non è più a Medellín, ma in una costellazione di capitali globali — da Madrid a Dubai, da Istanbul a Quito — dove la linea tra economia legale e riciclaggio si fa sempre più sottile.
A differenza dei narcos di ieri, quelli di oggi non vogliono più comandare con la paura, ma governare con la rispettabilità. Comprano il consenso, sponsorizzano eventi sportivi, finanziano opere sociali, e intanto investono nei sistemi che dovrebbero garantire sicurezza. È una logica perfetta, quasi elegante: più la società si sente minacciata, più aumenta la domanda di sicurezza privata; più aumenta la domanda, più si rafforza chi la controlla.
In questo schema, lo Stato perde centralità. Le autorità, spiazzate da una criminalità che si muove tra i codici fiscali e i bilanci societari, rincorrono ombre. La “lotta alla droga”, così com’è stata concepita negli ultimi decenni, appare ormai un esercizio retorico. Non si combatte più contro un cartello, ma contro un ecosistema. E gli ecosistemi non si arrestano: si riformano, si infiltrano, si espandono.
La Colombia non è un caso isolato. Lo stesso modello si replica in Messico, in Turchia, nei Balcani, e in parte anche in Europa. Il calcio, con le sue finanze opache e i suoi protagonisti in bilico tra sport e affari, è un terreno ideale per il riciclaggio di capitali. Le società di sicurezza, proliferanti e difficilmente monitorabili, diventano la nuova frontiera di un potere invisibile che offre “protezione” mentre erode la sovranità dello Stato.
Questa nuova era del narcotraffico non uccide solo con la violenza, ma con la legittimità sociale. I boss non temono più la galera: temono il discredito. E per evitarlo, si comprano l’immagine, la narrazione, la divisa, lo stemma. Non vogliono essere chiamati criminali, ma imprenditori.
Il paradosso è che la società — distratta, appassionata, polarizzata — non se ne accorge. Quando il calcio segna, non si chiede chi paga il pallone. Quando un vigilante presidia un condominio, nessuno si domanda chi lo arma. Ma dietro queste scene di normalità si muove una silenziosa privatizzazione del potere, in cui i confini tra legalità e crimine si confondono fino a diventare indistinguibili.
La vera minaccia non è più la droga: è l’idea che tutto possa essere comprato, anche la fiducia pubblica. È la nascita di un ordine parallelo, dove il narcotraffico non si impone, ma si insinua. E quando la criminalità non deve più corrompere lo Stato perché è diventata parte della sua economia, allora la partita è già finita. Solo che questa volta, a vincere, non sono più i boss in fuga: sono i soci invisibili, quelli seduti in tribuna vip.