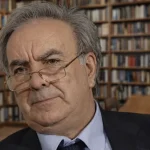Nuova proposta di legge sulla violenza sessuale
C’è un tratto tutto italiano che ritorna come una mareggiata: destra e sinistra possono dividersi su tutto, ma quando si tratta di dimostrarsi inflessibili sulla sicurezza, improvvisamente si ritrovano. È accaduto ancora, con la nuova legge sui reati sessuali che introduce un rovesciamento pericoloso: non sarà più chi accusa a dover provare ciò che afferma, ma chi è accusato a dover dimostrare la propria innocenza.
È un colpo al cuore della nostra Costituzione, che all’articolo 27 ricorda senza esitazioni: «L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».
Un principio nato dalle tragedie del Novecento, non da un formalismo astratto.
La buona intenzione è evidente: proteggere le donne. Ma una buona intenzione non basta a fare una buona legge. Anzi, a volte – come scriveva Manzoni – «il buon cuore, quando non è sorretto da buoni lumi, è causa dei mali maggiori». E proprio qui si annida l’equivoco.
La violenza sessuale è un dramma reale, durissimo, che richiede strumenti efficaci, non simbolici. Ma invertire l’onere della prova non renderà una donna più al sicuro: renderà la giustizia più fragile. Perché in un sistema in cui tocca all’imputato dimostrare di non aver commesso il fatto, basta pochissimo per rovinare un’esistenza: una lite che degenera, una parola di troppo, un messaggio frainteso, un rancore custodito troppo a lungo. Senza un’indagine solida, senza riscontri, senza testimonianze verificate, la verità rischia di trasformarsi in un conflitto fra versioni.
E chi conosce la realtà delle aule di tribunale sa bene dove si annida il vero ostacolo: non nella presunzione d’innocenza, ma nella capacità dello Stato di accompagnare le vittime con tempestività, competenza, protezione. La giustizia italiana fatica a custodire chi denuncia: i tempi sono lunghi, i fascicoli si accumulano, i procedimenti si interrompono, e non di rado il percorso si trasforma in una seconda ferita. Troppe donne rinunciano prima ancora di essere ascoltate da un giudice. Non per sfiducia nelle garanzie costituzionali, ma per stanchezza davanti a un sistema che procede a passo lento quando la sofferenza chiede velocità.
Per questo dire che “serve più durezza” non significa cambiare le regole del diritto: significa far funzionare ciò che già abbiamo. Processi che non si trascinino per anni; operatori formati ad accogliere senza giudicare; indagini che partano subito; strutture che sostengano le vittime, non che le abbandonino. Una comunità civile che protegge le donne non cerca scorciatoie giuridiche, cerca verità con metodo e rispetto.
Capovolgere l’onere della prova, invece, non aiuta né le vittime né gli imputati innocenti. Crea solo un terreno scivoloso, dove la tentazione del “giustizialismo morale” prende il posto della giustizia. E quando un principio costituzionale viene piegato una volta, la tentazione di farlo ancora cresce. Chi difende la presunzione d’innocenza non difende un colpevole: difende il diritto di tutti a non essere consegnati all’arbitrio.
È qui che entra in gioco la responsabilità politica.
Una democrazia si misura non dalla severità delle sue pene, ma dalla solidità delle sue garanzie. Non dalla velocità con cui indica un colpevole, ma dalla cura con cui cerca la verità. E la verità, senza metodo, non è mai verità: è impressione, sospetto, eco emotiva.
La violenza contro le donne deve essere combattuta con determinazione assoluta. Ma la determinazione, senza discernimento, diventa cieca. E ciò che nasce come protezione rischia di trasformarsi in un nuovo terreno d’ingiustizia.
La giustizia non si rafforza contro la Costituzione, ma dentro la Costituzione.
Ed è proprio nelle ore più difficili che una comunità civile deve ricordarlo.