L’illusione dell’intimità nell’era dei chatbot e la sfida etica per la cultura digitale
OpenAI apre le porte all’erotismo digitale, promettendo conversazioni “per adulti” su ChatGpt. Ma dietro l’idea di “trattare gli adulti come adulti” si nasconde una mutazione profonda: la trasformazione del desiderio umano in simulazione algoritmica. Analizziamo* le implicazioni etiche e spirituali di un’intimità senza corpo e senza volto, dove l’amore rischia di diventare un prodotto di consumo e la solitudine, un mercato globale.
OpenAI ha annunciato che, da dicembre, consentirà contenuti erotici su ChatGpt, accessibili agli adulti con verifica dell’età.
Un passo che Sam Altman, CEO dell’azienda, ha definito un modo per “trattare gli adulti come adulti”.
Ma dietro questa formula di apparente libertà si nasconde una questione antropologica e spirituale ben più profonda: che cosa resta dell’umano quando l’intimità diventa simulazione, e l’erotismo viene delegato a un algoritmo?
Non si tratta solo di un cambiamento di policy aziendale: è un passaggio di soglia nella cultura digitale, dove la linea tra comunicazione e seduzione, tra compagnia e compensazione, diventa sempre più sottile.
I chatbot, nati come strumenti di dialogo cognitivo, stanno evolvendo in simulatori emotivi, capaci di creare un’illusione di reciprocità, fino a sostituire la relazione vera con una proiezione artificiale del desiderio.
L’eros disincarnato
L’erotismo, nella visione cristiana, non è un peccato da reprimere ma una forza vitale da trasfigurare. È il linguaggio del corpo che diventa dono, promessa, comunione.
Ridurlo a una conversazione con una macchina significa spezzare il legame tra desiderio e alterità, cancellare l’altro come volto e come mistero.
È la vecchia tentazione gnostica in versione digitale: un amore senza corpo, un piacere senza responsabilità, un’intimità senza ferite.
Quando un’IA “impara” a simulare il desiderio umano, in realtà non ama né desidera, ma riproduce — con precisione algoritmica — i segni esterni dell’affettività. È un eros “disincarnato”, privo di reciprocità e di rischio, che alimenta un narcisismo solitario: l’uomo che parla con se stesso attraverso una macchina programmata per compiacerlo.
La falsa tenerezza delle macchine
I casi di dipendenza affettiva da chatbot, o le tragedie legate alla “psicosi da intelligenza artificiale”, mostrano che la simulazione dell’empatia è una droga potente.
Dietro la promessa di compagnia, questi sistemi alimentano la solitudine.
Il giovane che si confida con un assistente virtuale erotizzato non trova uno sguardo che lo accolga, ma un riflesso che lo conferma.
La relazione umana, per quanto fragile e complessa, è sempre un incontro tra libertà; l’interazione con l’IA è un monologo travestito da dialogo.
Per questo l’apertura ai contenuti erotici non è un semplice “aggiornamento di prodotto”: è un’operazione di mercato che sfrutta la vulnerabilità emotiva.
Dietro la retorica della libertà adulta, si intravede la logica del profitto: monetizzare il bisogno d’amore trasformandolo in consumo digitale.
L’etica del discernimento
Papa Francesco, nei suoi messaggi per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, ha più volte ricordato che la tecnologia non è neutra:
“Ogni strumento porta in sé una visione dell’uomo e della realtà.”
E nel recente Message on AI and Human Dignity (2024), Leone XIV ha ribadito che la dignità non si programma, si custodisce.
L’uso dell’intelligenza artificiale, anche nei contesti più privati, deve partire da una domanda radicale: “Questo strumento accresce o impoverisce la mia umanità?”
Un discernimento evangelico sull’IA non può limitarsi a valutare i rischi, ma deve interrogare i fini.
Se la tecnologia serve la comunione, è un dono; se alimenta l’isolamento e l’autoreferenzialità, è una forma di alienazione.
Per questo la comunità cristiana, le università e i centri di ricerca cattolici dovrebbero promuovere un’educazione affettiva digitale, capace di restituire all’eros la sua verità relazionale e simbolica.
Il compito della Chiesa
La risposta non è censura, ma presenza sapienziale.
Non si tratta di “moralizzare” la rete, ma di abitare la cultura tecnologica con sguardo umano, aiutando le persone a riconoscere ciò che genera vita e ciò che la consuma.
Serve un’etica della relazione incarnata, che ricordi — contro ogni surrogato artificiale — che il corpo dell’altro è sacramento di realtà, non un’interfaccia da programmare.
In un mondo dove anche l’erotismo diventa algoritmo, il Vangelo resta l’unico linguaggio che non mente sul desiderio: quello che unisce la carne e lo spirito nell’amore che dà la vita.
———————-
*L’Autore è socio della Pontificia Accademia Mariana Internationalis dove insegna comunicazione e bioetica





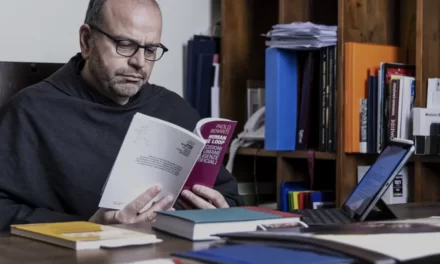



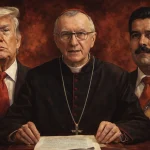









Mi stavo chiedendo quali implicazioni morali di fronte a questa novità e come la Chiesa stia reagendo nella sua funzione di madre e maestra per i credenti. Un sincero grazie all’autore.
Grazie per l’articolo prof. Bruno!