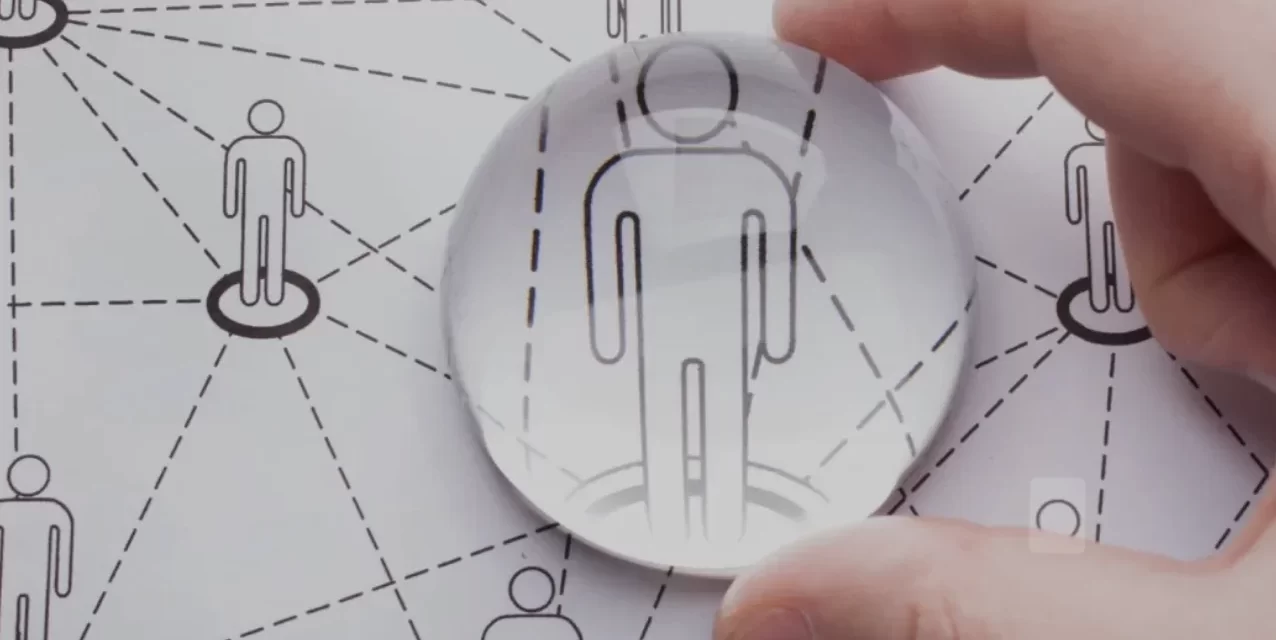La dignità si rivela insieme antropologica e teologica, filosofica e giuridica, morale e politica. È la premessa e il fine, la radice e la fioritura, il linguaggio comune e il principio ultimo. Essa non solo fonda l’edificio dei diritti, ma ne custodisce il senso: è, realmente, l’architrave invisibile della giustizia universale.
La dignità umana si impone allo sguardo della ragione come un assioma indimostrabile e tuttavia indubitabile, come verità che non necessita di fondamento ulteriore perché fonda essa stessa ogni altro discorso. Non deriva da un potere costituente, perché lo precede e lo trascende; non si consuma in un’astrazione concettuale, perché vive nel concreto esistere di ogni persona. Tale evidenza si è rivelata con forza particolare all’indomani delle tragedie del Novecento, quando la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ne ha proclamato solennemente l’intangibilità, collocandola nel cuore della libertà, della giustizia e della pace. Quel testo epocale non ha solo raccolto il grido delle vittime e le macerie di un’umanità ferita, ma ha costituito un orizzonte condiviso: una barriera invalicabile contro ogni riduzionismo utilitarista, una misura ultima capace di resistere al potere della tecnica e della politica.
Non a caso le costituzioni del dopoguerra hanno posto la dignità al centro del proprio dettato: la Grundgesetz tedesca si apre con l’affermazione che “la dignità dell’uomo è intangibile”, proclamandola Grundnorm da cui discendono tanto la legittimità del potere quanto la struttura dei diritti fondamentali; la Costituzione spagnola del 1978 la riconosce quale fondamento dell’ordine politico e della pace sociale; la Costituzione italiana, pur senza un articolo unitario, la fa risuonare come respiro sotterraneo nell’intero testo, dall’articolo 2 sui diritti inviolabili alla pari dignità sociale dell’articolo 3, dal diritto del lavoratore ad una vita libera e dignitosa dell’art. 36 al limite imposto all’iniziativa economica dall’art. 41; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea la proclama fin dal primo articolo come inviolabile, quasi pietra angolare dell’intero edificio giuridico.
Qui la dignità si rivela non come concessione, non come premio, non come merce revocabile, ma come dato ontologico che appartiene ad ogni uomo in quanto tale. La tradizione filosofica e teologica ha illuminato questo dato con parole convergenti. Boezio vide nella “sostanza individuale di natura razionale” la radice della persona; Tommaso d’Aquino riconobbe nella razionalità e libertà dell’essere umano la sua singolare altezza; Kant ne colse la grandezza nel suo essere fine e mai mezzo, affermando che la persona “non ha prezzo, ma dignità”. In questa linea, la modernità, pur nelle sue tensioni, ha riscoperto la dignità come cifra ultima della libertà. Essa non è dunque concetto accessorio, ma premessa ineludibile di ogni giustizia universale, architrave invisibile che sostiene la legittimità delle istituzioni e la fecondità delle relazioni sociali.
Dignità come principio architettonico del diritto
Se la dignità è premessa, essa diventa anche criterio: misura della giustizia, fondamento della legittimità, forza normativa che orienta il diritto. Nessun ordinamento può dirsi autenticamente giuridico se non la riconosce come suo principio architettonico; nessuna autorità politica è legittima se non assume la dignità come limite invalicabile; nessuna economia è giusta se non ne fa bussola delle proprie dinamiche. La dignità opera come principium regulativum e come clavis hermeneutica: non resta mera enunciazione teorica, ma plasma l’interpretazione costituzionale, ispira le decisioni giurisprudenziali, permea la cultura politica. Le corti costituzionali e sovranazionali ne hanno dato testimonianza eloquente.
In Germania, la tutela della dignità ha guidato la giurisprudenza sul trattamento dei detenuti, imponendo che nessuna restrizione di libertà si traduca in annullamento della persona. In Italia, la Corte costituzionale l’ha invocata in ambiti cruciali, dal lavoro alla salute, dalla tutela della vita al fine vita, mostrando come la dignità sia criterio per concretizzare condizioni di esistenza realmente degne. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha letto i divieti di tortura e di trattamenti inumani o degradanti come protezione immediata della dignità.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea l’ha affermata come limite invalicabile all’uso delle biotecnologie, evitando la riduzione della vita a materiale sperimentale. Persino oltre l’Europa, la dignità appare stella polare: la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli la proclama valore intrinseco, la Carta araba dei diritti umani la pone come premessa necessaria, mentre molte costituzioni latinoamericane e asiatiche la elevano a principio supremo. Questa convergenza globale testimonia che la dignità costituisce un patrimonio comune dell’umanità, un linguaggio universale che, pur espresso in forme diverse, custodisce un nucleo antropologico inaggirabile. Essa si rivela come forza dialogica e diplomatica, capace di offrire alle culture uno spazio di incontro senza annullamento, di riconoscimento reciproco senza dissoluzione, di arricchimento senza sopraffazione.
La dignità nell’orizzonte delle nuove sfide universali
La dignità non è concetto statico, ma principio vivo, chiamato ad interpretazioni sempre nuove. Le sfide del nostro tempo la pongono a verifica, rivelandone al contempo la forza e la necessità. La bioetica e le biotecnologie la interrogano sul senso del limite, opponendo all’onnipotenza tecnica la misura dell’intangibile umano. L’intelligenza artificiale la chiama a impedire che l’uomo sia sostituito dalla macchina o ridotto a dato.
Le migrazioni sollecitano a guardare ai volti concreti e non a cifre demografiche, ricordando che ogni vita porta in sé una dignità che nessuna frontiera può negare. Le diseguaglianze globali ammoniscono che la dignità non tollera esclusioni né scarti, e che un’economia che ignora l’uomo lo degrada a ingranaggio. La crisi ecologica, infine, mostra come senza dignità anche la natura venga degradata a risorsa, dimenticando che l’umanità è custode e non dominatrice. La dignità è dunque asse che connette giustizia e pace. Non c’è pace senza dignità, e non c’è giustizia laddove essa è violata. La storia lo conferma: ogni schiavitù, colonizzazione, genocidio nasce dalla negazione della dignità; ogni processo di liberazione e riconciliazione dalla sua riaffermazione. Essa non è un concetto monocorde, ma una sinfonia di linguaggi: nella tradizione occidentale si radica nella dignitas hominis, nella libertà e razionalità; nelle culture africane trova espressione nell’ubuntu; in quelle asiatiche nell’armonia cosmica; nell’Islam nella karāma, dono divino universale.
Questa pluralità non ne indebolisce l’universalità, ma la esalta: come melodia che diversi strumenti interpretano, conserva la stessa armonia di fondo.