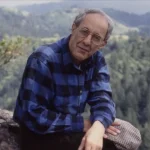L’attacco israeliano a Sanaa è solo un tassello nel disegno più ampio del premier: isolare l’Iran, legittimare la pressione militare e riposizionarsi nella partita globale del Medio Oriente.
L’attacco aereo israeliano sull’aeroporto di Sanaa, capitale dello Yemen controllata dagli Houthi, ha provocato almeno tre morti e 38 feriti. Un’azione di ritorsione – secondo la versione ufficiale di Tel Aviv – per la recente ondata di droni e missili lanciati dai ribelli yemeniti verso l’aeroporto di Tel Aviv. Ma in realtà, il raid israeliano assume un significato molto più ampio nella cornice del confronto strategico in Medio Oriente.
Benjamin Netanyahu ha immediatamente accusato l’Iran di essere il vero mandante dell’attacco, sostenendo che senza Teheran gli Houthi non sarebbero in grado di colpire Israele. Con questa affermazione, il premier israeliano compie un doppio salto logico e politico: trasforma un conflitto asimmetrico regionale in un capitolo del duello diretto con la Repubblica islamica, e allo stesso tempo ribadisce l’equazione geopolitica secondo cui ogni minaccia proveniente da sud o da est è riconducibile a un’unica regia: quella di Teheran.
Si tratta di una strategia coerente con la postura adottata da Israele dopo il 7 ottobre 2023. Il governo israeliano, messo sotto pressione interna per la gestione della guerra a Gaza e per le crescenti critiche internazionali, ha bisogno di un nuovo terreno di legittimazione: spostare l’attenzione verso l’Iran serve a rafforzare la narrazione securitaria, consolidare l’alleanza con gli Stati Uniti e riattivare le reti diplomatico-militari con gli attori sunniti moderati, spaventati dall’espansionismo sciita.
Non a caso, l’attacco a Sanaa ha visto la partecipazione americana. Anche se il presidente Trump ha successivamente dichiarato la fine dei raid statunitensi in Yemen, definendo gli Houthi “capitolati”, è evidente che l’azione congiunta rappresenti un messaggio a più livelli: contenere l’asse Tehran-Sanaa, mostrare prontezza operativa e testare la reattività dell’Iran in un momento di incertezza regionale.
Il problema, tuttavia, è che ogni colpo assestato agli Houthi rischia di alimentare un’escalation a geometria variabile. Il movimento sciita yemenita, armato e formato dall’Iran ma dotato di una propria logica politico-militare, ha già promesso una “risposta all’altezza”. E se gli attacchi dovessero proseguire, il Mar Rosso – già messo in crisi dal blocco delle rotte commerciali – potrebbe tornare ad essere una linea del fuoco permanente.
Inoltre, l’intenzione dichiarata da Netanyahu di colpire direttamente l’Iran apre scenari ancor più critici. Se da un lato Tel Aviv può contare su superiorità tecnologica e sostegno occidentale, dall’altro un’azione contro obiettivi iraniani rischia di provocare una risposta su più fronti: in Iraq, in Siria, in Libano e nel Golfo. L’Iran potrebbe non colpire in modo simmetrico, ma attivare le sue reti regionali per alzare il prezzo dell’aggressione.
Da questo punto di vista, il raid su Sanaa è un avvertimento ma anche un test. Israele misura la reazione dell’Iran, sonda la solidità delle alleanze regionali e osserva la postura americana. Trump, pur abituato a dichiarazioni muscolari, ha mostrato scarso interesse per un’escalation duratura in Medio Oriente. Ma una visita imminente nella regione potrebbe cambiare le carte.
Intanto, in Israele, la crisi politica interna preme: le manifestazioni delle famiglie degli ostaggi continuano, la pressione economica legata alla mobilitazione militare cresce, e l’avvicinarsi del processo a carico dello stesso Netanyahu rende la guerra – ancora una volta – una variabile utile per la sopravvivenza del potere.
In conclusione, il bombardamento su Sanaa non va letto come un episodio isolato, ma come parte di una strategia più vasta: quella di spostare l’asse del conflitto da Gaza a Teheran, passando per ogni possibile frontiera della “minaccia iraniana”. Una mossa che promette legittimità, ma rischia di incendiare l’intero scacchiere mediorientale.