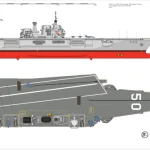C’è un modo di parlare di carità che consola tutti tranne le vittime: è il linguaggio del “non riapriamo ferite”, del “guardiamo avanti”, del “perdoniamo e basta”. Ma la carità cristiana non è anestesia: è luce. E la luce — quando entra — fa bene, anche se brucia.
Partire da un elzeviro che ha rimesso a fuoco una vicenda controversa non significa “fare processi” né coltivare risentimenti. Significa, più semplicemente e più radicalmente, restituire alla carità il suo spessore evangelico: quello di un amore che non teme la verità, perché sa che la verità è un bene per la comunione. La carità, infatti, non è l’arte di rendere il male invisibile; è l’arte di impedirgli di diventare norma.
C’è una frase che, detta a mezza voce, avvelena molte comunità: “Sì, però… è il fondatore.” Da quel “però” in poi il Vangelo comincia a essere addomesticato. Perché il “fondatore” (o chi viene percepito come tale) diventa una zona franca morale: ciò che per gli altri sarebbe abuso, per lui diventa “carisma”; ciò che per chiunque sarebbe manipolazione, per lui diventa “esigenza spirituale”; ciò che sarebbe illegittimo diventa “eccezione provvidenziale”. Ed ecco la caricatura più pericolosa della vita consacrata: una fraternità dove Cristo è sullo sfondo e la figura dominante al centro.
Qui si comprende un punto decisivo: presentare le ferite fa bene a chi le ha subite. Non perché la memoria sia vendetta, ma perché il silenzio è una seconda violenza. La vittima non chiede innanzitutto punizioni: chiede che il reale venga riconosciuto. Chiede che non si faccia finta. Chiede che la sua percezione non venga riscritta come “interpretazione”, “fragilità”, “mancanza di fede”. Dare parola alle ferite è restituire dignità, e la dignità è già una forma di guarigione.
E fa bene anche alla comunità, perché la salva dalla spiritualizzazione dell’ingiustizia: quel meccanismo per cui tutto viene letto come “croce” da portare, senza mai chiamare il male col suo nome. Ma una croce non è un abuso. E confonderli non santifica nessuno: santifica il potere e umilia i piccoli.
C’è poi un altro punto, forse ancora più impopolare ma essenziale: notiziare ciò che è stato oggetto di disinformazione fa bene alla verità. In un’epoca in cui la reputazione è spesso più importante della realtà, la disinformazione non serve solo a “proteggere l’immagine”: serve a proteggere un sistema. E un sistema, quando teme la verità, sta già confessando la propria fragilità morale. La Chiesa non è una società segreta; è un popolo chiamato alla luce. La trasparenza — quando è ordinata, prudente, rispettosa — non è un lusso moderno: è un esercizio di responsabilità evangelica.
Qualcuno dirà: “Ma così si scandalizza”. Eppure lo scandalo vero non è la verità detta con carità: è l’abuso coperto con devozione. È l’ingiustizia benedetta. È il male reso intoccabile perché rivestito di linguaggio religioso. La disinformazione è il contrario della carità perché rende impossibile il discernimento: impedisce alle persone di capire, di proteggersi, di imparare. E soprattutto impedisce alla comunità di rileggere la propria storia in modo adulto, evitando che gli errori diventino tradizione.
Qui tocchiamo il nodo teologico: il perdono è bellissimo, ma non è magia. Il perdono cristiano non è un colpo di spugna sul reale. Io posso perdonare un torto — e devo tendere a farlo — ma il torto deve essere riconosciuto, altrimenti non si perdona: si rimuove. E la rimozione non salva: prepara il ritorno del medesimo. Il perdono senza verità scivola nel bonismo; e il bonismo, in comunità, diventa il migliore alleato degli abusi, perché consegna ai potenti un’arma perfetta: “Se parli, sei rancoroso; se taci, sei buono.”
La carità, invece, è esigente. Non umilia la verità per proteggere la pace apparente. Non chiede alle vittime di fare da tappeto “per il bene dell’Opera”. Qui c’è una lezione che vale per ogni famiglia religiosa e per ogni istituzione ecclesiale: l’Opera non è mai più importante delle persone. Se un carisma diventa pretesto per ferire, allora quel carisma è già stato tradito.
Per questo, anche quando si è costretti — per amore della verità e della Chiesa — a rimettere ordine nelle parole e nei ruoli, lo si fa per carità, non per accanimento: chiamare iniziatore storico chi non può più essere presentato come fondatore carismatico non è un insulto, ma un atto di igiene spirituale. Vale anche per casi noti e dolorosi, come quello di P. Stefano M. Manelli: la storia, quando viene riportata alla sua verità, smette di essere mito e torna a essere maestra. E una comunità cresce quando impara a distinguere tra carisma e potere, tra paternità e controllo, tra obbedienza e autarchia.
Alla fine, il punto è semplice e terribile: Cristo va rimesso al centro. Non la paura di perdere prestigio, non l’ansia di difendere una narrazione, non l’istinto tribale di “proteggere i nostri”. Cristo al centro significa anche Chiesa al centro: cioè una comunione che accetta regole, discernimenti, verifiche; una comunione che non divinizza nessuno; una comunione che non scambia la fedeltà con l’omertà.
La carità è la forma più alta della verità, e la verità è la forma più concreta della carità. Dire questo oggi, con serenità e senza isterie, è già un servizio: alle vittime, alla comunità, e alla Chiesa stessa. Perché solo una carità che sa guardare in faccia il reale può guarire. E solo una verità detta con carità può convertire senza distruggere.