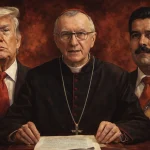La canonizzazione di un convertito che trasformò la sua cecità in visione di fede e di carità
È la storia di un uomo che, come Paolo sulla via di Damasco, vide un’altra luce. Non quella degli occhi, che stava perdendo, ma quella del cuore, che Dio gli restituì nella fede. Bartolo Longo, avvocato pugliese, ex spiritista e anticlericale, è da domenica 20 ottobre 2025 santo della Chiesa: canonizzato come testimone luminoso della misericordia, della ragione ritrovata e della carità operosa. Una vita che sembra scritta per i nostri tempi, smarriti tra il bisogno del soprannaturale e il rischio dell’inganno spirituale.
Dallo spiritismo alla conversione
Nato a Latiano, nel Salento, nel 1841, Bartolo era un giovane brillante, inquieto e affascinato dalle mode del suo tempo.
Durante gli studi di diritto a Napoli, si lasciò trascinare dallo spiritismo e dalle pratiche occultistiche che si diffondevano tra i circoli laici e borghesi dell’Ottocento.
Arrivò persino a ricevere una sorta di “ordinazione spiritica” come sacerdote di un culto esoterico.
Ma la sua anima, in cerca di assoluto, fu travolta dal vuoto.
La salute si spezzò, la mente si oscurò, cominciò a perdere la vista.
E fu allora, nel momento della massima disperazione, che un amico — il domenicano Alberto Radente — gli parlò di Cristo come unica luce.
«Chi invoca Maria, non può perire», gli disse.
Bartolo si inginocchiò, confessò la sua vita e cominciò il suo cammino di ritorno.
Fu il suo piccolo “Damascus”: dalle tenebre dello spiritismo alla luce della fede.
Pompei: il deserto che divenne santuario
Nel 1872, per una causa legale, Bartolo si recò nella valle di Pompei, all’epoca una distesa desolata di ruderi e superstizioni popolari.
Scrisse:
“Trovai un popolo di poveri e ignoranti, immerso nell’ozio e nell’empietà. Compresi che quella era la mia missione.”
Da quell’incontro nacque una compassione concreta: evangelizzare e sollevare il popolo.
Fu lui a portare tra i contadini il rosario, a insegnare loro che la preghiera non era magia ma fiducia.
E la Provvidenza si servì di un segno: un quadro della Vergine del Rosario, trovato malridotto in un convento di Napoli e collocato in una chiesetta fatiscente di Pompei.
Da quel quadro, raccontano le cronache, partirono guarigioni e conversioni, e la fama dei miracoli attirò pellegrini da tutta Italia.
Il Santuario di Pompei cominciava così: con una tela consunta, un laico convertito e una fede che ricostruiva pietra dopo pietra.
Con la contessa De Fusco, un’opera per i poveri
Accanto a Bartolo Longo ci fu una donna, la contessa Marianna De Fusco, vedova nobile e pia, che condivise con lui il sogno di una città di carità.
Insieme fondarono istituzioni per orfani, figli di carcerati, giovani abbandonati e poveri.
Pompei non divenne solo un santuario di pietra, ma un laboratorio di misericordia sociale.
In un’Italia segnata da povertà e analfabetismo, la loro opera anticipò il moderno welfare cristiano: scuole, laboratori, collegi e case-famiglia.
Bartolo diceva:
“Il Rosario non è solo preghiera: è opera. Se ami Maria, ama anche i poveri suoi figli.”
E non mancò la dimensione culturale: fondò una tipografia e un giornale, Il Rosario e la Nuova Pompei, per diffondere la devozione e la cultura cristiana in un’epoca di scristianizzazione e materialismo.
Un santo laico che comprese la potenza educativa dei media, ben prima che la Chiesa ne facesse un tema pastorale.
Una fede che diventa città
Chi oggi arriva a Pompei vede una città costruita intorno a una fede viva.
Il santuario mariano, con le sue cupole imponenti e la folla dei pellegrini, è un simbolo della rinascita spirituale che può scaturire anche da un cuore traviato.
Pompei è il miracolo di una conversione diventata architettura, dove la pietra racconta la misericordia.
Ogni mattina, il Rosario e la Supplica scritta da Bartolo Longo — recitata ogni prima domenica di ottobre e l’8 maggio — fanno vibrare ancora la voce di quel santo che si sentiva “figlio della perdizione” e che Maria trasformò in apostolo della luce.
Oggi Pompei è molto più di una meta di pellegrinaggio: è una città-icona della fede che si fa carità, dell’educazione che riscatta, della cultura che evangelizza.
E il suo fondatore resta un segno di speranza per quanti, come lui, hanno cercato nelle tenebre una luce che non abbaglia ma guarisce.
“Chi diffonde il Rosario, si salva”, scriveva Bartolo Longo. E lui, convertito, giornalista, apostolo e santo, ne è la prova vivente.