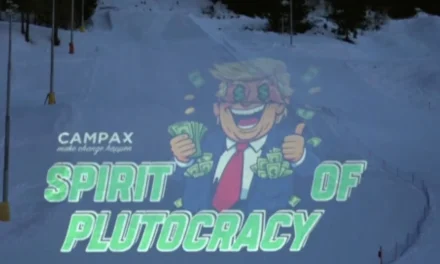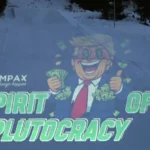C’è un’immagine che, in questi giorni, ha fatto il giro del mondo: Mahmūd Abbās, detto Abu Mazen, che stringe la mano a Papa Leone XIV in Vaticano e, poco dopo, a Sergio Mattarella al Quirinale. Un gesto che, sul piano simbolico, parla di riconoscimento, di attenzione, di speranza. Ma basta scostare un poco il velo della retorica per rendersi conto che, sul terreno, la realtà resta drammaticamente immobile — e forse peggiora di giorno in giorno.
Le dichiarazioni ufficiali sono quelle di sempre: «Due popoli, due Stati», «pace giusta e duratura», «fine della violenza». Parole sincere, certo. Ma dietro le quinte, la Cisgiordania vive ormai un’occupazione quotidiana fatta di check-point, arresti arbitrari, e di una colonizzazione che procede come una metastasi. I “coloni”, sostenuti in molti casi dall’esercito israeliano, si moltiplicano: veri e propri cloni di uno stesso modello ideologico che mira a cancellare, centimetro dopo centimetro, la presenza palestinese. E chi osa resistere, finisce spesso stritolato nella macchina della sicurezza o della burocrazia militare.
In questo quadro, la visita di Abu Mazen rischia di apparire come un atto di sopravvivenza politica più che come una mossa di rilancio. Da anni la sua Autorità Palestinese ha perso credibilità interna, logorata da corruzione, divisioni e impotenza. A Gaza, intanto, non c’è più nulla da amministrare: la Striscia è un cumulo di macerie, “raso al suolo”, e con ogni probabilità finirà sotto una qualche forma di controllo militare internazionale, forse una forza multinazionale di interposizione — non tanto per garantire giustizia, quanto per mantenere l’ordine e proteggere gli interessi strategici delle potenze coinvolte.
Papa Leone XIV, nel suo stile diretto e compassionevole, ha riaffermato la necessità di una soluzione a due Stati e di un futuro fondato non sulla vendetta ma sul rispetto reciproco. Mattarella ha ribadito la vicinanza italiana al popolo palestinese e il diritto di Israele alla sicurezza. Tutto giusto, tutto vero. Ma la distanza tra le parole di Roma e la realtà di Ramallah resta abissale. L’occupazione si è fatta sistema, la geografia della pace si è disintegrata: non esiste più continuità territoriale tra Cisgiordania e Gaza, non c’è più fiducia tra le parti, e la comunità internazionale sembra rassegnata a un eterno “status quo” armato.
L’Italia e il Vaticano, pur nella loro diversa natura, hanno una responsabilità morale e politica: non basta accogliere Abu Mazen, occorre chiedere garanzie a Israele, pressare per la fine degli insediamenti illegali, sostenere concretamente la ricostruzione di Gaza e la tutela dei civili. Un gesto simbolico vale solo se è il preludio di un’azione coerente.
Ma finora la diplomazia internazionale sembra più preoccupata di non urtare equilibri fragili che di costruirne di nuovi. Così il dramma palestinese continua, sospeso tra la compassione del mondo e l’indifferenza della politica.
La verità, che nessun comunicato stampa può mascherare, è che la pace è diventata un concetto retorico, un mantra svuotato. Eppure, come ricorda Leone XIV, «non c’è futuro fondato sulla violenza». Forse è questo il punto di partenza più onesto: smettere di illudersi, riconoscere il fallimento delle strategie del passato, e ripensare il futuro dei due popoli a partire dalla dignità umana violata ogni giorno, in silenzio, ai margini delle mappe.
Abu Mazen è venuto a Roma, ma la Palestina non è con lui. La sua terra è frammentata, il suo popolo stremato, il suo sogno sempre più lontano.
Se questa visita servirà almeno a ricordare al mondo che la pace non è un rituale da calendario, ma una ferita aperta che continua a sanguinare, allora forse non sarà stata inutile. Ma per ora, la distanza tra le strette di mano e le macerie resta abissale.