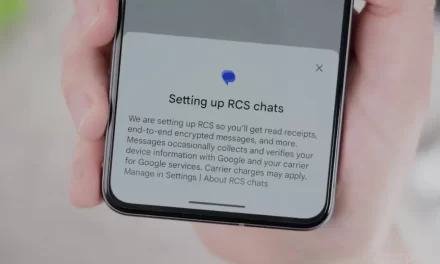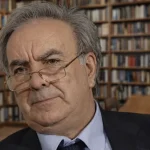Dalla freddezza diplomatica al nuovo gelo globale: due modelli di società che promettono molto e custodiscono poco.
Il 16 novembre 1933 gli Stati Uniti riconobbero ufficialmente l’Unione Sovietica. Un gesto dettato dalla necessità più che dalla simpatia. Oggi, quasi un secolo dopo, i due Paesi si fronteggiano come poli opposti in una nuova Guerra fredda. E i modelli che propongono – libertà senza legami da una parte, ordine senza libertà dall’altra – appaiono come paradisi artificiali. Ma cosa dice la dottrina sociale della Chiesa davanti a questo bivio?
Una data che illumina il presente
Ci sono date che sembrano archiviate e invece continuano a parlarci. Il 16 novembre 1933 non fu un’annata qualsiasi della diplomazia. Gli Stati Uniti, appena usciti dalla Grande Depressione, decisero di riconoscere l’Unione Sovietica, non perché Roosevelt stimasse Stalin, ma perché la realtà geopolitica lo imponeva. L’Europa era fragile, il Giappone avanzava nel Pacifico e Mosca si stava consolidando come un attore inevitabile. Non fu un riconoscimento affettivo, ma pragmatico: due mondi inconciliabili, costretti a parlarsi.
Il nuovo gelo della seconda Guerra fredda
Oggi, quasi un secolo dopo, gli USA e la Russia si fronteggiano nuovamente, ma in un contesto radicalmente diverso. Non c’è più il fervore ideologico del Novecento; c’è un calcolo freddo, digitale, intermittente. La guerra non si misura solo con carri armati e missili, ma con propaganda, informazione, intelligence e cyberattacchi. Eppure, come allora, si percepisce la stessa distanza: due visioni del mondo che promettono un benessere totale e finiscono per offrire soltanto un fragile equilibrio.
Il mito americano: libertà senza legami
Il paradigma americano rimane quello della libertà assoluta. La terra dove “tutto è possibile” ha trasformato quel sogno in una sorta di teologia del successo: non più libertà come relazione, ma libertà come competizione permanente. L’individuo deve reinventarsi da solo, provare il proprio valore in un mercato che spesso chiede molto più di quanto possa restituire. Il risultato è una società potente, brillante, ma anche attraversata da solitudini profonde e da vuoti che nessuna tecnologia riesce a colmare.
Il modello russo: ordine senza libertà
La Russia contemporanea offre l’antitesi: un ordine che pretende stabilità a costo della libertà. L’identità nazionale diventa la religione civile, la verticalità del potere una garanzia di sicurezza. Questa percezione affascina molti Paesi, perché promette protezione, ma rischia di soffocare la persona dietro l’altare della nazione. L’ordine senza libertà produce paura, autocensura e dipendenza psicologica dal potere. Anche questo è un paradiso artificiale, un’illusione che non regge alla prova dei fatti.
Due modelli speculari con lo stesso vuoto
Pur presentandosi come opposti, i due sistemi condividono lo stesso limite: la sostituzione della persona con un’ideologia. Da un lato l’individualismo assoluto, dall’altro il collettivismo identitario. Da una parte il mito dell’autorealizzazione, dall’altra quello della grandezza nazionale. In entrambi i casi, la promessa è seducente, ma il prezzo è l’uomo, chiesto come sacrificio necessario alla coerenza del sistema.
La voce della Chiesa: la persona prima del sistema
Qui la dottrina sociale della Chiesa offre la sua voce più limpida. Documenti come Centesimus annus, Caritas in veritatee Fratelli tutti ricordano che né la libertà senza verità né l’ordine senza dignità possono sostenersi. La Chiesa non si allinea né al modello americano né a quello russo, perché entrambi mancano dell’essenziale: la persona come fine, mai come mezzo. La libertà, se assoluta, si autodistrugge; l’ordine, se non custodisce la dignità universale, diventa oppressione; l’economia, senza etica, si trasforma in idolatria; la nazione, quando esclude la giustizia, genera violenza. Il modello cristiano è più esigente e più umile: una società in cui la libertà è relazione, la giustizia è condivisa e la pace è costruita insieme.
Il monito del 1933
Forse il 16 novembre 1933 è un monito più che una memoria. Quel giorno gli Stati Uniti riconobbero l’URSS non perché la considerassero un modello, ma perché il mondo reale imponeva un dialogo. Oggi la geopolitica ripropone la stessa logica dei blocchi, ognuno dei quali si proclama il lato buono della storia. Ma tra la libertà che si consuma da sola e l’ordine che si impone da solo, rischia di crescere un vuoto in cui l’uomo si perde. La Chiesa lo ricorda con ostinazione: l’unico paradiso non è artificiale, ed è quello che nasce quando la persona viene prima del sistema.