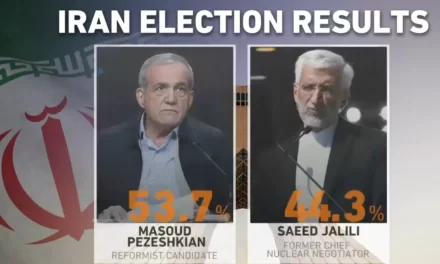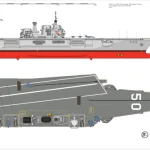«Affido alla misericordia di Dio Onnipotente i molti migranti che hanno perduto la vita». È con queste parole che Papa Leone XIV ha voluto unirsi, in silenziosa preghiera e in voce profetica, alla tragedia consumatasi pochi giorni fa nelle acque del Mar Arabico, al largo dello Yemen. L’ennesimo naufragio. L’ennesimo bollettino di corpi etichettati come “numeri”. L’ennesima rotta della morte percorsa non da criminali, ma da poveri in cerca di pane e dignità.
Settantasei vittime accertate. Tutte dall’Etiopia. Donne, uomini, forse anche adolescenti, gettati in mare da un’imbarcazione sovraccarica e senza scampo, sferzata da un maltempo indifferente come il mondo che l’ha ignorata. Trenta i superstiti, mentre decine di dispersi resteranno probabilmente anonimi tra le onde, come tanti altri migranti prima di loro, inghiottiti da una delle rotte più mortifere del mondo.
Il silenzio delle coste arabe, l’urlo delle coste africane
Non è il Mediterraneo, non è Lampedusa, non è Lesbo: e per questo se ne parla meno. Ma il dramma non è minore. La rotta che parte dal Corno d’Africa – dall’Etiopia e dalla Somalia soprattutto – e attraversa il Golfo di Aden per giungere in Yemen è un canale sotterraneo di disperazione, che l’OIM definisce senza mezzi termini “la più pericolosa del pianeta”.
La destinazione è quasi sempre l’Arabia Saudita o altri Emirati del Golfo, dove la manodopera straniera viene ancora oggi sfruttata secondo logiche di semi-schiavitù. I migranti non sono accolti, ma assorbiti. Senza status, senza diritti, senza voce. La loro funzione è quella dell’invisibile: costruire grattacieli, raccogliere datteri, servire. Il loro passaggio è garantito da trafficanti che lucrano su ogni passaggio di frontiera, mentre lo Yemen – un Paese in macerie – diventa corridoio insanguinato e campo minato.
Uno Yemen disumanizzato
Non dimentichiamolo: il Paese che accoglie queste carovane di migranti è lo stesso Yemen martoriato da una guerra dimenticata, dove si combatte da più di dieci anni con armi e silenzi occidentali. È il Paese in cui l’80% della popolazione ha bisogno di aiuti umanitari, dove le strutture sanitarie sono al collasso e dove la tratta di esseri umani coesiste con la fame, la guerra e l’anarchia tribale.
Eppure, nonostante tutto, i migranti continuano a passare. Perché la speranza è più forte della paura. Perché la fame è più forte della prudenza. Perché il sogno di raggiungere l’altra sponda – non l’Eldorado, ma un luogo meno crudele – è più forte di qualsiasi naufragio.
La frattura africana
Ma la tragedia parte a monte. Parte da un Corno d’Africa dilaniato da crisi sistemiche, dove il cambiamento climatico ha desertificato i raccolti, dove i conflitti etnici hanno moltiplicato gli sfollati, e dove l’instabilità politica – da Addis Abeba a Mogadiscio – ha reso l’unica via di fuga il mare.
L’Etiopia, da cui provenivano le vittime di quest’ultimo naufragio, è il Paese delle grandi contraddizioni: motore economico dell’Africa orientale da una parte, e scenario di guerre intestine, persecuzioni e diseguaglianze dall’altra. Un Paese che perde i suoi giovani migliori in una fuga silenziosa che attraversa deserti, mari, checkpoint e prigioni.
Chi parte non è solo un migrante: è un’accusa vivente alla disuguaglianza globale. È un indice puntato contro l’ingiustizia climatica, contro la complicità delle potenze del Golfo, contro la cecità delle politiche europee che si preoccupano di quanti arrivano, e mai di perché partano.
Il dovere della memoria, la necessità della giustizia
Nel messaggio papale – sobrio, scarno, ma profondo – si sente tutto il peso del Vangelo calato nella carne ferita dell’umanità. “La morte non avrà l’ultima parola”, ha voluto dire Leone XIV. Ma perché questo sia vero, non basta affidarsi al giudizio di Dio. Occorre inchiodare quello degli uomini.
Bisogna interrogare i governi arabi che accolgono manodopera e respingono persone.
Bisogna interrogare i Paesi africani che, pur sovrani, lasciano che le loro gioventù siano vendute ai mercanti del deserto.
Bisogna interrogare le istituzioni europee e internazionali che si girano dall’altra parte, perché tanto “non è il nostro mare”.
La rotta che unisce le periferie
Quello che accade al largo dello Yemen riguarda anche noi. Non solo per motivi morali, ma per una visione politica delle relazioni globali. Le rotte migratorie non sono anomalie: sono le vene aperte del mondo disuguale. Dove la povertà spinge e il privilegio respinge.
Chi attraversa il Mar Rosso con un sacco di plastica legato al petto non è un criminale. È un testimone silenzioso di un sistema globale che ha fallito. Il suo corpo sulle coste yemenite ci chiede di scegliere: o indifferenza, o conversione.
E allora, almeno noi – che scriviamo e leggiamo da questa sponda del mondo – non accontentiamoci di invocare pietà. Pretendiamo giustizia, canali sicuri, cooperazione equa, cittadinanza globale. Solo così potremo dire, con credibilità, che davvero quella morte non sarà stata vana.
Perché nessun mare, nessuna rotta, nessuna frontiera potrà mai giustificare l’abbandono degli ultimi. E ogni naufragio ignorato è una parte di noi che affonda con loro.