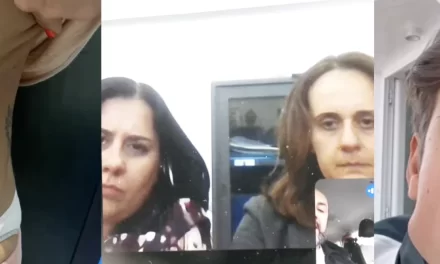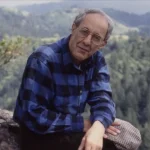Nel silenzio di molti, l’università italiana sta entrando sempre più nella galassia dell’industria della difesa. Una recente inchiesta di Altreconomia ha ricostruito una rete crescente di accordi tra atenei e grandi aziende del comparto bellico – in particolare Leonardo, Thales Alenia Space e MBDA Italia. Una collaborazione legittima sul piano formale, ma che solleva interrogativi importanti sul ruolo pubblico dell’accademia, sulla trasparenza e sulla direzione in cui sta andando la ricerca scientifica in Italia.
Secondo i dati pubblici raccolti dal mensile, sono 23 le università che oggi hanno rapporti attivi con Leonardo, tredicesimo gruppo militare al mondo. Alcuni casi colpiscono per peso e intensità: l’Università di Genova, con contratti e progetti legati anche alla presenza industriale in Liguria; l’Università di Bergamo, coinvolta in un programma di oltre tre milioni di euro con Leonardo e Thales Alenia; numerosi atenei dell’area centro-meridionale in relazione con MBDA.
In alcuni casi – come alla Federico II di Napoli – gli accordi non sono stati resi noti nel dettaglio “per ragioni di concorrenza”, sollevando perplessità sul grado di trasparenza richiesto a un’istituzione pubblica.
Sul versante della ricerca aerospaziale, Bologna emerge per il numero di progetti con Thales Alenia, mentre Padova, Firenze, Sapienza e Tor Vergata risultano anch’esse coinvolte in programmi europei che includono applicazioni dual use, civili e militari. Di contro, i politecnici di Milano e Torino non hanno fornito informazioni complete: un dato che, più che dissipare dubbi, rischia di alimentarli, anche considerando che a Torino la ricerca militare rappresentava già anni fa una quota rilevante dei contratti.
Il caso della Sapienza resta simbolico. L’ateneo romano collabora da tempo con Leonardo e partecipa, tramite la Fondazione Med-Or, alla riflessione strategica su Mediterraneo e Medio Oriente. Una scelta che ha aperto un dibattito acceso fra studenti e docenti sul confine tra legittima cooperazione industriale e rischio di “normalizzazione” della logica del riarmo. Le proteste studentesche degli ultimi mesi testimoniano che il tema non è astratto: riguarda il senso della missione universitaria, la libertà di ricerca e il servizio al bene comune.
Da questo quadro non emerge una condanna pregiudiziale, ma una domanda di responsabilità.
Che tipo di sviluppo vogliamo sostenere?
Quale equilibrio tra ricerca civile, sicurezza e pace?
Il mercato può da solo orientare i laboratori universitari?
La Dottrina sociale della Chiesa richiama l’alleanza tra sapere e cura dell’umano. E invita a custodire la pace non come idea astratta, ma come criterio concreto per orientare scelte e priorità. Un’università che dipende in modo crescente da fondi militari rischia non solo di perdere trasparenza, ma anche di smarrire la sua vocazione più profonda: formare coscienze libere e pensiero critico.
L’Italia ha bisogno di ricerca d’eccellenza. Ma ha anche bisogno di ricerca che non dimentichi l’uomo. In un tempo in cui la guerra torna a bussare alle porte dell’Europa e del Mediterraneo, tenere desto questo interrogativo è un servizio alla verità e alla pace.
Nota della redazione
Quest’articolo non intende assumere posizioni di parte né delegittimare collaborazioni istituzionali. È una riflessione giornalistica basata su dati pubblici e finalizzata a promuovere trasparenza, dibattito e consapevolezza sul rapporto tra università, ricerca e industria militare.