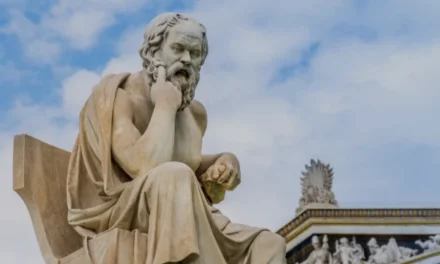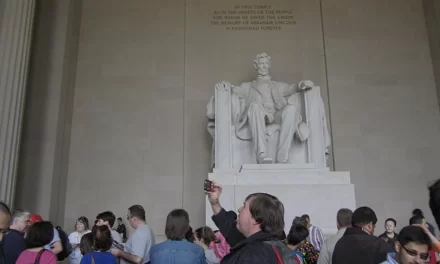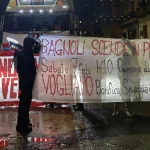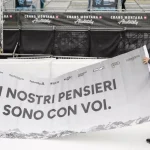Le crisi politiche e i conflitti armati hanno sempre attraversato la storia umana. Ma ciò che stiamo vivendo oggi ha un carattere inedito: la contemporaneità, l’intensità e l’interconnessione delle crisi. Governi che cadono in democrazie consolidate come il Giappone e la Francia, guerre di logoramento come quella in Ucraina, conflitti asimmetrici che degenerano in tragedie umanitarie come a Gaza, l’assassinio di un attivista negli Stati Uniti, i missili che colpiscono il Qatar, la crisi sociale e politica del Venezuela: episodi diversi e lontani, che però compongono un mosaico comune. È l’immagine di un ordine internazionale che non riesce più a contenere gli urti della storia.
Il sistema che si era messo in piedi tra il 1944 e il 1948, sulle macerie della Seconda guerra mondiale, aveva l’ambizione di garantire stabilità attraverso tre pilastri: il multilateralismo globale (ONU, FMI, Banca Mondiale, GATT), l’integrazione regionale (Europa, Americhe, Africa) e la democrazia nazionale come forma di governo legittima, capace di assicurare diritti, benessere e pace sociale. Per decenni, pur tra limiti e contraddizioni, quel sistema ha funzionato. Oggi, invece, sembra irrimediabilmente logoro.
L’ONU, nata non per portare l’umanità in paradiso ma per salvarla dall’inferno, come disse Dag Hammarskjöld, non riesce più neppure a svolgere questa funzione minima. Il Consiglio di sicurezza, con il suo diritto di veto cristallizzato nel 1945, è paralizzato di fronte ai conflitti più devastanti. I segretari generali, un tempo figure capaci di parola profetica, appaiono oggi ridotti a meri portavoce di appelli inascoltati. Gaza, Ucraina, Nepal o Sudan diventano così luoghi di una guerra mondiale “a pezzi”, per usare l’espressione cara a papa Francesco, senza che vi sia un foro globale credibile in grado di arginarne gli effetti.
Anche gli strumenti economici appaiono fuori sincrono. Il FMI e la Banca Mondiale continuano a funzionare come se il baricentro del potere fosse rimasto in Occidente, ignorando il peso crescente dell’Asia e del Sud globale. L’Organizzazione mondiale del commercio, già fragile, è stata colpita al cuore dalla paralisi del suo Organo d’appello e dall’uso spregiudicato di tariffe unilaterali da parte delle grandi potenze. Al posto di un commercio regolato da norme multilaterali, ci troviamo davanti a un protezionismo strategico che privilegia i forti e lascia i deboli in balia della tempesta.
I meccanismi regionali, presentati negli anni ’90 come architravi di un nuovo equilibrio, si sono appannati. L’Unione europea oscilla tra ambizione geopolitica e fragilità interna, divisa da interessi divergenti e spinte centrifughe. In America Latina, esperimenti come Unasur o Celac hanno perso vigore, ridotti a sigle incapaci di generare azioni concrete. In Africa, l’Unione africana fatica a essere più di un foro diplomatico. Anche il regionalismo, che doveva essere un pilastro della governance globale, si rivela oggi un guscio vuoto.
Il quadro si fa ancora più preoccupante sul piano nazionale. La democrazia rappresentativa, modello vincente nel secondo dopoguerra, mostra crepe profonde. L’erosione della fiducia nei partiti, la crescente volatilità elettorale e soprattutto il dominio delle piattaforme digitali stanno cambiando la natura stessa della politica. Non è più l’assemblea o il partito a mediare tra cittadini e istituzioni, ma l’algoritmo di un social network che amplifica le emozioni e monetizza la radicalizzazione. Le big tech sono diventate i nuovi arbitri invisibili della sfera pubblica, capaci di influenzare opinioni, orientare dibattiti e perfino destabilizzare democrazie.
Questa trasformazione ha accelerato l’avanzata dei populismi, che sfruttano frustrazioni sociali, disuguaglianze economiche e paure identitarie. La promessa della democrazia liberale – stabilità, prosperità, stato di diritto – non convince più chi si sente escluso dai benefici della globalizzazione. Le destre estreme e i leader autoritari occupano questo vuoto, normalizzando un discorso che mette in discussione i principi stessi della convivenza. Siamo così entrati in una fase di “regimi ibridi”, dove esistono elezioni, ma con pratiche illiberali che ne svuotano il senso.
Il risultato complessivo è che il mondo sembra vivere in una terra di mezzo: un vecchio ordine morto, un nuovo ordine non ancora nato. Le regole che hanno dato forma agli ultimi ottant’anni non sono più efficaci, ma non esiste ancora una cornice alternativa capace di garantire un minimo di coesione. È per questo che le crisi si moltiplicano, si sommano e si contagiano.
Che cosa ci resta, allora? Da storico e sociologo non posso che osservare il fallimento di un sistema che ha esaurito la sua spinta propulsiva. Da politologo cattolico, credo invece che il compito non sia arrendersi al cinismo, ma ricercare nuove forme di ordine fondate su verità, giustizia e bene comune. La Dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che la pace non è semplicemente assenza di guerra, ma frutto di una giustizia condivisa. E ci ricorda che la politica, se vuole essere tale, deve restare servizio, non dominio.
La vera domanda non è più se l’ordine nato nel 1945 sopravviverà: è già crollato nei fatti. La vera domanda è come ricostruire un sistema che tenga conto delle nuove geografie del potere, delle sfide tecnologiche, delle esigenze ambientali e delle aspirazioni di miliardi di persone che non vogliono vivere nell’incertezza permanente. Ciò che accadrà “dopo” dipenderà dalla capacità – o dall’incapacità – di società civili, istituzioni e comunità religiose di assumersi la responsabilità di un nuovo patto globale.
L’alternativa, lo vediamo ogni giorno, è un mondo senza bussola, dove i conflitti scorrono come fiumi senza argini. È un mondo che cammina verso l’inferno evocato da Hammarskjöld. Ma la storia, ancora una volta, ci chiede se vogliamo restare spettatori di questo naufragio o protagonisti di una nuova ricostruzione.