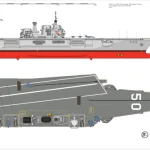Nel Bangladesh ferito e inquieto di questi giorni, il nome di Sharif Osman Hadi è diventato più di un nome. È un corpo martoriato, una piazza in rivolta, una domanda di giustizia che scavalca i confini nazionali e riapre una ferita mai rimarginata: quella del rapporto con l’India e del destino incompiuto della democrazia bengalese.
Hadi aveva trentadue anni ed era uno dei volti più riconoscibili della generazione che, nel 2024, aveva portato in piazza centinaia di migliaia di studenti contro un sistema di potere percepito come ereditario, clientelare, chiuso. Portavoce di Inqilab Mancha, la “Piattaforma della Rivoluzione”, incarnava una miscela pericolosa per molti: radicalità giovanile, consenso popolare, capacità comunicativa e una critica esplicita all’influenza indiana sulla politica interna del Bangladesh, soprattutto dopo la fuga in India dell’ex premier Sheikh Hasina.
Il 12 dicembre, a Dhaka, due uomini su una motocicletta gli hanno sparato alla testa mentre viaggiava su un risciò elettrico. Non un’azione confusa, ma un’esecuzione. Dopo giorni di coma, Hadi è morto in un ospedale di Singapore. La notizia del decesso ha funzionato da detonatore.
Da quel momento il Bangladesh è entrato in una spirale che mescola lutto, rabbia, nazionalismo e sfiducia radicale nelle istituzioni. Le piazze si sono riempite, prima di studenti, poi di cittadini comuni. Le parole d’ordine sono state semplici e assolute: giustizia, dimissioni, verità. Ma accanto a esse è riemerso un sentimento più profondo e più antico: l’ostilità verso l’India, percepita da una parte significativa dell’opinione pubblica bengalese come potenza tutelare, ingombrante, mai davvero neutrale.
Non è un caso che gli edifici presi di mira dai manifestanti siano stati quelli di due grandi quotidiani – Prothom Alo e The Daily Star – accusati di una linea editoriale filo-indiana. Gli assalti alle redazioni, gli incendi, i giornalisti intrappolati per ore: tutto questo segnala un punto di rottura. Quando la stampa viene identificata come “parte del problema”, la crisi non è più solo politica: è sistemica.
Il governo ad interim ha reagito con parole misurate, dichiarazioni di lutto, promesse di indagini. Ma nelle strade la fiducia è evaporata. Gli arresti annunciati non bastano, le ricompense offerte sembrano un rituale vuoto. La convinzione – alimentata sui social e rilanciata da esponenti politici giovanili – che gli assassini siano fuggiti in India ha acceso una miccia che va oltre il singolo delitto.
Qui sta il punto decisivo: la morte di Hadi non è letta come un fatto isolato, ma come l’ultimo atto di una lunga storia di repressione, interferenze e impunità. Le proteste studentesche del 2024, soffocate nel sangue con oltre mille morti, sono ancora una ferita aperta. Le rivelazioni successive – comprese le prove audio di ordini a usare armi letali contro i manifestanti – hanno demolito ciò che restava della legittimità morale del vecchio potere.
In questo contesto, Hadi viene elevato a martire. Non solo da Inqilab Mancha, che lo ha definito tale in chiave religiosa e politica, ma da una parte crescente della società bengalese che vede nella sua fine il simbolo di una verità scomoda: in Bangladesh il dissenso continua a essere pericoloso.
Il rischio, ora, è duplice. Da un lato, la radicalizzazione della protesta, che può scivolare nella violenza indiscriminata e nell’odio anti-indiano come scorciatoia identitaria. Dall’altro, una risposta securitaria che replichi gli errori del passato, alimentando il ciclo repressione-rivolta.
Sharif Osman Hadi non era un santo, né un semplice agitatore. Era un prodotto del suo tempo: giovane, politico, scomodo. La sua morte chiede giustizia, non strumentalizzazione. Ma soprattutto pone una domanda che il Bangladesh non può più eludere: è possibile costruire una democrazia senza spegnere chi la chiede?
Finché questa domanda resterà senza risposta, le piazze continueranno a bruciare. E il confine tra lutto e rivolta resterà pericolosamente sottile.