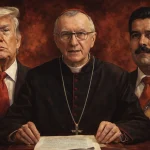«Non so che diavolo gli sia successo»: con queste parole, pronunciate domenica da Donald Trump riferendosi a Vladimir Putin, l’ex presidente americano rompe — in modo inusualmente diretto — la sua consueta ambiguità verso il leader del Cremlino. Una condanna verbale che arriva dopo il più grave bombardamento russo su obiettivi civili ucraini degli ultimi anni, ma che non si accompagna a scelte politiche coerenti: nessuna sanzione, nessuna pressione diplomatica, nessun sostegno militare concreto a Kiev. Un’escalation di violenza, dunque, commentata a parole ma lasciata scorrere nei fatti.
«Non so cosa diavolo sia successo a Putin»: con queste parole, cariche di stupore e tensione, l’ex presidente americano Donald Trump ha commentato l’ennesimo massiccio bombardamento russo in Ucraina, avvenuto lo scorso fine settimana e diretto in larga parte contro obiettivi civili. A Kiev e in altre città ucraine, i missili e i droni hanno colpito quartieri residenziali e dormitori universitari, lasciando una scia di distruzione e di vittime. Ma il vero cortocircuito si è verificato nelle ore immediatamente precedenti: Trump aveva appena concluso una lunga telefonata di due ore con il presidente russo, definita “eccellente”, nella quale aveva auspicato un possibile cammino di pace.
La contraddizione è evidente: Trump esprime sdegno per la violenza russa, ma allo stesso tempo non adotta misure concrete per contrastarla. Nonostante gli appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a rafforzare le sanzioni economiche, l’ex presidente continua a sottrarsi a ogni iniziativa che implichi una pressione reale su Mosca.
La diplomazia del disimpegno
Nel corso delle ultime settimane, Trump ha alternato dichiarazioni pubbliche di vicinanza al popolo ucraino a scelte strategiche che indeboliscono il fronte occidentale. In incontri riservati con i leader di Germania, Francia e Italia, avrebbe espresso l’intenzione di ritirare il sostegno americano da ogni ulteriore azione sanzionatoria, allineandosi a una linea di prudente distacco. «Sono fuori», avrebbe detto, secondo fonti diplomatiche europee. Una frase che suona come un segnale preoccupante, soprattutto alla luce della crescente collaborazione militare tra Russia e altri attori ostili all’ordine internazionale.
Trump ha spesso dichiarato che solo lui sarebbe in grado di concludere la guerra, grazie alla sua relazione personale con Putin. Eppure, dopo ogni contatto tra i due, le ostilità sul campo si sono intensificate. Mentre il leader del Cremlino prosegue nel suo piano di annientamento dell’Ucraina, gli Stati Uniti sembrano sempre più esitanti, incapaci di trovare un equilibrio tra il desiderio di disimpegno e la responsabilità di una leadership internazionale.
L’assenza di scelte chiare
Anche sul piano economico, la posizione americana appare ambigua. Lo scorso aprile, quando Trump ha annunciato nuove sanzioni commerciali a livello globale, la Russia ne è stata quasi completamente esentata. E mentre l’Europa intensifica la sua risposta, gli Stati Uniti sembrano fare un passo indietro anche nella raccolta di prove per eventuali procedimenti internazionali contro i crimini di guerra.
Il presidente Zelensky, pur attento a non inasprire i rapporti con Washington, ha sottolineato con forza che “solo un senso di impunità assoluta può giustificare bombardamenti di questa portata”. Un richiamo che non può restare inascoltato.
Verso quale pace?
La posta in gioco resta alta. Trump continua a suggerire una futura normalizzazione dei rapporti con Mosca, immaginando una ripresa del commercio dopo la fine del conflitto. Ma mentre si rincorrono dichiarazioni contraddittorie – come quella sul presunto desiderio russo di “assorbire tutta l’Ucraina” – manca una visione politica e morale chiara su come arrivare alla pace.
Nel suo messaggio di domenica, Trump ha accusato Putin di voler espandere la guerra, ma ha anche escluso qualunque iniziativa per fermarlo, rinunciando persino a una richiesta di cessate il fuoco temporaneo.
L’urgenza di una responsabilità condivisa
Nel terzo anno di guerra, l’Ucraina continua a vivere sotto l’assedio, mentre la comunità internazionale è chiamata a rinnovare il proprio impegno per la giustizia e la pace, al di là delle convenienze elettorali o delle oscillazioni personali dei leader. La via della pace non può essere affidata all’improvvisazione, né basarsi solo su rapporti personali tra capi di Stato.
Serve un fronte internazionale coeso, capace di parlare con chiarezza e fermezza, con il linguaggio della verità e della dignità umana. Solo così sarà possibile fermare la violenza, ridare voce ai popoli colpiti e costruire una pace giusta, che non sia dettata dalla paura o dal silenzio, ma dalla forza della coscienza.