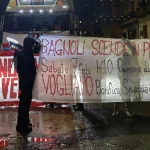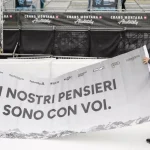Atomi e responsabilità. Nell’era di Leone XIV, non possiamo tornare indietro
Il recente annuncio statunitense sulla possibile riattivazione dei test nucleari, diffuso poco prima del faccia-a-faccia con la Cina, riporta all’ordine del giorno un tema che molti speravano relegato agli archivi della Guerra Fredda. In un frangente nel quale prevalevano segnali di cooperazione economica, ecco ripresentarsi logiche di potenza e intimidazione: un campanello d’allarme per la comunità internazionale e, sul piano cristiano, un richiamo urgente a riscoprire la prospettiva di una pace fondata sul diritto e non sulla forza.
Prima Mosca ha esibito un missile a propulsione nucleare, simbolo di una tecnologia pensata non per difendere ma per intimidire. Poi, pochi giorni dopo, da Washington è arrivato l’annuncio: l’America è pronta a riaprire la stagione dei test atomici, interrompendo un silenzio che durava da oltre trent’anni.
E tutto questo alla vigilia di un incontro con la Cina, che a sua volta accelera sui vettori avanzati.
Non è una coincidenza. È una logica: se l’altro mostra i muscoli, io raddoppio. La vecchia tentazione — che la pace si garantisca con la minaccia — ritorna, travestita da “parità strategica”. Eppure sappiamo bene dove conduce: alla sfiducia, all’instabilità, alla paura elevata a metodo politico.
Proprio per questo la voce della Chiesa, e quella del Papa, oggi risuona con particolare urgenza. Leone XIV ha richiamato più volte alla sicurezza condivisa: non la rassegnazione ingenua, ma l’unica strada realistica nell’era nucleare.
Non è un sogno spirituale: è lucidità storica. Finché la sicurezza sarà costruita sull’idea che l’altro va dissuaso e non ascoltato, ogni tregua sarà fragile, ogni crisi potenzialmente definitiva.
Il divieto di test esplosivi — pur imperfetto, pur incompiuto — è stato uno degli argini morali più importanti degli ultimi decenni. Abbatterlo significa riaprire una porta che la storia aveva chiuso a caro prezzo.
La dottrina della Chiesa non è romantica: considera la legittima difesa, comprende le esigenze di Stato, ma non accetta che la sicurezza pubblica si fondi sulla minaccia atomica o sulla logica dell’inibizione reciproca. La pace autentica nasce da istituzioni che favoriscono la cooperazione tra nazioni, il disarmo controllato, la trasparenza nei sistemi di verifica. È una costruzione esigente, che richiede tanto coraggio quanto la deterrenza, ma con esito opposto: non la preparazione alla guerra, ma l’abbattimento delle sue possibilità.
Questo ci richiama ad una responsabilità collettiva. Non possiamo delegare ad altri (Stati, sistemi militari, trattati) la sola cura della pace: è chiesto alle comunità, ai media, alle istituzioni educative e politiche di promuovere una cultura della fiducia, del dialogo, della riduzione delle armi. Perché la pace non è la mera assenza di conflitto, ma la presenza di giustizia e fraternità.
Se vogliamo evitare che nuovi conflitti vengano generati o alimentati da test nucleari, dobbiamo rifiutare l’illusione che la minaccia sia una garanzia. La storia dimostra che il deterrente può diventare veleno per l’anima dei popoli e per l’equilibrio internazionale.
Oggi più che mai è necessario scegliere: non la deterrenza perpetua, ma la sicurezza condivisa; non il calcolo della forza, ma la pazienza della diplomazia; non il riarmo, ma la perseveranza del disarmo. Per la Chiesa, la pace non è un sogno ingenuo, ma profezia reale che chiede coraggio. E in un mondo che torna a parlare il linguaggio delle prove atomiche, quella profezia è urgente.