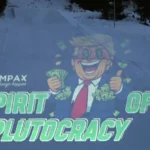Mons. Ronald A. Hicks inaugura il suo ministero episcopale a New York
Alla cattedrale di San Patrizio, il nuovo pastore di New York non ha iniziato con un programma, ma con una lingua e un gesto: qualche verso in spagnolo, una melodia popolare latinoamericana, e l’idea di Chiesa come missione, non come circolo. Ronald A. Hicks raccoglie l’eredità di Timothy Dolan e manda un segnale: il cattolicesimo newyorkese non può più permettersi periferie.
Certe successioni episcopali sembrano fatte di protocolli: un nome che passa di mano, una sedia che cambia occupante, i ringraziamenti di rito. Eppure, a volte, un dettaglio rompe l’ovvio e rivela il nucleo. Ronald A. Hicks, appena insediato come guida di circa 2,5 milioni di cattolici di New York, ha scelto un dettaglio che è già teologia pastorale: ha cominciato parlando in spagnolo, richiamando un canto che molti latinoamericani riconoscono come preghiera di disponibilità e offerta. Non una “strizzata d’occhio” etnica, ma una dichiarazione di metodo: prima di essere strategia, l’evangelizzazione è un “eccomi” pronunciato con l’accento delle persone.
Il passaggio di consegne con il cardinale Timothy Dolan — dopo oltre sedici anni di governo — avviene in una città che è allo stesso tempo simbolo e laboratorio. New York è la vetrina dove il cattolicesimo americano viene guardato, giudicato, spesso frainteso. Ma è anche il luogo dove la Chiesa si misura con la realtà: pluralismo culturale, fratture sociali, povertà e ricchezza che si sfiorano senza incontrarsi, migrazioni che non sono capitolo di cronaca ma biografie quotidiane. In questo contesto, l’incipit in spagnolo di Hicks diventa un segno: non esiste “centro” ecclesiale che possa ignorare la sua periferia demografica e spirituale.
Hicks arriva a New York con una biografia che assomiglia a una mappa: vescovo a Joliet (Illinois), prete di Chicago, formatore in seminario, e soprattutto un’esperienza che pesa più di tanti titoli — la guida di un orfanotrofio in El Salvador. Non è un dettaglio “curriculare”: è un punto di vista. Chi ha conosciuto la vulnerabilità non parla della missione come di un progetto da amministrare, ma come di un’urgenza da abitare. E nella sua omelia di insediamento la parola chiave è stata proprio questa: una Chiesa missionaria.
Missionaria, però, non come slogan. Hicks ha contrapposto due immagini: la Chiesa-circolo e la Chiesa-in-uscita. Un club, per definizione, esiste per i suoi membri; la Chiesa, se rimane Chiesa, esiste per andare verso tutti. È un’affermazione che sa di Vangelo prima ancora che di ecclesiologia: non perché disprezzi chi è dentro, ma perché ricorda che il “dentro” è sempre un “per”. La comunità cristiana non custodisce il bene come un privilegio; lo condivide come un fuoco.
In quella stessa linea, Hicks ha evocato Gesù nei tratti essenziali che ogni città comprende: sfamare chi ha fame, curare le ferite del corpo e dello spirito, rifiutare l’odio, proclamare l’amore. È un cristianesimo senza sovrastrutture, ma non senza spina dorsale. In un’America dove spesso la fede viene arruolata come identità di parte, il nuovo arcivescovo sembra suggerire un’altra grammatica: non la religione come bandiera, bensì come servizio.
È qui che la scelta linguistica e culturale acquista profondità. La liturgia è stata bilingue e lo spagnolo non è rimasto decorazione: ha avuto un posto “primo”, come se l’assemblea dovesse imparare un ordine nuovo delle priorità. Hicks non ha trasformato l’omelia in un comizio sull’immigrazione né ha nominato direttamente le paure legate a campagne di deportazione e controlli: ma ha fatto qualcosa che, a volte, è più incisivo di un discorso politico. Ha mostrato che i latinos non saranno un capitolo a margine, bensì una parte strutturale dell’identità ecclesiale diocesana. Nella Chiesa, la lingua non è solo mezzo: è riconoscimento.
E poi c’è stato un altro segno, più “newyorkese” e, proprio per questo, interessante: la musica pop. Hicks ha infilato nel suo discorso una piccola costellazione di citazioni — Billy Joel, Jay-Z, Sinatra — e persino Bad Bunny. In molti, raccontano, hanno reagito con un entusiasmo particolare proprio a quest’ultima citazione. Non perché un rapper risolva i problemi della Chiesa, ma perché dice che il pastore conosce il suo popolo: non solo le sacrestie, ma le strade, le cuffie, la lingua emotiva della città. L’inculturazione, quando è autentica, non è marketing: è il modo in cui l’Incarnazione continua a farsi stile.
Sul piano ecclesiale, Hicks ha anche collocato se stesso con chiarezza nella traiettoria inaugurata da papa Francesco e portata avanti da papa Leone XIV: la parola d’ordine è inclusione, ma non come elasticità dottrinale, bensì come ampiezza evangelica. Il suo richiamo al “todos” — quel “tutti” ripetuto come un colpo di campana — suona come una scelta: non una Chiesa assediata che si difende restringendosi, ma una Chiesa che si rafforza donandosi. E, con un gesto tipico di Francesco, ha chiesto preghiera: non per rituale modestia, ma per confessare che governare una diocesi non è dominio, è peso condiviso.
Intanto, Dolan esce di scena con la sua impronta inconfondibile: presenza mediatica, capacità comunicativa, stile affabile, una figura che ha segnato il cattolicesimo americano ben oltre New York. La transizione è dunque “dolceamara”: gratitudine per ciò che è stato e attesa per ciò che sarà. In questo spazio di passaggio, Hicks ha fatto la scelta più intelligente: non ha parlato soprattutto di sé, ma della Chiesa che desidera. E l’ha raccontata non con un manifesto, bensì con una lingua, una canzone, una città intera come parabola.
Forse è questo il punto: New York non chiede al suo arcivescovo di essere perfetto, ma di essere vero. E un uomo che comincia il suo ministero con lo spagnolo un po’ incerto di un canto missionario sembra voler dire: non sono qui per gestire un’istituzione. Sono qui per servire un popolo. E per ricordare alla Chiesa che il suo centro è sempre fuori, là dove l’umanità ha più bisogno di essere incontrata.