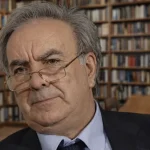Ucciso un giovane identitarista a Lione. Un prete francese si fa cappellano solo di chi la pensa come lui.
Lione, 12 febbraio 2026: un giovane di 23 anni, Quentin D., viene soccorso in condizioni gravissime sul quai Fulchiron dopo violenze avvenute a margine di una conferenza a Sciences Po. Le indagini faranno chiarezza su dinamiche e responsabilità, ma una verità è già intatta: quando la militanza si fa pestaggio, non vince “la causa”, vince l’estremismo — e vince sempre due volte, perché contagia destra e sinistra con la stessa logica del nemico.
C’è un punto in cui la democrazia non “cade”: si logora. Non arriva con i carri armati, ma con le parole che cambiano senso, con le piazze che cambiano tono, con l’università che smette di essere aula e diventa arena. Il fatto di Lione — un ragazzo colpito con violenza brutale in un contesto di scontri tra militanti contrapposti — non è soltanto cronaca: è la fotografia di un’Europa che rischia di abituarsi alla scorciatoia più vecchia del mondo, quella che scambia la forza per argomento.
Si dirà: “Aspettiamo la giustizia”. Certo. È doveroso. Proprio perché le ricostruzioni, in queste ore, si accendono e si contraddicono, e i social trasformano ogni frammento in sentenza. Ma l’etica pubblica non ha bisogno di aspettare per pronunciare la sua condanna: un pestaggio non è mai “incidente”, non è mai “reazione”, non è mai “difesa”. È un fallimento. E quando accade ai margini di una conferenza universitaria, il fallimento è doppio: del confronto e delle istituzioni informali — “servizi d’ordine” improvvisati, cordoni, gruppetti — che pretendono di sostituire regole e responsabilità con muscoli e intimidazione.
Il punto che tanti evitano per calcolo è questo: l’estremismo è bipartisan per natura, perché non vive di contenuti ma di metodo. Cambiano i simboli, resta la grammatica. La stessa frase — “non devono parlare” — può vestirsi da “antifascismo” o da “difesa identitaria”. La stessa pratica — “isolarlo, inseguirlo, colpirlo” — può essere giustificata come “protezione” o come “giustizia”. Ma è sempre uguale: l’avversario non è più persona, è bersaglio.
E qui bisogna avere il coraggio di dire anche ciò che fa più male: quando la politica scivola verso la rissa, la tentazione delle leadership è strumentalizzare. La tragedia diventa clava narrativa: per alcuni prova che “l’altra parte” è intrinsecamente violenta; per altri occasione di minimizzare, di spostare il discorso, di ridurre tutto a propaganda. È un cinismo che disumanizza due volte: la vittima — ridotta a simbolo — e la società — ridotta a tifoseria.
In questo clima, anche la parola religiosa può essere trascinata nel fango dello scontro. E qui il nome va fatto, perché lo chiedono i fatti e lo impone la responsabilità: l’abbé Matthieu Raffray. Quando un sacerdote — seguito e ascoltato, soprattutto da giovani in cerca di identità — predica con il registro dell’assedio e costruisce una “folla di nemici” da elencare uno dopo l’altro, con categorie ammassate e demonizzate (“comunisti, massoni, mondialisti, wokisti…” e via via fino a “eretici e scismatici”), non sta aiutando il discernimento: sta offrendo una cornice mentale in cui il mondo è guerra permanente.
Non si tratta di “censurare” un prete. Si tratta di ricordare cos’è il sacerdozio: non la cappellania di una tribù, ma un ministero per tutti. “Cattolico” vuol dire universale: se la predicazione diventa il luogo dove si rafforzano le appartenenze contro qualcuno, allora la fede viene ridotta a etichetta identitaria — un “supplemento d’anima” per la polarizzazione, non un lievito di riconciliazione. E il rischio è concreto: parole così, in un contesto già incendiato, possono diventare benzina — non perché “producano” automaticamente violenza, ma perché normalizzano l’idea che l’altro sia, prima di tutto, un nemico.
Il paradosso è che gli estremismi si alimentano a vicenda. L’ultrasinistra ha bisogno dell’ultradestra per sentirsi “necessaria”; l’ultradestra ha bisogno dell’ultrasinistra per sentirsi “assediata”. È un circuito chiuso, perfetto, suicida. E in mezzo restano le persone reali: studenti, cittadini, perfino comunità parrocchiali, costrette a scegliere tra silenzio e schieramento, come se non esistesse più un terzo spazio: quello della dignità umana e della ragione.
Se vogliamo che Lione non sia solo un titolo, bisogna spezzare il meccanismo in tre punti, subito e senza ambiguità:
- Condanna piena della violenza, senza “sì però”, senza gerarchie morali tra spranghe.
- Responsabilità nei linguaggi, anche ecclesiali: chi parla a folle o a community giovani smetta di fabbricare nemici.
- Difesa degli spazi del confronto (università, piazze, media) con regole chiare e con l’isolamento netto di chi cerca lo scontro fisico.
Perché la democrazia non chiede concordia finta: chiede conflitto civile. Ma quando il conflitto diventa pestaggio, la società entra in una zona buia dove destra e sinistra — per quanto si odino — finiscono per somigliarsi. E allora sì, la politica sanguina. E con lei sanguina anche ciò che dovrebbe curare: la parola, la coscienza, perfino la fede.