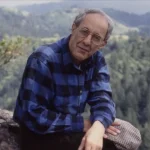Alla ribalta documenti classificati sugli armamenti tra Israele e Italia
I soldi non puzzano, ma la coscienza sì. Nel pieno di uno dei più drammatici conflitti della storia recente, quando Gaza è diventata sinonimo globale di devastazione e sradicamento, un documento rimasto finora nell’ombra riemerge con forza: l’Accordo di Sicurezza Italia-Israele del 1987, parte integrante del Memorandum d’Intesa del 2005, siglato per intensificare la cooperazione militare tra i due Paesi. Un patto vincolante, che impone un segreto reciproco su ogni informazione classificata, incluse operazioni, forniture, collaborazioni tecniche e scientifiche in ambito bellico. Un patto che oggi interroga non solo la politica, ma anche la coscienza collettiva di una democrazia.
Il velo del segreto
Quando la diplomazia si affida all’opacità, il cittadino resta cieco. In nome della sicurezza nazionale, la trasparenza cede il passo all’autoreferenzialità del potere esecutivo. E il Parlamento, che in teoria dovrebbe controllare le scelte in materia di armamenti secondo la legge 185/1990, viene neutralizzato con una formula giuridica: “accordi non soggetti a ratifica”. È accaduto allora. E accade ancora.
Ma si può, nel 2025, continuare a stipulare – o mantenere – accordi di cooperazione militare con uno Stato che, come dichiarano 25 ministri degli Esteri (incluso il nostro), sta infliggendo sofferenze civili “insostenibili”? La questione non è ideologica, ma etica. E riguarda il discrimine tra cooperazione strategica e corresponsabilità morale.
Il paradosso Tajani
Il ministro Tajani ha riconosciuto pubblicamente che la reazione israeliana al massacro del 7 ottobre «sta assumendo forme inaccettabili». Ma poi ha ribadito la volontà del governo di non sospendere il Memorandum. Il motivo non detto è semplice: Israele non è solo un partner politico. È un fornitore strategico di tecnologie militari, cyber intelligence, droni, difese elettroniche.
Secondo i dati ufficiali, l’Italia importa da Israele il 20% dei suoi armamenti, più di qualsiasi altro Paese dopo gli Stati Uniti. È un flusso che si muove in gran parte sotto traccia, protetto proprio da accordi di segretezza come quello del 1987. Il paradosso è evidente: diciamo di non esportare nuove armi a Tel Aviv, ma continuiamo ad acquistarne. In silenzio. Con discrezione. E con fondi pubblici.
Pecunia non olet?
«Il denaro non puzza», dicevano i Romani. Ma questo adagio, nato per giustificare una tassa sui bagni pubblici, oggi risuona tragicamente fuori luogo. Perché il denaro speso in strumenti di guerra, quando la guerra sbriciola vite umane e coscienze, ha sempre un odore: quello del compromesso morale.
Non è un’accusa ideologica contro Israele, né un’assoluzione per le violenze di Hamas. È una domanda civile: può una democrazia restare moralmente neutra quando finanzia – direttamente o indirettamente – un conflitto che giudica “drammatico e inaccettabile”? È legittimo per un governo scegliere la ragion di Stato, ma non può pretendere che la società civile dimentichi la ragion di umanità.
La democrazia esige controllo
Il vero scandalo non è solo l’accordo in sé, ma l’impossibilità di conoscerne i contenuti, persino da parte dei rappresentanti eletti. La democrazia, senza accesso all’informazione, diventa simulacro. La legge 185/1990, pensata per garantire trasparenza nelle esportazioni militari, è ormai aggirata da prassi di governo e protocolli non ratificati, siglati in silenzio e custoditi sotto il mantello del “top secret”.
Eppure, proprio nei momenti di crisi, la trasparenza non è un lusso: è un dovere. Non possiamo accettare che il Parlamento venga tenuto all’oscuro mentre a Gaza piovono bombe anche costruite con tecnologia straniera. Non possiamo fingere neutralità mentre alimentiamo, economicamente e tecnicamente, l’apparato bellico di chi è sotto accusa internazionale per crimini di guerra.
Una domanda per il futuro
La questione non è solo politica, ma profondamente antropologica: quale tipo di civiltà vogliamo costruire? Una che misura tutto in base agli interessi geopolitici e alle convenienze industriali, o una che ancora riconosce nella vita umana, in ogni vita, un valore non negoziabile?
Israele, per la sua storia e la sua vulnerabilità, merita sicurezza. Ma la sicurezza non può trasformarsi in impunità. Né può diventare merce di scambio nel mercato degli armamenti. E l’Italia, se vuole essere credibile nel richiamare gli altri al rispetto del diritto internazionale, deve cominciare da sé. La vera neutralità non è nell’equidistanza. È nella coerenza.
La coscienza ha memoria lunga. E sa riconoscere quando il silenzio non è prudenza, ma complicità.