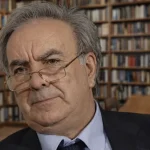Coloni israeliani incendiano luoghi di culto dei palestinesi in Cisgiordania
A volte la cronaca arriva come una fitta improvvisa, qualcosa che non puoi ignorare. In Cisgiordania, una moschea data alle fiamme dai coloni israeliani ha lasciato un guscio annerito e un odore acre sospeso nell’aria, ma ciò che più ha colpito non è stato il fuoco. Sono state le scritte, tracciate in fretta sui muri: minacce rivolte all’IDF, l’esercito israeliano. Un paradosso amaro. Non più un gesto di odio diretto al nemico palestinese, ma un segnale di guerra interna, di frattura che si insinua nel cuore dello Stato.
Nel frattempo, due adolescenti palestinesi cadono sotto i colpi delle forze israeliane. Due ragazzini, due famiglie travolte. L’Autorità nazionale palestinese alza la voce, denuncia, protesta. E intanto da Washington arriva l’avvertimento del senatore Marco Rubio, che sembra quasi un sospiro: “Così si rischia di far saltare la tregua”. La tregua, già abbastanza fragile da sembrare un origami lasciato sotto la pioggia, ora minacciata non solo dai missili o dalle rappresaglie, ma dagli incendiatori della propria parte.
È questo, forse, il passaggio più inquietante: quando un Paese comincia a incendiarsi da solo, quando i suoi estremisti iniziano a considerare l’esercito troppo tiepido, troppo moderato, quasi un ostacolo. E allora bruciano una moschea non come gesto di “resistenza”, ma come avvertimento. L’IDF, accusato di non spingere abbastanza, diventa il bersaglio degli stessi che dovrebbe contenere. È l’immagine di uno Stato che rischia di non riconoscersi più nello specchio.
La Cisgiordania non è mai stata una terra facile, ma negli ultimi mesi sembra un diapason impazzito: ogni gesto vibra più forte, ogni errore rimbomba più lontano. L’uccisione di due adolescenti non è un incidente: è una crepa nella struttura già fragile della convivenza. E intanto Gaza, dall’altra parte del confine, tenta una tregua fatta di trattative, ostaggi, salme restituite una ad una, come fossero biglietti di un dialogo che nessuno sa più leggere.
In questi giorni, nelle capitali occidentali si ripetono parole come “de-escalation”, “moderazione”, “responsabilità”. Ma le immagini che arrivano dalla Cisgiordania raccontano altro: raccontano uno Stato che sembra procedere per inerzia, come se non avesse più il controllo dei suoi margini più infiammati. Raccontano una leadership politica intrappolata nella necessità di non scontentare gli estremisti, di non perdere un voto, una coalizione, un consenso. Raccontano il silenzio di chi, pur sapendo che l’incendio è iniziato, finge di non sentire il crepitio.
Eppure, i segnali sono fin troppo chiari. Bruciare un luogo di culto non è solo un atto vandalico: è un gesto che spezza ponti, che avvelena la possibilità stessa di una convivenza futura. È un marchio sulla superficie già ferita di un territorio che non ha più pelle sana. E minacciare l’IDF — l’istituzione che in Israele rappresenta la continuità dello Stato, la sua spina dorsale — significa aprire una breccia che nessun leader responsabile dovrebbe ignorare.
La tregua a Gaza, miracolosa nella sua precarietà, non può reggere se attorno si alimenta il caos. Hamas consegna una salma, Israele avanza richieste, l’Egitto media, il Qatar insiste. Tutto sembra appeso a un filo sottile, già sfibrato. In questo contesto, un incendio in Cisgiordania pesa più di una dichiarazione diplomatica. È un messaggio che vola oltre il fumo: se l’estremismo prende il sopravvento, nessuna trattativa è possibile.
Forse il punto è proprio questo: Israele non sta esagerando soltanto nelle operazioni militari, ma nel permettere che una parte del Paese sposti il baricentro etico oltre il limite della prudenza e della legge. Ed è qui che si gioca il futuro prossimo: non nelle conferenze degli inviati internazionali, ma nei villaggi colpiti, nelle strade pattugliate, nelle moschee bruciate e nelle scritte di minaccia.
Quando un Paese perde il controllo dei suoi estremi, rischia di perdere anche la sua direzione. E allora il quesito non riguarda più solo la sicurezza o la politica. Riguarda l’identità. Riguarda la possibilità stessa di guardare avanti senza inciampare nel fuoco lasciato alle spalle. Perché un incendio, lo sappiamo, non resta mai il problema di una sola notte.
Scava, cova, riappare.
E questa volta, rischia di incendiare tutto.