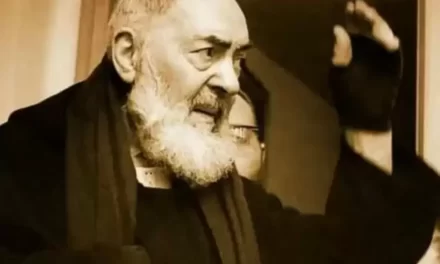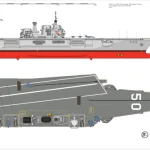Ritrovare l’umano nel tempo dei muri
Sessant’anni fa, il Concilio Vaticano II consegnava alla storia Nostra Aetate, un testo breve e coraggioso che apriva un’era nuova nei rapporti tra la Chiesa cattolica e le religioni del mondo. Allora era un germoglio fragile. Oggi, nel ricordo di quell’atto profetico, Leone XIV ha restituito al mondo il senso più profondo di quella scelta: il dialogo non come strategia, ma come identità, non come gesto diplomatico, ma come vocazione umana e spirituale.
Nell’Aula Paolo VI, davanti a capi religiosi e diplomatici, il Pontefice ha parlato con gratitudine, ricordando chi ha creduto nel dialogo fino a donare la vita, veri “martiri della fraternità”, uomini e donne che non hanno risposto al fanatismo con l’odio, ma con la coerenza di un cuore aperto.
Radici e orizzonte
Il Papa ha evocato il cuore di Nostra Aetate: la convinzione che tutta l’umanità appartiene a una sola famiglia e che ogni tradizione religiosa, pur diversa, custodisce un raggio di verità. La Chiesa, ha ricordato, non rinuncia alla sua fede quando tende la mano, ma proprio dalla fede trae la forza per farlo. Non uniformità, ma incontro. Non diluizione delle identità, ma profondità che si apre.
Particolare attenzione è stata dedicata all’ebraismo, “radice viva” del cristianesimo. Nostra Aetate segnò il rifiuto definitivo dell’antisemitismo e di ogni odio religioso: una scelta allora rivoluzionaria, oggi ancora necessaria, mentre in molte parti del mondo riemergono pregiudizi, nazionalismi religiosi, derive fondamentaliste e teorie del sospetto.
Dialogo come stile di vita
Leone XIV ha parlato di dialogo in termini poco teorici e molto concreti: non strumento diplomatico, ma via di trasformazione. Non esercizio di cortesia, ma pazienza quotidiana, capace di cambiare chi ascolta e chi parla. Un cammino che non ignora le ferite del tempo presente: guerre che sembrano senza soluzione, nuove barriere tra popoli, crisi ambientale, povertà che generano rabbia, solitudini che diventano rancore.
In questo scenario, il Pontefice ha affidato ai leader religiosi un compito non secondario: disarmare gli spiriti, educare alla pace, aiutare i popoli a liberarsi da odio e paura. Non per utopia ingenua, ma per una responsabilità storica: se religioni e culture non fermano il discredito reciproco, sarà difficile evitare che l’umanità scivoli in una spirale senza uscita.
Il Giubileo della Speranza
La cornice è il Giubileo della Speranza: non un calendario liturgico, ma un invito a non cedere alla stanchezza e al cinismo. Perché la speranza non nasce da se stessa; si genera nel cammino condiviso, nella scelta di guardarsi negli occhi, nel coraggio di ricominciare a fidarsi.
Nell’epoca dei muri e delle paure, il Papa ha chiesto di restare “artigiani di fraternità”. E ha concluso con il linguaggio che più gli appartiene: il silenzio della preghiera. Non come pausa cerimoniale, ma come gesto che riconsegna la parola a ciò che nessun discorso può dire: la pace si costruisce prima dentro di noi, poi tra di noi.
Una via possibile
In un tempo che torna a usare il linguaggio degli avversari e dei blocchi, l’intervento di Leone XIV ricorda una verità semplice e rivoluzionaria: le civiltà muoiono quando smettono di parlarsi; rinascono quando scoprono nuovamente l’altro come fratello.
Sessant’anni dopo Nostra Aetate, il futuro non chiede solo nuove parole, ma nuovi cuori. E un’umanità capace di ritrovare nell’altro non una minaccia, ma un volto. Chi cammina nella speranza non ignora le ombre: decide solo di non lasciarsene governare.