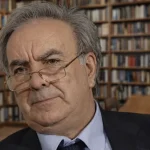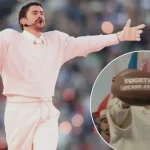Nel cuore della riflessione qui proposta si colloca l’idea che il potere, nella sua essenza più alta, non sia dominio ma diaconia istituzionale: un servizio al bene comune reso possibile dal diritto, la cui finalità ultima è rendere vivente la giustizia nella vita dei popoli. Tuttavia, nel tempo presente, questo ideale appare gravemente incrinato da una crisi silenziosa ma profonda: la crisi della partecipazione, dell’appartenenza e della responsabilità politica. L’astensionismo crescente, che priva le democrazie del respiro vitale del consenso, non è mera disaffezione elettorale, ma il segno di un impoverimento spirituale della polis, di una perdita di fiducia nella capacità delle istituzioni di incarnare il bene comune. È il sintomo di una patologia più radicale: la riduzione della politica a tecnica amministrativa, la sua separazione dall’etica, la dissoluzione della auctoritas come fondamento morale della potestas. La dignità, intesa non come concetto astratto ma come forza normativa della convivenza, diventa il criterio attraverso cui ripensare la democrazia come processo di partecipazione reale, capace di rigenerare la fiducia, l’impegno e la corresponsabilità dei cittadini. In questo orizzonte, il diritto si rivela non semplice meccanismo regolativo, ma via maestra della libertà; strumento educativo che forma la coscienza dei popoli, ponendo la giustizia al centro dell’agire politico. Le universitas, luoghi della ragione e dell’incontro, diventano allora le nuove agorà del pensiero critico, le architetture viventi della sinfonia delle diversità, nelle quali si rigenera l’auctoritas delle nazioni e si riforma la polis come comunità dialogica. In tal modo, la cultura si fa diplomazia, la dignità diviene misura del potere, e la partecipazione torna ad essere la forma più alta della libertà.
Il potere come diaconia istituzionale
Il potere, nella sua essenza più alta, non è dominio, ma servizio: non imposizione, ma diaconia istituzionale. In questa prospettiva, il potere si configura come responsabilità verso l’altro, come atto di custodia dell’umanità e come arte del governo orientata al bene comune. Già Cicerone, nel De officiis, riconosceva che l’esercizio della potestas non può mai essere separato dall’idea di officium, ossia dal dovere di agire secondo giustizia, verità e decoro. Il potere autentico non risiede dunque nella capacità di comandare, ma nella virtù di servire il diritto; è un potere che si piega per elevare, che si limita per rendere possibile la libertà altrui, che rinuncia alla prevaricazione per garantire la coesistenza. Nel linguaggio delle istituzioni romane, la potestas trovava il suo fondamento nell’auctoritas, cioè nel riconoscimento etico e spirituale della legittimità. L’auctoritas dei patres non era un potere coercitivo, ma un atto di conferma e di ratifica: il segno di un ordine in cui la forza si trasforma in autorevolezza e la decisione diviene espressione di sapienza condivisa. Nella logica del diritto romano, l’auctoritas era dunque la dimensione spirituale della potestas, il suo principio di misura. Il potere senza auctoritas degenerava in arbitrio; l’auctoritas senza potestas restava pura intenzione morale. È nella loro sinergia che si dischiude la via del governo giusto. Il potere come diaconia istituzionale si innesta su questa genealogia antica, ma trova nel tempo presente una nuova profondità teologica e politica. Esso è servizio alla persona e alla comunità, mediazione tra l’individuale e l’universale, tra il diritto positivo e il diritto naturale, tra la libertà e l’ordine. Lungi dall’essere un semplice strumento di gestione, il potere è una vocazione etica al bene comune, un’arte dell’equilibrio e della mediazione, una forma di cura. Quando esso perde la consapevolezza di tale vocazione, si corrompe; quando si richiude su di sé, tradisce la propria natura; quando si allontana dal bene comune, dissolve la legittimità che lo fonda. Cicerone, nella sua riflessione sulla res publica, aveva colto il rischio di questa deriva. La crisi delle istituzioni, la decadenza dei costumi e la frattura tra privatum consilium e publicum consilium, rivelano che il potere politico, quando si separa dall’ethos, perde la sua anima. Nella riflessione più alta, il modello ideale del governante, non è colui che domina, ma colui che regge la comunità come un genitore, consapevole che la sua forza risiede nella capacità di suscitare concordia. Il potere è dunque ministerium civitatis: si giustifica solo nella misura in cui tende a costruire la casa comune, ad armonizzare le differenze, a rendere operativa la giustizia. Il potere si fa servizio al bene comune per mezzo del diritto perché, nella sua forma più alta, diventa percorso che porta alla giustizia universale: un potere che regge senza opprimere, che corregge senza annientare, che guida senza possedere. È questo il paradigma della auctoritas servans, dell’istituzione che vive per la dignità dei popoli, e che riconosce nella legge non la limitazione della libertà, ma il suo compimento razionale e morale.
Il diritto come via della giustizia
Il diritto è la via maestra attraverso la quale la diaconia istituzionale diventa concreta. Esso non è mera tecnica, ma arte della convivenza: è la forma visibile della giustizia, la traduzione normativa dell’idea di bene comune. Per Cicerone, il diritto nasce dalla natura stessa delle cose; esso è il riflesso della recta ratio, la ragione giusta che unisce gli uomini in una comunione spirituale prima ancora che civile. Nelle Leges e nel De officiis, egli ricorda che non vi è giustizia dove manca la legge, e non vi è legge dove non vi sia rispetto per l’uomo. Il diritto, in quanto espressione del logos umano, è la strada che collega la libertà alla responsabilità, il potere alla moralità, la decisione alla misura. È il ponte che traduce il dovere in norma e la virtù in istituzione. Quando il diritto si separa dalla giustizia, si svuota; quando la giustizia si distacca dal diritto, si dissolve. La loro unità è ciò che consente alla civiltà di sussistere e di progredire. La tradizione romanistica, reinterpretata nel corso dei secoli, ha trasmesso all’umanesimo giuridico europeo questa convinzione: che il diritto è strumento di educazione del popolo e scuola di libertà. Non a caso, Cicerone parlava della libertas in iure come della più alta forma di libertà, quella che non si fonda sull’arbitrio, ma sulla consapevolezza del limite. La libertà del cittadino, per essere reale, deve essere radicata nel diritto: non libertà da, ma libertà per, orientata all’agire giusto, alla responsabilità comune, alla salvaguardia dell’altro. Nell’orizzonte contemporaneo, il diritto non può più essere inteso come strumento di mera regolazione, ma come veicolo di trasformazione per il pieno e autentico sviluppo della persona umana. Esso è il linguaggio attraverso cui la dignità umana diventa principio operativo, la grammatica della convivenza che traduce in norme la coscienza collettiva dei popoli. In questo senso, il diritto non si limita a descrivere la società, ma la plasma, la educa, la trascende. È la via che conduce all’utopia concreta della giustizia, non perché la realizzi interamente, ma perché la tiene sempre aperta come tensione regolativa, come promessa dell’umano. La giustizia universale, come fine utopico, non è un ideale irraggiungibile, ma una direzione. Essa è la meta che orienta l’azione politica e la riflessione giuridica, la stella polare che impedisce al diritto di ridursi a strumento di potere locale. Ecco perché il giurista, nel senso più alto, è un servitore della giustizia, un mediatore tra il mondo del dover essere e la concretezza della storia. La sua opera è di autentica diaconia, di servizio al bene dei popoli, come quella del legislatore e del giudice, poiché tende a rendere la giustizia non un concetto, ma un’esperienza vivente.
La dignità come fondamento del diritto e principio di libertas
Se il potere è servizio e il diritto è via, la dignità è il fondamento. Tutto l’edificio della giustizia e della convivenza si regge su questo principio superiore, che precede le istituzioni e ne misura la legittimità. La dignità non è una qualità concessa, ma un diritto originario; non è una proprietà individuale, ma una relazione universale che unisce tutti gli esseri umani nel riconoscimento reciproco. La Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II ha espresso con forza questa verità, affermando che la libertà e la giustizia nascono dal riconoscimento della persona come soggetto morale e spirituale, capace di agire secondo coscienza. In tal senso, la dignità è il presupposto della libertas: non c’è libertà senza dignità riconosciuta, e non c’è dignità senza libertà esercitata. La dignità è anche il criterio che unifica il diritto positivo e quello naturale, poiché in essa si radica la fonte del diritto vivente. È la pietra angolare di ciò che oggi potremmo chiamare ius cosmopoliticum dignitatis, un diritto dei popoli e per i popoli, fondato non sul dominio ma sull’incontro, non sulla forza ma sulla fiducia. Nei testi contemporanei sul diritto vivente, la dignità cosmica come strada del benessere dei popoli, la dignità appare come categoria giuridica e cosmica, principio che lega l’ordine umano a quello universale. Essa non è solo attributo morale, ma criterio regolativo dell’ordine internazionale, in quanto vincola gli Stati e le istituzioni alla fedeltà, alla buona fede e alla correttezza reciproca. In questo senso, la dignità è libertà ordinata, armonia giuridica, equilibrio etico delle relazioni. Nella prospettiva di una nuova civiltà delle relazioni, la dignità diventa il motore di un’ecologia integrale del diritto. È ciò che consente ai popoli di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza, di riconquistare la propria libertas come progetto di vita comune. Essa è la linfa vitale di ogni ordinamento giuridico dei popoli, il fondamento invisibile che trasforma il diritto in diaconia e la legge in caritas politica.
L’auctoritas dei popoli e la coscienza critica della polis
Nessun potere è legittimo se non si radica nell’auctoritas dei popoli, e nessuna auctoritas è autentica se non si nutre della coscienza critica. La legittimità politica non nasce dal consenso formale, ma dalla capacità di suscitare partecipazione, di promuovere il pensiero libero, di formare cittadini consapevoli. Come mostra la storia della Repubblica romana, la auctoritas non si impone, ma si conquista nel tempo, attraverso la coerenza e la virtù. È la forza morale che conferisce legittimità alla potestas, l’anima invisibile delle istituzioni. Quando la auctoritas si indebolisce, le democrazie si svuotano e la partecipazione si trasforma in routine. Il grande astensionismo contemporaneo è il segno di questa malattia democratica: la disaffezione verso la polis, la perdita del senso del “noi”, la riduzione della politica a tecnica amministrativa. Per risanare la polis è necessario formare la coscienza critica dei popoli. Pensare, domandare, discernere: sono atti politici prima ancora che intellettuali. Sviluppare il logos e il nomos dei popoli significa educarli a ritrovare se stessi e la loro auctoritas, ossia la dignità che legittima ogni potere. In questo processo, le universitas svolgono un ruolo decisivo. Esse sono il luogo in cui si genera la libertà del pensiero e si costruisce l’etica della responsabilità; sono le scuole della polis, i laboratori in cui il potere si misura con la verità e la giustizia con il sapere. Il voto del popolo, nella sua duplice forma di elettorato attivo e passivo, diventa allora il sacramento laico della cittadinanza: segno di una comunità che si riconosce, che si interroga, che si costruisce insieme.
Le universitas come architettura vivente della sinfonia delle diversità
Nel mondo contemporaneo, la rete delle università costituisce il cuore pulsante della diplomazia del sapere e della costruzione del bene comune. Esse rappresentano l’ordo amoris della conoscenza: un ordine universale che non uniforma, ma armonizza; che non impone, ma collega. Le universitas sono le custodi della libertà critica e le fucine della democrazia culturale. In esse si forma la coscienza dei popoli, si educa la virtù politica, si costruisce la visione ontologica del bene pubblico. Esse sono le architetture viventi della sinfonia delle diversità, in cui il diritto si fa musica del convivere, e la scienza diventa strumento di pace. La diplomazia scientifica e culturale è oggi la forma più alta di potere, perché fonda la politica sulla cultura e la cultura sul servizio. Le università, in questa visione, non sono solo luoghi di trasmissione del sapere, ma soggetti attivi di governance etica e di trasformazione globale: ponti tra le culture, tessitrici di un diritto umano universale, interpreti del noi panumano. Solo una diplomazia della conoscenza, fondata sulla dignità e sulla libertà del pensiero, potrà rendere il diritto strumento di pace e il potere atto di servizio. Così, la diaconia istituzionale si compie: il potere serve, il diritto educa, la dignità fonda, la cultura unisce. E l’umanità, attraverso la sinfonia delle sue diversità, ritrova se stessa come comunità di destino, guidata dalla giustizia e illuminata dalla libertà.