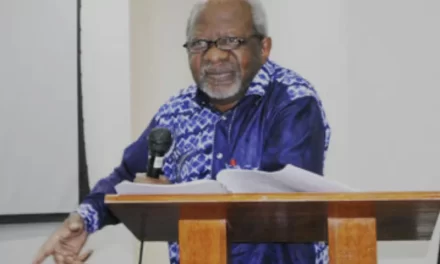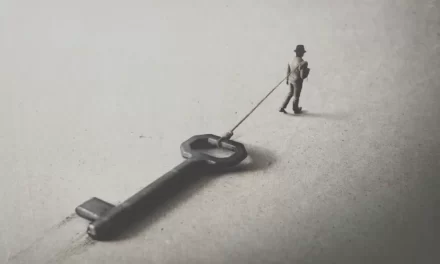La seduta del 26 luglio 1946 non rappresenta soltanto un episodio iniziale dei lavori costituenti, ma un momento fondativo dell’identità giuridica della Repubblica. In essa prende forma la visione di un ordinamento che riconosce la persona come centro e misura della vita democratica, un ordinamento chiamato a proteggere la dignità, a promuovere la libertà responsabile e a edificare una società in cui la politica non si sostituisce all’uomo, ma lo serve. È questo il significato più autentico della nascita dell’idea di persona nella Costituente: un’idea che, grazie all’opera di Aldo Moro e degli altri costituenti, continua a orientare la Repubblica verso la piena realizzazione della dignità umana.
La prima seduta della Prima Sottocommissione della Costituente rappresenta uno dei momenti più significativi nei quali, pur in assenza di una discussione esplicita e già matura sul catalogo dei diritti fondamentali, prende forma la consapevolezza che la futura Carta non potrà essere costruita senza un riferimento essenziale alla persona umana quale fondamento del nuovo ordine democratico. Le comunicazioni introduttive del Presidente, nel sollecitare un metodo di lavoro capace di procedere con ordine e sistematicità, evidenziano fin dall’inizio che la Commissione è chiamata non soltanto a individuare un insieme di norme da coordinare, ma soprattutto a definire l’architettura concettuale che reggerà l’intero edificio costituzionale, all’interno della quale dovrà trovare sede il riconoscimento dei «diritti fondamentali delle libertà della persona umana». Già questa prima formulazione rivela che il soggetto della tutela costituzionale non è l’individuo astratto della tradizione giusliberale, bensì la persona concreta, portatrice di dignità, di esigenze spirituali e materiali, di appartenenza comunitaria, e non riducibile alle sole funzioni economico-sociali. Il dibattito si concentra inizialmente sulla determinazione dei compiti della Sottocommissione, ma tale questione organizzativa si intreccia immediatamente con un interrogativo più profondo: come articolare i futuri diritti e doveri, in modo che l’idea di persona non sia sacrificata a una costruzione formale priva di radicamento umano? Il confronto tra i membri della Sottocommissione dà vita a una riflessione che, pur rimanendo ancora nella fase preliminare, lascia intravedere la tensione tra diverse antropologie politiche. Grassi, ad esempio, propone di distinguere tra dichiarazioni generali e disposizioni specifiche di diritti e doveri, invitando a elaborare una struttura organica capace di includere non soltanto le libertà individuali ma anche i doveri sociali. La Pira, in piena sintonia con le correnti cristiano-sociali, insiste sulla necessità di definire un «integrale organico dei diritti della persona», sottolineando che questi non possono essere concepiti al di fuori delle formazioni sociali in cui la persona si esprime e si realizza. Tale riferimento alla dimensione relazionale come condizione costitutiva della soggettività giuridica rappresenta una delle prime manifestazioni del paradigma personalistico destinato a orientare la stesura degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Nel contempo, Lombardi Giovanni pone l’accento sul primato delle libertà spirituali, ammonendo che un’impostazione materialistica non riuscirebbe a garantire la «libera esplicazione» della persona, la quale necessita di un riconoscimento che vada oltre il soddisfacimento dei bisogni immediati. Ciò dimostra come, già nelle prime fasi del lavoro, la Sottocommissione considerasse la persona non come una semplice entità giuridica da tutelare, ma come un essere dotato di una profondità spirituale che occorre riconoscere ordinando i principi costituzionali in modo coerente, evitando sia l’appiattimento della persona sulle sue esigenze materiali, sia l’astrazione di diritti privi di fondamento nella vita concreta. Da questa prospettiva, la seduta del 26 luglio 1946 si presenta non come un momento meramente organizzativo, ma come l’alba di una nuova comprensione della persona nella dimensione costituzionale. Le discussioni mostrano con evidenza che i costituenti non intendono elaborare un testo normativo compilativo o derivativo, ma desiderano costruire un impianto organico capace di rispecchiare la complessità e la dignità dell’essere umano. In tale quadro, l’identità giuridica della persona non è mai disgiunta dalla sua vocazione comunitaria, né dalla necessità che lo Stato garantisca non solo diritti formali, ma condizioni reali di sviluppo umano. Il metodo stesso, lungi dal costituire una questione formale, diviene veicolo essenziale attraverso cui l’idea di persona potrà esprimere tutta la sua capacità generativa: la persona è il centro dell’ordinamento, ma è al tempo stesso il criterio della sua costruzione.
L’intervento di Aldo Moro e l’emersione dell’idea di persona come criterio metodologico della Costituzione
È tuttavia con l’intervento di Aldo Moro che la nascente idea di persona riceve la sua più compiuta articolazione metodologica, acquistando una forma giuridica destinata a rimanere decisiva per l’intera elaborazione costituzionale. Moro afferma che il «punto essenziale» dei lavori consiste nello «stabilire un piano sistematico» che consenta alla Sottocommissione di procedere ordinatamente alla definizione dei diritti e dei doveri, evitando dispersioni e anticipazioni improprie. Questa affermazione, in apparenza organizzativa, racchiude una scelta culturale di grande spessore: per Moro, la persona non deve essere inserita nella Costituzione come un oggetto normativo predefinito, né come il risultato di un’impostazione ideologica preesistente, ma deve emergere dal confronto ordinato delle dimensioni fondamentali dell’umano. Ciò presuppone che la Costituzione non sia costruita come una giustapposizione di diritti e rivendicazioni, bensì come un sistema organico capace di riflettere la verità integrale dell’essere umano. Moro mette in guardia contro il rischio di anticipare discussioni etiche o filosofiche «prive di sistemazione», poiché simili anticipazioni possono «aggravare lo spirito» del dibattito e compromettere il lavoro futuro. La sua preoccupazione non riguarda l’irrilevanza delle questioni etiche, ma l’esigenza che esse non vengano trattate in modo disordinato, generando un clima polemico che finirebbe per oscurare il fine più alto della costruzione costituzionale: il riconoscimento della persona nella sua unità. Di qui discende un principio fondamentale del costituzionalismo moroteo: il metodo non è una procedura tecnica, ma l’argine che impedisce alla persona di essere sacrificata alla contingenza politica. Il metodo è ciò che preserva l’oggettività della persona, impedendo che venga deformata dal peso delle ideologie o dalle urgenze del momento. Per questo Moro insiste affinché la Sottocommissione non devii dall’individuazione dei diritti fondamentali «dell’uomo e del cittadino», riconoscendo implicitamente che la persona possiede una dignità anteriore allo Stato, che lo Stato non crea ma riconosce; una dignità che la Costituzione dovrà custodire e promuovere. Questo intervento rappresenta un momento di svolta nella nascita dell’idea costituzionale di persona. Moro pone la persona non come uno dei tanti temi da affrontare, ma come il criterio metodologico da cui dipende l’intero impianto dei principi fondamentali. Egli comprende che una Costituzione disordinata o ideologizzata finirebbe per tradire la persona, mentre una struttura coerente, fondata sul metodo e sulla ricerca della verità, potrà garantire un riconoscimento reale della dignità umana. La sua visione anticipa la futura formulazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, e in particolare l’idea che i diritti inviolabili non siano concessioni statali, ma riconoscimenti di prerogative radicate nella natura stessa dell’uomo. Si tratta di una prospettiva che fonde insieme realismo giuridico e profondità antropologica: la persona è al centro non perché l’ordinamento lo affermi, ma perché è la struttura stessa dell’essere umano, nella sua dimensione spirituale, razionale, sociale e relazionale, ad esigere che l’ordinamento la custodisca. In tal modo, Moro conferisce alla Costituente un orientamento che ne segnerà in modo indelebile la storia.
La persona come architrave della futura Costituzione
Alla luce di quanto emerso nelle discussioni del 26 luglio 1946, la persona si configura non come un oggetto passivo di tutela, ma come l’architrave attorno alla quale la Costituzione deve sviluppare la propria coerenza interna. La seduta mostra che i costituenti erano pienamente consapevoli che una Costituzione priva di fondamento antropologico si sarebbe trasformata in un testo frammentario, incapace di orientare il futuro della Repubblica. La persona emerge così come categoria unificante, in grado di ricomporre le tensioni tra libertà e doveri, tra individuo e società, tra materie spirituali e materiali, garantendo un equilibrio che non è semplice mediazione politica ma riconoscimento della struttura integrale dell’umano. In questo senso, i richiami di Moro assumono un valore decisivo: il metodo come ordine; l’unità come criterio; la persona come centro. Il lavoro costituente viene così sottratto al rischio della frammentazione ideologica e indirizzato verso una sintesi che troverà la sua formulazione più alta nei principi fondamentali della Carta. La discussione sulla scelta dei relatori, sulle priorità da attribuire ai diritti spirituali rispetto a quelli economici, sul ruolo degli enti sociali come luoghi di espressione della persona, conferma che la Sottocommissione avvertiva l’esigenza di costruire una Costituzione che non fosse solo un documento giuridico, ma un progetto di civiltà. Nel richiamare la «natura» dei diritti e dei doveri, nel discutere la loro gerarchia e il loro ordine interno, i membri della Commissione anticipano infatti il futuro impianto personalista dell’articolo 2, destinato a riconoscere e garantire i diritti inviolabili non dell’individuo isolato, ma della persona nelle «formazioni sociali» dove si svolge la sua personalità. La persona, nelle parole e nelle intenzioni dei costituenti, non è mai un atomo separato, ma un essere in relazione, che trova nella società, nella famiglia, nel lavoro, nella scuola e nella comunità civile i luoghi costitutivi della sua piena realizzazione. È in questa prospettiva che la prima seduta del 26 luglio assume oggi una forza profetica. In un tempo in cui le società occidentali sembrano smarrire la profondità antropologica che aveva sostenuto lo sviluppo democratico del dopoguerra, tornare alle radici del personalismo costituzionale significa ritrovare la verità più alta dell’ordinamento repubblicano: la persona come misura del diritto e come fine della politica. L’eredità di quella seduta non consiste in un semplice elenco di proposte né in un esercizio tecnico, ma in un’impostazione culturale che ha segnato l’intero percorso della Costituzione italiana. La consapevolezza che il metodo deve proteggere la verità della persona, che il dibattito deve essere ordinato e non polemico, che la Costituzione deve esprimere l’unità dell’umano, rimane uno dei tratti più preziosi della riflessione morotea. La persona diventa così non solo protagonista ma principio, non solo soggetto ma fondamento, non solo destinataria ma origine della Costituzione.