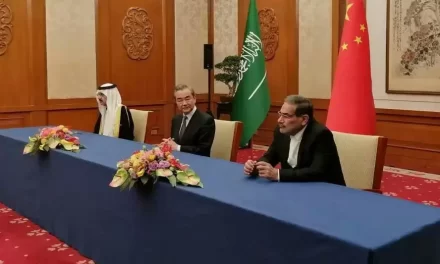I media mainstream parlano di tregua vicina, ma sul fronte si continua a morire
Un giorno la pace è lì, a portata di mano: “questione di giorni”, dicono. Il giorno dopo torna il ritornello opposto: la colpa è di Putin che non vuole negoziare. In mezzo, come sempre, ci sono i corpi. E c’è l’Europa: presente a ogni tavolo, decisiva in ogni comunicato, ma raramente capace di una voce che cambi davvero la traiettoria degli eventi.
È martedì 16 dicembre 2025 e il pendolo mediatico oscilla con una rapidità che sembra indecente rispetto alla lentezza con cui la guerra macina vite. Volodymyr Zelensky sostiene che le proposte di pace discusse con gli Stati Uniti a Berlino potrebbero essere finalizzate in pochi giorni, per poi essere portate a Mosca dagli inviati americani. Lo dice con realismo: la bozza “non è perfetta”, ma è “fattibile”; e subito aggiunge la frase che conta: la questione dei territori resta il nodo.
Qui sta la verità nuda della guerra: la pace, finché non tocca la geografia, resta un’ipotesi. Washington e Kiev parlano di un piano ampio, di più documenti, di una costruzione di garanzie “forti”. Ma sul Donbas e sulla Crimea il linguaggio si irrigidisce: Zelensky ribadisce che l’Ucraina non riconoscerà come russa alcuna parte del Donbas; il Cremlino pretende invece che siano riconosciute come russe le aree annesse e la Crimea.
Nel frattempo, però, la diplomazia statunitense appare l’unico motore capace di imprimere ritmo. L’America — con i suoi emissari e con la pressione politica della Casa Bianca — dichiara che Ucraina ed Europa sarebbero d’accordo su circa il 90% del piano. E si parla di nuovi incontri, perfino di una sessione di lavoro negli Stati Uniti, mentre l’idea di garanzie postbelliche prende la forma di un doppio binario: forza a guida europea sul terreno e meccanismo di monitoraggio a guida Usa.
L’Europa qui mostra la sua ambivalenza: indispensabile come portafoglio e come retrovia industriale, ma ancora incerta come soggetto politico. Da una parte, alcuni leader insistono sull’urgenza di rafforzare il fianco orientale; dall’altra, l’Unione continua a inciampare sulle sue stesse fratture interne, come dimostra l’ennesimo braccio di ferro sull’allargamento e sull’Ucraina, con Budapest che blocca o diluisce. La linea comune, quando c’è, appare spesso un compromesso scritto per non far saltare la foto di gruppo.
E mentre si discute di “garanzie”, in guerra la parola “tregua” è già diventata sospetta. Il Cremlino ripete che non vuole una pausa temporanea che permetta a Kiev di riorganizzarsi, ma un accordo “globale”: è il modo elegante di dire che, senza concessioni territoriali e senza limiti strutturali all’Ucraina, la Russia non considera conclusa la partita. Anche la proposta di una tregua natalizia viene respinta o subordinata a un’intesa più ampia.
Nel frattempo, la guerra si allarga lateralmente, come fanno tutte le guerre lunghe. Non è un dettaglio, oggi, che Ankara lanci allarmi ripetuti sulla sicurezza della navigazione nel Mar Nero, dopo attacchi e incendi che hanno coinvolto anche navi mercantili: se il mare diventa instabile, l’economia europea lo sente prima ancora della politica. La guerra che “sta per finire” continua a produrre nuovi fronti di rischio.
C’è poi un altro capitolo che rivela l’impotenza europea: la giustizia e il denaro. Zelensky chiede con insistenza l’uso degli asset russi congelati per la difesa e la ricostruzione; intanto nascono strumenti internazionali per quantificare danni e richieste. Ma ogni passo tocca interessi, timori di ritorsioni, nervi giuridici scoperti: e l’Europa, che avrebbe la massa critica per decidere, spesso preferisce sperare che sia Washington a “chiudere” la pratica. È una dipendenza strategica mascherata da prudenza.
In questo scenario, l’alternanza quotidiana tra ottimismo e disincanto non è solo comunicazione: è la fotografia di un problema strutturale. La pace viene raccontata come un evento imminente perché serve a tenere insieme alleanze, opinioni pubbliche stanche, bilanci sotto pressione. Ma la guerra resta reale perché le condizioni minime di una fine condivisa — soprattutto sui territori e sulle garanzie — non sono ancora mature.
E allora sì: oggi dicono che “si risolve tutto”. Domani diranno che “Putin non vuole negoziare”. Probabilmente saranno vere entrambe le cose, a metà. Ma ciò che non cambia è la sostanza: finché la guerra resta l’unico linguaggio davvero efficace sul terreno, ogni bozza di pace rischia di essere solo un modo più sofisticato per rinviare la prossima offensiva.