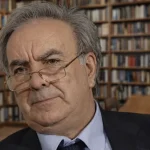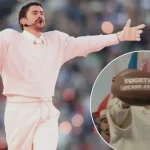Quando un accordo governativo si trasforma in catena per chi fugge, la politica perde la dignità e la vulnerabilità diventa cifra del compromesso. Il rinnovo tacito del Memorandum d’intesa tra Italia e Libia – avvenuto di recente nonostante l’allarme costante delle ONG e delle organizzazioni per i diritti umani – è la prova che la retorica dell’accoglienza può piegarsi alla logica del muro.
Il testo del 2017, e i suoi successivi rinnovi, prevedono che la sorveglianza e il controllo delle traversate via mare vengano esternalizzati: la Libia, attraverso la sua Guardia costiera, intercetta, riporta, detiene; l’Italia e l’Unione Europea forniscono mezzi, formazione e fondi. Questo meccanismo – costruito sulla paura del “flusso” più che sulla protezione della vita – oggi mostra le sue crepe: i “centri” libici dove convergono profughi e migranti sono stati ripetutamente denunciati come luoghi di detenzione arbitraria, tortura, abusi sistematici.
Le ONG non restano in disparte. In Italia, 13 realtà (tra cui Sea‑Watch, Mediterranea Saving Humans) hanno annunciato la nascita della “Justice Fleet” – una coalizione che rifiuta di collaborare con il Centro di Coordinamento dei Soccorsi libico, denunciando un “diritto alla vita” calpestato. Le denunce raccolte parlano di avvistamenti in mare, spari contro imbarcazioni in difficoltà, motivi di morte evitabili.
Dal punto di vista morale, c’è una domanda che brucia: è accettabile che uno Stato europeo si affidi a un partner dove la prigione per migranti è la norma e il respingimento una strategia? Organizzazioni come Amnesty International e Human Rights Watch lo ripetono da anni: “Italia e UE devono sospendere qualsiasi cooperazione che comporti contenimento e abusi in Libia”.
Eppure, anche nella tempesta di critiche, la politica guarda altrove: al contenimento dei numeri; all’immagine; al “bonus” mediatico di aver “ridotto gli sbarchi”. Ma dimentica che ogni vita è un conto aperto, non un grafico da abbattere con l’aritmetica del veto.
La stampa cattolica internazionale, come quella di Nigrizia, ha ben descritto come motovedette italiane siano coinvolte in azioni in Libia, e come un sistema – tra cofinanziamenti, addestramenti e materiali – abbia preso corpo non nella garanzia della protezione, ma nella produzione del respingimento.
La questione delle ONG è altrettanto grave: esse vengono obbligate a comunicazioni operative con le autorità libiche per svolgere operazioni di soccorso, un vincolo che molte definiscono “pressione ingiusta” su chi dovrebbe salvare vite, non gestire accordi militari.
Dunque: il contratto rinnovato tra Italia e Libia ha un volto. Non soltanto quello del patto politico o della cooperazione interstatale. È il volto dei migranti riportati in siti dove i diritti non esistono, delle ONG ostacolate, delle vite affidate all’incertezza. È il volto dell’Europa che vuole difendere le proprie coste invece di difendere i principi.
La morale è semplice, ma urgente: il bene comune richiede che i confini non diventino recinti della disperazione. La storia ci interroga: una democrazia che accetta accordi basati sulla delega del controllo verso partner che violano i diritti, tradisce se stessa. E se il rischio è quello di trasformare il soccorso in tecnologia del respingimento, allora è l’umanità ad esser tradita.
È tempo di un cambiamento reale: che l’Italia riprenda la linea del diritto internazionale, che le ONG possano operare liberamente, che la Libia non sia una zona di contenimento ma un corridoio di solidarietà. Altrimenti, si scrive nelle carte, ma si vive nella vergogna.