Un attacco alla democrazia che non possiamo ignorare
Il 14 giugno 2025 segna una data tragica nella storia politica degli Stati Uniti. In Minnesota, la deputata statale Melissa Hortman e suo marito Mark sono stati assassinati nella loro casa di Brooklyn Park. Poche ore prima, il senatore John Hoffman e sua moglie erano rimasti feriti in un altro agguato. Gli attacchi, eseguiti da un uomo armato travestito da poliziotto e dotato di maschera in lattice, rivelano una premeditazione inquietante, legata a motivazioni politiche e ideologiche.
Non si tratta di episodi isolati o dettati dalla follia: siamo davanti a una forma di terrorismo interno, alimentata da odio e da una polarizzazione sociale che da anni matura nel silenzio complice di molte istituzioni. Il killer, identificato come Vance Boelter, era in possesso di un vero e proprio manifesto con una lista di obiettivi: politici, sanitari, attivisti. Un elenco di “nemici” da eliminare, secondo una logica perversa che nulla ha a che fare con la democrazia e tutto con l’odio organizzato.
La censura dei dettagli, il silenzio su alcuni aspetti — come il fatto che l’aggressore avesse pianificato di usare travestimenti da forze dell’ordine, o che fosse riuscito a colpire più volte senza essere fermato — non fanno che aggravare il senso di smarrimento. Lo stesso uso delle armi, la facilità con cui si è potuto agire indisturbati, interroga duramente un sistema che predica libertà ma non garantisce sicurezza.
Il governatore del Minnesota ha parlato senza mezzi termini di “omicidio politico”, e ha avuto ragione. La senatrice Klobuchar ha detto che l’attacco ha colpito “tutto ciò che la democrazia rappresenta”. Ma le parole, per quanto forti, non bastano. Non ci si può limitare alla condanna. Occorre una presa di coscienza radicale. L’estremismo ideologico non nasce dal nulla. Si nutre di retorica incendiaria, di impunità, di social network trasformati in arene di odio.
La morte di Melissa Hortman e le ferite inflitte a John Hoffman sono il frutto di un clima malato. E non riguarda solo l’America. Ogni democrazia che tollera il linguaggio dell’odio, che minimizza le minacce o che consente la disumanizzazione dell’avversario politico, apre la porta a questa deriva.
Papa Leone XIV, nel suo primo discorso al corpo diplomatico, ha affermato che “la pace sociale si costruisce solo dove la giustizia è nutrita dalla verità e disarmata dalla misericordia”. Queste parole non sono un ornamento spirituale, ma una bussola politica. Oggi più che mai, davanti a questi fatti, abbiamo bisogno di verità che chiami le cose col loro nome, di giustizia che non sia vendetta e di misericordia che non sia debolezza.
Non bastano il cordoglio e le bandiere a mezz’asta. Servono leggi più rigorose, protezioni efficaci per chi serve lo Stato, strumenti per prevenire la radicalizzazione violenta. Ma soprattutto serve un impegno collettivo a ricostruire la cultura del confronto, della parola civile, del rispetto.
Perché la democrazia non si difende solo nei tribunali o nelle urne. Si difende ogni giorno, nelle parole che scegliamo, nei gesti che compiamo, nel modo in cui trattiamo chi non la pensa come noi.
E se è vero, come ha scritto un editorialista americano, che “la fortuna degli Stati Uniti è finita”, noi possiamo ancora scegliere di non fare lo stesso errore. Possiamo ancora dire: mai più. E possiamo, anzi dobbiamo, farlo adesso.















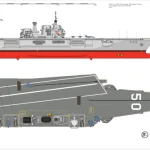



Quando anche in Itaia si usano certi toni si incita alla violenza. C’è gente squilibrata in giro. La retorica politica va rivista e corretta.