Se guardiamo la scena pubblica contemporanea, la tentazione è descriverla come un semplice duello: destra contro sinistra, conservatori contro progressisti, sovranisti contro globalisti. Ma questa mappa è sempre più insufficiente. Accanto agli estremismi che alzano la voce – e spesso raccolgono rabbia reale – si è consolidato un mainstream dei potenti: un blocco trasversale, capace di parlare il linguaggio dei “diritti” quando serve e quello del “mercato” quando conviene, ma soprattutto capace di trasformare il consenso in gestione tecnica e la democrazia in amministrazione della complessità. È qui che il liberalismo – inteso come cultura politica della libertà, del pluralismo e dei limiti del potere – rischia di confondersi con il suo doppio: un liberalismo ridotto a procedura, compatibile con diseguaglianze crescenti e con una concentrazione di potere economico e informativo che, nei fatti, erode la libertà dei molti.
La frattura: quando la libertà perde il suo “popolo”
Il liberalismo europeo e occidentale ha retto finché è stato percepito come un patto: libertà individuali, istituzioni credibili, mobilità sociale, welfare, ascensore educativo. Quando quel patto si incrina, le parole restano ma cambiano di segno: “merito” diventa giustificazione della rendita; “competizione” diventa precarietà permanente; “innovazione” diventa deregolazione selettiva. Le disuguaglianze non sono solo una questione economica: diventano una questione spirituale e civile, perché intaccano la fiducia reciproca.
Non è un’impressione: indicatori internazionali mostrano come la distanza tra ricchi e poveri resti strutturale nelle economie avanzate; ad esempio, nei Paesi OCSE il rapporto medio tra reddito del 10% più ricco e del 10% più povero è stato stimato attorno a 8,4 a 1 (dato riferito al 2021). E istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale mettono esplicitamente in guardia: disuguaglianze “eccessive” possono erodere la coesione sociale e alimentare polarizzazione politica, oltre a danneggiare la crescita.
Quando la promessa di una libertà “per tutti” perde credibilità, il sistema produce due reazioni speculari. Da un lato gli estremismi: semplificano, cercano capri espiatori, promettono protezione identitaria. Dall’altro il centro tecnocratico-oligarchico: invita alla calma, spiega che “non ci sono alternative”, governa con algoritmi, emergenze e linguaggi di inevitabilità. In mezzo, milioni di persone si sentono inermi: e l’inerzia è il terreno dove la democrazia si sfibra.
Non solo destra e sinistra: il potere “impersonale” del turbocapitalismo
C’è un punto che spesso sfugge: il danno non viene soltanto dalla radicalizzazione politica. Viene anche dall’asimmetria di potere prodotta da un capitalismo finanziarizzato e digitale che tende a concentrare ricchezza, influenza normativa e controllo delle infrastrutture del discorso pubblico. Quando questo avviene, la libertà formale resta, ma la libertà sostanziale diminuisce: non è censura classica, è dipendenza (dati, piattaforme, debito, precarietà, filiere essenziali).
Le analisi recenti sulla diseguaglianza globale – pur con differenze tra fonti e metodologie – convergono su un fatto: la ricchezza è fortemente concentrata e ciò si traduce in potere politico e capacità di orientare regole e narrazioni. In parallelo, la nuova frontiera tecnologica rischia di amplificare i divari: la Organizzazione mondiale del commercio ha avvertito che l’adozione dell’IA può accrescere la disuguaglianza globale se i Paesi con meno infrastrutture e accesso restano esclusi dai benefici.
È questo l’aspetto “spirituale” della questione: il turbocapitalismo non ferisce solo redistribuzione e lavoro; ferisce anche l’immaginario umano, perché propone una antropologia implicita: l’uomo come produttore/consumatore, la relazione come transazione, la politica come marketing, la verità come engagement. L’esito è una società che può anche dichiararsi “libera” ma diventa più fragile, più ansiosa, più sola.
La crisi del liberalismo è anche crisi di fiducia e di cooperazione
Il liberalismo, storicamente, ha bisogno di un presupposto: un livello minimo di fiducia nelle istituzioni e nella possibilità di cooperare. Ma i grandi shock dell’ultimo quindicennio (crisi finanziarie, pandemie, guerre, inflazione, transizione energetica) hanno stressato quel capitale sociale. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo parla apertamente di un mondo più polarizzato e di una “gridlock” pericolosa, legata a disuguaglianze e incapacità istituzionali di rispondere a sfide interdipendenti; segnala anche l’aumento della polarizzazione in molti Paesi nel periodo recente.
Quando la politica non riesce a governare la complessità, la complessità governa la politica. E in quel vuoto entrano due “religioni civili” concorrenti: la radicalizzazione identitaria (che promette purezza e nemici chiari) e l’iper-economismo (che promette efficienza e inevitabilità). Entrambe, a modo loro, impoveriscono l’umano.
Che cosa dire “nel merito”: una critica che non diventi cinismo
Dire che il mainstream turbocapitalista produce danni non significa assolvere gli estremismi. Significa evitare l’errore opposto: pensare che basti “contenere i populismi” per guarire la democrazia. Se le persone percepiscono che il gioco è truccato – che la ricchezza compra influenza e la fragilità paga sempre – allora gli anticorpi democratici si indeboliscono.
Una lettura esigente, oggi, dovrebbe tenere insieme quattro verità:
La libertà politica senza giustizia sociale tende a diventare privilegio. Lo suggeriscono i dati sulla disuguaglianza e i nessi con la polarizzazione.
La giustizia sociale senza libertà politica tende a diventare controllo: gli estremismi “salvifici” possono promettere ordine, ma spesso chiedono in cambio obbedienza e uniformità.
La tecnologia non è neutrale: può emancipare o dominare, a seconda di chi possiede infrastrutture, dati, regole e capacità di indirizzare l’innovazione.
La “salvezza” non è solo economica: è anche culturale e morale. Se la vita comune diventa una guerra di status o una vetrina permanente, le società si disgregano anche se il PIL cresce.
Un possibile recupero: liberalismo come limite al potere, non come scusa del potere
Se il liberalismo vuole sopravvivere come progetto umano (non come etichetta), deve tornare a essere ciò che promette: un argine ai poteri. Tutti: politico, economico, mediatico, tecnologico. In pratica, significa mettere al centro alcuni cantieri che oggi sono la vera frontiera “non ideologica” della democrazia:
ricostruire un patto sociale credibile (salari dignitosi, protezioni nei passaggi lavorativi, welfare adattato alle nuove fragilità); ridurre la rendita e la concentrazione (fisco più equo, lotta ai monopoli, regole antitrust e trasparenza nelle filiere dei dati); governare la transizione tecnologica ed ecologica senza scaricare i costi sui soliti (altrimenti la transizione diventa carburante per la reazione); investire in istituzioni che ricompongano (spazi deliberativi, lotta alla disinformazione senza paternalismi, educazione civica e digitale).
Qui, per un cristiano – e per una visione ecclesiale della storia – c’è un punto ulteriore: la critica più profonda al turbocapitalismo non è l’invidia verso il ricco, ma la difesa dell’uomo concreto. La dottrina sociale direbbe: la persona non è un mezzo, il lavoro non è una variabile, il povero non è scarto, la pace sociale non è un sottoprodotto automatico della crescita. E dunque, sì: anche il mainstream dei potenti “non è da meno” nei danni che può produrre, perché può farli con volto rispettabile, linguaggio moderato e mani pulite—ma conseguenze ugualmente corrosive.



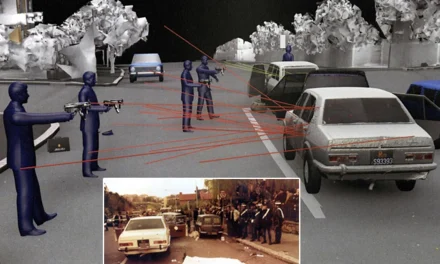















Una riflessione come poche. Condivido pienamente. Grazie! Continuate così.