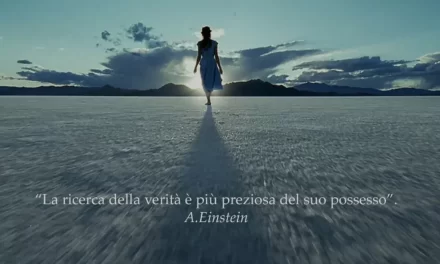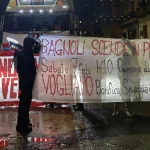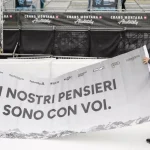Intelligenza artificiale, cyberspazio e governance globale
Il diritto delle genti, che lungo i secoli ha incarnato l’aspirazione a regolare le relazioni tra i popoli secondo principi comuni di giustizia, uguaglianza e pace, si trova oggi a confrontarsi con una sfida inedita: la rivoluzione tecnologica. L’avvento dell’intelligenza artificiale, l’espansione del cyberspazio e la progressiva digitalizzazione delle attività umane hanno aperto un orizzonte normativo del tutto nuovo, nel quale non sono più soltanto gli Stati a interagire tra loro, ma attori privati, piattaforme globali, algoritmi e sistemi autonomi che incidono direttamente sulle condizioni di vita delle persone e sul funzionamento delle istituzioni democratiche. Ne derivano interrogativi radicali circa la natura della sovranità, la titolarità della responsabilità giuridica e la protezione dei diritti fondamentali, che esigono un ripensamento del diritto delle genti come fondamento della governance globale del XXI secolo.
Se in passato tale diritto aveva disciplinato i mari, i commerci, i conflitti e la diplomazia, oggi è chiamato a estendere la propria portata a dimensioni immateriali e ubiquitarie, nelle quali la distinzione tra interno ed esterno, pubblico e privato, umano e artificiale si fa sempre più incerta. L’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti non sono infatti semplici strumenti, ma veri fattori strutturali dell’ordine internazionale, capaci di determinare nuovi equilibri di potere, di generare rischi globali e di ridefinire i parametri stessi della convivenza giuridica. In questo contesto, il diritto delle genti non può limitarsi a riprodurre i modelli classici del diritto internazionale: deve evolvere in senso costituzionale, ponendo regole comuni a tutela della dignità umana, della sicurezza collettiva e della solidarietà universale, affinché l’innovazione tecnologica diventi strumento di progresso e non di dominio.
Intelligenza artificiale e cyberspazio: la nuova frontiera del diritto delle genti
Tra le sfide più rilevanti spicca l’intelligenza artificiale, nelle sue molteplici declinazioni: sistemi predittivi, applicazioni militari, modelli linguistici generativi, algoritmi che governano flussi economici e sociali. Essa introduce un elemento di discontinuità epocale, poiché mette in discussione categorie tradizionali quali soggetto, responsabilità, imputabilità e controllo democratico. Così come in passato il diritto delle genti si era misurato con l’espansione dei commerci o con le scoperte geografiche, oggi esso deve disciplinare uno spazio non territoriale ma cognitivo, in cui decisioni automatizzate incidono direttamente sulla dignità e sui diritti delle persone. L’Unione Europea, con il progetto di AI Act, ha tentato di anticipare questa sfida elaborando un modello regolativo fondato sul principio di precauzione, sulla proporzionalità e sulla protezione dei diritti fondamentali, dando vita a quel che in dottrina è stato definito effetto Bruxelles. Tuttavia, la natura transnazionale dell’AI rende insufficiente ogni regolazione meramente regionale: i rischi di manipolazione dell’informazione, discriminazioni algoritmiche, sorveglianza di massa e impiego bellico delle tecnologie non conoscono confini e richiedono un quadro giuridico universale. In parallelo, il cyberspazio si configura come nuovo bene comune globale, spazio privo di confini fisici ma dominato da dinamiche di potere che riproducono, e talvolta amplificano, le logiche geopolitiche tradizionali. In esso non si confrontano soltanto gli Stati, ma anche attori privati dotati di un potere para-statuale: le grandi piattaforme digitali determinano regole di accesso, manipolano flussi informativi e condizionano mercati, esercitando un’influenza che sfida i meccanismi classici del diritto internazionale. La neutralità della rete, la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica e la prevenzione degli attacchi cibernetici evidenziano l’insufficienza di un approccio puramente statocentrico. Il diritto delle genti, rinnovato nell’era digitale, deve quindi affermare principi di accesso equo, di non discriminazione, di protezione della dignità e di responsabilità collettiva, ponendo le basi per un ordine digitale internazionale. In questa prospettiva, la tradizione europea della pace, con la sua insistenza sulla tutela dei diritti fondamentali, può fornire un contributo prezioso: considerare la connettività e l’accesso all’informazione non come meri strumenti economici, ma come diritti essenziali alla partecipazione democratica e alla fraternità globale.
Sovranità digitale e governance multilivello: verso un diritto pubblico dell’umanità
La rivoluzione tecnologica ha introdotto una nuova dimensione della sovranità: la sovranità digitale. Essa non si riduce al controllo delle infrastrutture informatiche e delle reti di comunicazione, ma comprende anche il dominio sui dati, sugli algoritmi, sugli standard tecnologici e sulle piattaforme che plasmano la vita politica, economica e sociale delle comunità. In questa prospettiva, la sovranità digitale diventa terreno di tensione tra la volontà degli Stati di mantenere il controllo e la realtà di un cyberspazio intrinsecamente globale, che sfugge a ogni giurisdizione esclusiva. Il diritto delle genti è quindi chiamato a ridefinire i confini di questa sovranità, evitando che essa degeneri in frammentazione normativa (splinternet) o in conflitti di giurisdizione, e orientandola invece verso un modello di corresponsabilità multilivello. La tradizione europea ha già offerto un approccio peculiare in questa direzione: il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ha elevato la tutela dei dati personali a diritto fondamentale, proiettando principi etici e giuridici oltre i confini regionali grazie al cosiddetto effetto Bruxelles. Tuttavia, la competizione globale per il controllo delle tecnologie emergenti – dall’intelligenza artificiale alle reti 5G, dalle infrastrutture cloud alla cybersicurezza – dimostra che il rischio di conflitti digitali è reale e crescente. Occorre pertanto un diritto delle genti che affermi la dimensione collettiva della sovranità digitale, intesa non come dominio esclusivo ma come capacità condivisa di garantire sicurezza, accesso equo e protezione della dignità umana nel cyberspazio. Questo implica il riconoscimento di principi comuni vincolanti a livello universale, che assicurino interoperabilità, trasparenza e solidarietà nella gestione delle tecnologie, trasformando la sovranità digitale da strumento di competizione a strumento di cooperazione. In tale prospettiva, il diritto delle genti rinnovato assume la fisionomia di un vero e proprio diritto pubblico dell’umanità, in cui i valori della dignità, della giustizia e della fraternità orientano l’innovazione tecnologica, garantendo che essa divenga fattore di pace e di progresso globale piuttosto che di dominio e disuguaglianza.