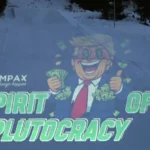Un cessate il fuoco dovrebbe avere un suono riconoscibile: non quello della vittoria, ma quello della tregua. Un rumore più raro di quanto si creda: la normalità che ricomincia, il respiro che torna lungo, la notte che non si spacca in due. A Gaza, invece, la tregua ha compiuto più di due mesi e tuttavia la morte non ha mai smesso di presentarsi al varco: a giorni alterni, a colpi brevi, come una sirena che non concede abitudine né tregua.
C’è un confine, ora, che porta un nome quasi burocratico: la “Linea Gialla”. È una linea che non assomiglia a un confine di Stato ma a una cicatrice: delimita l’area orientale dove l’esercito israeliano è trincerato e l’ovest dove la vita — e il potere di Hamas, e la sopravvivenza di due milioni di persone — tenta di riorganizzarsi tra macerie e tende. Il problema è che questa linea è spesso difficile da distinguere sul terreno: in una città devastata è facile “perdere la strada”, e un errore di direzione può diventare una sentenza.
Da una parte, i palestinesi leggono questo stillicidio come prova che Israele non stia rispettando lo spirito della tregua e che continui a trattare la vita civile come variabile secondaria. Dall’altra, l’esercito israeliano sostiene l’opposto: fuoco aperto solo in risposta a violazioni, regole d’ingaggio pensate per evitare vittime tra chi non rappresenta una minaccia, avvertimenti prima di sparare, e — come estrema risorsa — colpi diretti “alle gambe”.
Ma l’elzeviro, più della contabilità delle versioni, ascolta la grammatica della paura. E la paura, a Gaza, ha tre volti semplicissimi.
Il primo è la geografia: attraversare o avvicinarsi alla Linea Gialla, consapevolmente o per necessità, può costare la vita. E non si tratta sempre di “sconfinamenti” deliberati: a volte è un percorso sbagliato, una strada ostruita, un ritorno alla propria casa per vedere cosa ne resta. La città distrutta rende il confine un tranello.
Il secondo volto è la parentela: “essere imparentati con la persona sbagliata”. Un raid che mira a due presunti comandanti può cancellare un intero albero genealogico, dentro una casa, in una notte. Anche quando l’obiettivo è dichiarato “militare”, la famiglia allargata diventa danno collaterale con nome e cognome, e tra le vittime compaiono bambini piccolissimi.
Il terzo volto è la necessità: cercare legna da ardere perché non c’è gas, dormire in una tenda piantata sulle rovine di casa, vivere con generatori e acqua scarsa mentre l’inverno stringe. È qui che la tregua mostra il suo lato più spietato: non basta “non bombardare a tappeto” se la sopravvivenza quotidiana continua a costringere le persone a rischiare la pelle per un gesto elementare — scaldarsi, cucinare, nutrire una moglie incinta, un bambino.
I numeri, poi, inchiodano l’illusione di una pace già arrivata. Diverse ricostruzioni giornalistiche parlano di centinaia di morti palestinesi dopo l’entrata in vigore della tregua, con un’incidenza tragicamente alta di minori. E anche quando i totali variano tra fonti e giorni diversi, l’immagine non cambia: la tregua è reale, ma è fragilissima, e la violenza non è mai davvero “spenta”.
E qui sta il punto più amaro: un cessate il fuoco può diventare una forma di guerra amministrata. Non il caos di prima, ma un regime di forza “gestita”, dove l’eccezione diventa metodo: un colpo oggi, una “risposta” domani, un’operazione mirata dopodomani. La linea tra sicurezza e punizione si assottiglia, e la vita civile resta appesa alla percezione di minaccia di chi controlla il terreno e il cielo.
La Linea Gialla, allora, non è solo un confine tattico. È una metafora: di una tregua che non riesce a trasformarsi in pace, di un conflitto che si è fatto procedura, e di una popolazione che vive sotto una domanda quotidiana e disumana: che cosa, oggi, sarà considerato pericoloso? Un’auto? Un passo? Una tenda? Un cognome?
Finché la tregua non saprà produrre almeno una cosa — giorni interi senza morti, senza ambiguità, senza “incidenti” — resterà un cessate il fuoco solo sulla carta. E la carta, a Gaza, brucia facilmente.