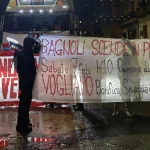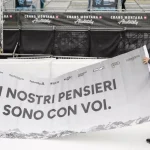Il prossimo novembre Johannesburg ospiterà il primo G20 nella storia del continente africano. Un evento che dovrebbe essere carico di significati simbolici e politici: “Solidarietà, uguaglianza e sostenibilità” è il tema scelto, quasi un manifesto di giustizia globale in un mondo segnato da fratture profonde. Ma a questa tavola mancherà un protagonista ingombrante: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato di non partecipare, inviando al suo posto il vicepresidente JD Vance.
La scelta non sorprende. Le relazioni tra Trump e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa sono logorate da mesi. A Washington, in primavera, l’incontro tra i due si era trasformato in uno scontro aperto, con Trump che rilanciava accuse infondate su un presunto “genocidio dei contadini bianchi” in Sudafrica. Un mito agitato da gruppi suprematisti per screditare le politiche di riforma agraria e di giustizia sociale volute dal governo di Pretoria. Ramaphosa ha respinto nettamente queste insinuazioni, sottolineando che la violenza nelle campagne ha radici complesse – criminalità, povertà, diseguaglianza – e non motivazioni razziali.
A peggiorare i rapporti ci hanno pensato le sanzioni unilaterali di Trump: sospensione degli aiuti economici, dazi del 30% sulle esportazioni sudafricane, e persino l’espulsione dell’ambasciatore Ebrahim Rasool dopo le sue critiche alla politica americana in Medio Oriente. Una catena di atti punitivi che rivelano quanto poco la nuova amministrazione statunitense tenga in considerazione la voce africana, soprattutto quando questa osa prendere posizione autonoma – come nel caso del sostegno sudafricano ai diritti del popolo palestinese.
Dietro queste tensioni si muovono anche attori interni sudafricani: il sindacato afrikaans Solidariteit, vicino agli ambienti più conservatori e accusato dal governo di difendere privilegi razziali, ha già programmato nuovi viaggi negli Stati Uniti per negoziare con il Dipartimento di Stato e provare a smantellare le leggi di “redress” che cercano di correggere le eredità dell’apartheid. Una diplomazia parallela che rischia di delegittimare le istituzioni democratiche di Pretoria e che Trump, con la sua narrativa populista, sembra incoraggiare.
Eppure, l’assenza del presidente americano potrebbe trasformarsi in un’opportunità. Il G20 a Johannesburg non deve misurarsi sulla presenza scenica dei leader più mediatici, ma sulla sostanza delle decisioni prese. Per la prima volta l’Africa è sede, non spettatrice: questo significa che le priorità del continente – sicurezza alimentare, giustizia climatica, riforma delle istituzioni finanziarie globali – dovranno occupare il centro del dibattito.
Il messaggio, allora, è chiaro: la sfida non è inseguire Trump o i suoi dazi, ma far valere un’agenda africana autonomadentro un’arena globale che finora ha trattato il continente come “ospite” e non come protagonista. In un mondo multipolare, l’Africa ha diritto a dettare condizioni, non solo a subirle.
La vera domanda che il G20 di Johannesburg ci pone è questa: riuscirà l’Africa a trasformare un summit simbolico in un laboratorio politico che ribalti gerarchie consolidate? O resterà prigioniera delle tensioni tra grandi potenze, con Trump che dall’esterno continuerà a strumentalizzare paura e divisioni?
La risposta dipenderà dalla capacità dei leader africani di fare fronte comune. Perché se il motto del G20 sarà davvero “solidarietà, uguaglianza e sostenibilità”, allora la prima solidarietà dovrà nascere tra i popoli del continente.