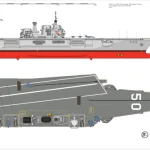Ci sono storie che il tempo non consuma, ma incancrenisce. La scomparsa di Emanuela Orlandi è una di queste: un enigma che da oltre quarant’anni non smette di interrogare l’Italia, la giustizia, le coscienze. Ogni nuova riapertura del fascicolo non somiglia a una pagina che si volta, ma a una stanza che si riapre con la stessa aria irrespirabile di sempre. Cambiano i nomi, si affinano le piste, ma resta intatto il senso di una verità trattenuta, come se qualcuno, da qualche parte, continuasse a sapere più di quanto dica.
Dal 2023 la Procura di Roma e i carabinieri hanno ripreso in mano il caso senza preclusioni, seguendo tre filoni principali: la famiglia, gli amici, un blogger. Non tre piste alternative, ma tre cerchi concentrici che ruotano attorno a un’assenza. E attorno a una domanda che non smette di tornare: perché tanti silenzi, tante paure, tante vite spezzate intorno a una ragazza di quindici anni?
La pista familiare è la più dolorosa, perché costringe a guardare dentro casa. L’attenzione su Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, morto da anni, non nasce da sospetti improvvisati ma da un dato di fatto: fu lui uno dei principali interlocutori nelle telefonate dei presunti rapitori. A rendere tutto più oscuro pesa l’ombra di molestie denunciate dalla sorella maggiore di Emanuela, Natalina, anni prima della scomparsa. Pietro Orlandi ha sempre respinto con forza l’idea di un coinvolgimento dello zio. Ma la giustizia, oggi, non può permettersi né indulgenze né rimozioni. La verità, se esiste, non risparmia nessuno.
Poi ci sono gli amici, o meglio, ciò che ne resta. Compagne di musica, di scuola, di adolescenza. Figure che, una dopo l’altra, sembrano essere state risucchiate da una spirale di paura. L’iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande segna un punto di non ritorno: non perché sia colpevole, ma perché indica che il tempo dei racconti contraddittori è finito. Accanto a lei, i nomi di Raffaella Monzi, Silvia Vetere, Pierluigi Magnesio compongono un mosaico inquietante: testimonianze rese, ritrattate, pagate a caro prezzo. Ricoveri psichiatrici, fughe all’estero, vite interrotte. Non è normale. Non lo è mai stato.
Infine, il blogger. Figura controversa, quasi simbolica di questa epoca: intermediario di voci, custode di fonti anonime, accusato di aver taciuto informazioni rilevanti. La pista dell’aborto clandestino — respinta con indignazione dalla famiglia — è forse la più violenta, perché rischia di trasformare una vittima in oggetto di una narrazione infamante. Ma anche qui la magistratura non può fermarsi alle reazioni emotive: deve distinguere tra depistaggio, fantasia, calunnia o frammenti di verità manipolati.
In tutto questo, colpisce un dato trasversale: la paura. Paura di parlare, paura di ricordare, paura di essere coinvolti. Come se attorno alla scomparsa di Emanuela si fosse formato un campo magnetico capace di deformare le vite di chi le è passato vicino. Non è solo il mistero di una ragazza scomparsa. È il mistero di un Paese che, per decenni, non è riuscito — o non ha voluto — fare i conti fino in fondo con ciò che è accaduto.
Forse la verità, se mai emergerà, non sarà consolatoria. Forse non restituirà giustizia piena. Ma una cosa è certa: Emanuela Orlandi non è un caso da archiviare, né un simbolo da usare. È una ferita aperta. E finché resterà tale, continuerà a dirci qualcosa di scomodo su di noi, sul nostro rapporto con il potere, con il silenzio, con la responsabilità.
Il tempo, da solo, non guarisce. A volte copre. E coprire, in certi casi, è solo un altro modo di far sparire.