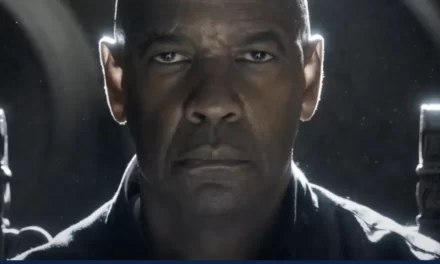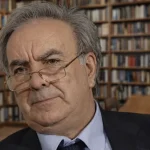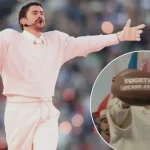Un trilione di dollari. È la cifra – letteralmente planetaria – del nuovo super-stipendio approvato a novembre 2025 per Elon Musk, l’uomo che ha trasformato Tesla in una religione tecnologica e se stesso in un simbolo della potenza individuale. Gli azionisti hanno votato a favore del pacchetto di compensi più grande della storia: se tutti gli obiettivi saranno raggiunti, Musk potrebbe incassare una somma superiore al PIL di molti Paesi.
La notizia è rimbalzata nelle borse e nei talk show con l’entusiasmo di chi scambia la grandezza economica per grandezza morale. Ma il vero interrogativo, oggi, non è quanto valga Musk. È quanto valiamo noi, come società, quando applaudiamo a un record che misura la sproporzione, non la giustizia.
Il contratto è costruito per premiare il successo: se Tesla raggiungerà traguardi inediti — otto trilioni di capitalizzazione, robotaxi diffusi, umanoidi nelle fabbriche — Musk riceverà la sua ricompensa. È la logica del merito spinta al parossismo: l’uomo-azienda che incarna la promessa del capitalismo californiano. Ma in questa narrazione, il genio solitario cancella la comunità, e l’innovazione diventa un idolo che non risponde più alla domanda sul bene comune.
C’è qualcosa di arcaico e insieme di nuovo in tutto questo. Arcaico, perché riecheggia i culti dei potenti che si facevano venerare come semi-dei. Nuovo, perché oggi la divinizzazione avviene in tempo reale, tra social network e mercati, dove il carisma vale più della regola e la ricchezza diventa spettacolo.
Il fondo sovrano norvegese e diversi investitori etici hanno votato contro, parlando di “sproporzione e rischio sistemico”. Hanno ragione. Non è solo questione di soldi, ma di equilibrio morale: cosa resta dell’idea di impresa come comunità di lavoro se il vertice guadagna milioni di volte più della base? Quale fiducia può avere un operaio di Fremont, o un ingegnere di Berlino, sapendo che la ricchezza che produce scorre tutta verso un’unica direzione?
La dottrina sociale della Chiesa insegna che l’impresa non è un feudo privato, ma una realtà sociale, orientata al bene comune. L’etica del profitto è legittima solo se accompagnata dall’etica della responsabilità. E qui la responsabilità sembra mancare. Non tanto in Musk come individuo — che, con la sua visione, ha effettivamente cambiato settori interi — ma nel sistema che lo celebra come incarnazione del successo.
Un capitalismo che affida il proprio futuro a un solo uomo, a un solo nome, è un capitalismo che ha smarrito la fiducia nella collaborazione, nella solidarietà, nella misura. È la versione iper-tecnologica di un’antica tentazione: credere che la salvezza venga dall’alto.
Certo, Elon Musk non è un mostro. È il sintomo di un mondo che non sa più distinguere il valore dal prezzo. Il suo super-stipendio non è solo un premio: è un test, una rivelazione, uno specchio. Riflette un’epoca che ama l’eroe individuale più della giustizia collettiva, e che misura il progresso non in diritti, ma in capitalizzazioni.
Alla fine, resterà una domanda semplice, ma decisiva: quanto può valere un uomo, se per pagarlo serve il mondo intero?
E quanto, invece, vale il mondo, se non sa più riconoscere la dignità di chi lo costruisce con mani, idee e speranza, senza mai finire sui titoli di borsa?