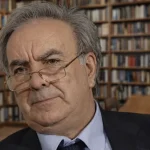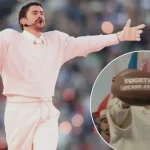Arrestato dopo l’evasione l’autore della “strage dei fornai”
C’è qualcosa di simbolico, quasi circolare, nella storia di Elia Del Grande: latitante per tredici giorni tra i boschi, i sentieri e le acque del Varesotto, fino all’arresto avvenuto ieri all’alba. È stato ritrovato lì dove tutto era cominciato: sulle rive del lago di Monate, a due passi dai luoghi che, ventisette anni fa, aveva insanguinato con un triplice omicidio che sconvolse una comunità intera.
Quella notte del 1998 resta ancora impressa nella memoria giudiziaria italiana: tre giovani uccisi con ferocia, nessuna attenuante, nessun dubbio sulla colpevolezza. Un processo lungo, una sentenza definitiva, una condanna pesantissima. E poi il lento scorrere degli anni, la pena scontata in buona parte, l’ingresso in un percorso di semilibertà: lavoro di giorno, rientro la sera. Una scelta — quella del Tribunale di Sorveglianza — fondata su relazioni che parlavano di buona condotta, di progressi, di possibilità di reinserimento.
Poi, all’improvviso, la fuga.
La cronaca giudiziaria: una fuga “annunciata”?
Il 31 ottobre Del Grande non rientra nella comunità dove era stato assegnato in regime di semilibertà. Si dilegua. In tasca qualche euro, due telefoni, una bicicletta. Sembra una fuga improvvisata, quasi infantile. Ma non lo è. Del Grande conosce ogni bosco del Varesotto, ogni stradina sterrata, ogni angolo delle rive: il territorio diventa complice, o almeno rifugio.
Le indagini ricostruiscono una latitanza minuta, quasi ascetica: bivacchi improvvisati, notti all’aperto, piccoli furti di cibo, avvistamenti incerti, un pedalò abbandonato sulle acque del Monate come un’improbabile barca di emergenza. Lo cercano carabinieri, droni, unità cinofile. Per giorni, niente.
Poi la svolta: un passante lo riconosce. Del Grande viene intercettato e bloccato senza resistenza. Finisce così una fuga che non è stata un pericolo pubblico — non ha commesso violenze né minacciato nessuno — ma che ha riportato alla luce tutte le ferite antiche del territorio.
La lettera aperta: l’accusa alla comunità che lo ospitava
Nelle ore successive all’arresto emerge un dato nuovo, inquietante e rivelatore: Del Grande aveva scritto una lettera aperta pochi giorni prima della fuga. Una lettera dura, accusatoria, contro la comunità dove svolgeva la semilibertà.
Scriveva:
«Qui non c’è nessun percorso. C’è sfiducia, incomprensione, giudizio. Non si lavora per il reinserimento; si sconta una pena in un altro modo.»
Una denuncia che non giustifica nulla, ma che rivela un disagio reale.
Un disagio che forse i responsabili non hanno colto, o non hanno saputo leggere.
La lettera diventa ora un documento processuale: perché Del Grande, anche se condannato, era inserito in un programma di recupero. E quando chi dovrebbe essere accompagnato fugge, la domanda inevitabile è: chi non lo ha accompagnato davvero?
La giustizia ferita su due fronti
Chi conosce il mondo penitenziario sa che le misure alternative non sono un premio, né un atto di fiducia ingenua. Sono uno strumento che serve a restituire persone migliori alla società. Funzionano nella maggior parte dei casi. Ma chiedono attenzione, vigilanza, competenza.
Nel caso Del Grande, qualcosa si è spezzato.
Non si è trattato di una “fuga impossibile da prevedere”, né di una leggerezza individuale isolata.
La semilibertà gli consentiva margini di movimento stretti ma reali.
Il contesto era delicatissimo: lo stesso territorio del crimine, gli stessi boschi, le stesse vie.
E poi c’è la comunità, che non lo aveva mai davvero accolto.
Una comunità che ha convissuto ventisette anni con il ricordo del delitto come con una ferita non rimarginata.
La domanda più scomoda
Il punto non è chiedersi se le misure alternative siano sbagliate. Il punto è chiedersi se erano adeguate per lui.
La recidiva non c’è stata: Del Grande non ha ferito nessuno. Ma la fuga resta un gesto di rottura grave.
Una rottura che ora pesa come una sconfitta per il sistema penitenziario e come un trauma rinnovato per il territorio.
Perché fugge chi si sente braccato, chi si sente osservato, chi sente di non avere un posto.
E forse Del Grande, nella lettera, questo lo aveva detto chiaramente — troppo chiaramente.
L’arresto come parabola
La scena finale — un uomo di mezz’età, infangato, stremato, ritrovato accanto al lago dove tutto era iniziato — ha la forza di un simbolo amaro.
Non consola. Non assolve. Non chiude nulla.
Ricorda solo che la giustizia non vive soltanto di sentenze: vive di relazioni, di vigilanza, di capacità di valutare caso per caso.
Ricorda che non tutti possono stare in semilibertà, e che fiducia e prudenza devono rimanere legate, mai separate.
Ricorda che un territorio non dimentica, e che i fantasmi del passato ritornano sempre dove non sono mai stati davvero elaborati.
E ci dice, infine, che ogni percorso rieducativo va preso sul serio — davvero sul serio — perché quando crolla, non crolla solo un protocollo.
Crolla l’idea stessa che un condannato possa cambiare vita.
Il caso Del Grande non è il fallimento della speranza.
È il richiamo a non confonderla mai con ingenuità.